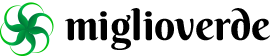“La conferenza intergovernativa della Comunità europea che partorì i criteri che ancor oggi determinano i vincoli fiscali degli Stati membri si riunì a Maastricht il 9 dicembre 1991. Che cosa succederebbe se, quasi un quarto di secolo dopo e nel tentativo di dare nuovo smalto alle regole fiscali, i governi dei paesi Ue si ritrovassero proprio a Maastricht?”. Ho riportato l’inizio di un articolo nel quale Luigi Marattin, da qualche mese componente del Nucleo Tecnico per il Coordinamento della Politica Economica (un nome da struttura burocratica sovietica che viene in comunemente sostituito da “consiglieri economici di Renzi”), cerca di giustificare un aggiornamento al rialzo dei due principali parametri fissati con il Trattato di Maastricht: quelli che impongono limiti al 3% e al 60% del Pil rispettivamente per deficit pubblico e debito.
Scrive Marattin: “Come noto, il “numero magico” del 3 per cento del rapporto deficit/Pil non viene dal cielo, ma dipende esclusivamente da due ipotesi: il desiderio di stabilizzare in rapporto debito/Pil al valore medio dell’epoca (il 60%), e l’ipotesi che la crescita nominale del Pil sia tendenzialmente pari al 5 per cento annuo; valore, quest’ultimo, risultante da un’ipotesi di inflazione al 2 per cento come da mandato Bce, e una crescita reale del 3 per cento. Vediamo che cosa accadrebbe se questi valori macroeconomici fossero aggiornati a quello che poi è accaduto dall’introduzione dell’euro a oggi. I valori medi di inflazione e tasso di crescita reali dell’Eurozona dal 1996 al 2011 (escludendo l’outlier del 2009) sono stati pari a, rispettivamente, 2% e 2,3%; la crescita nominale è stata quindi pari al 4,3%, contro il 5% deciso nel 1991. La revisione del primo pilastro alla base degli attuali vincoli, quindi, condurrebbe a un limite al deficit più stringente dell’attuale 3% (circa il 2,6%). Per un dato deficit nominale, infatti, un minore tasso di crescita del Pil fa alzare il rapporto e quindi richiede una soglia più stringente. Ma a essere cambiato, in questi vent’anni, è anche lo stock medio del debito pubblico nell’area Euro, che invece spinge nell’altra direzione. Mentre all’inizio degli anni Novanta esso era pari al 60% del Pil, il valore del 2013 è 90,9%. Inferiore a quello di altre aree valutarie quali Stati Uniti (122,8%), Regno Unito (92,5%) e Giappone (236%), sebbene la Uem non sia un’unione fiscale come quelle economie”.
A parte che i numeri sui debiti al 2013 sono diversi da quelli riportati dal FMI (ma non è qualche punto in più o in meno che conta nel ragionamento), fin qui nulla da obiettare. Lo stesso Marattin, tra l’altro, riconosce che adeguare al rialzo l’obiettivo del debito (quindi quello del deficit) si presta a obiezioni.
Scrive infatti: “Si potrebbe tuttavia obiettare che utilizzare la media aggiornata del debito (anziché quella, inferiore, di un quarto di secolo fa) equivarrebbe ad adeguare i propri obiettivi futuri a una performance deludente. È come se una squadra di atletica leggera composta da 18 membri il cui tempo medio di percorrenza dei 100 metri fosse stato in passato 10 secondi (e quindi tale fosse stata la soglia fissata per far parte della squadra) improvvisamente adeguasse la soglia a 15 secondi, perché tale ora è la nuova media dei componenti del gruppo. Non stiamo forse compromettendo la nostra capacità di migliorarci? L’argomento non è privo di un certo fascino. Se gli stati membri dell’Unione monetaria vent’anni fa riuscivano ad avere un rapporto debito/Pil al 60%, perché non possono riuscirci anche ora e in futuro?”
E qui cerca di giustificare quella revisione al rialzo: “Tornando alla metafora, si può rispondere che da allora a oggi ci sono stati infortuni pesanti che hanno (forse irrimediabilmente) danneggiato le articolazioni e i muscoli non soltanto degli atleti della squadra, ma di tutte le formazioni iscritte al torneo. Pertanto può essere autorizzata una revisione al rialzo degli standard di ammissione. Anche perché, nonostante tutto, la nuova media di 15 secondi è ancora la più bassa tra tutte le squadre iscritte al torneo. Non è azzardato affermare che la globalizzazione negli anni Novanta, la Grande crisi negli anni Duemila e l’invecchiamento demografico abbiano rappresentato tre “infortuni muscolari” piuttosto rilevanti per gli “atleti” dell’eurozona e per tutte le economie concorrenti. La globalizzazione ha comportato un permanente sconvolgimento delle capacità competitive dei sistemi economici occidentali, con un conseguente aumento di domanda di protezione (costosa per le finanze pubbliche) per i fattori produttivi che durante o alla fine del percorso di ri-aggiustamento si sono trovati spiazzati. La Grande crisi ha impattato ancor più direttamente sui rapporti debito/Pil: sul numeratore ha influito la necessità di assorbire il debito privato in eccesso (causa ultima della crisi) e sul denominatore il calo del livello di attività economica strutturale dopo anni di sottoutilizzazione dei fattori produttivi. L’invecchiamento della popolazione, infine, ha posto in tutto il mondo una consistente pressione al rialzo sul costo dei sistemi di protezione sociale e sanitaria.
Il semplice aggiornamento dei dati su crescita nominale e debito ci riconsegna matematicamente un limite al deficit pari al 3,9%. Per l’Italia, ad esempio, si tratterebbe di circa 15 miliardi annui di spazio in più per aumentare la spesa o, preferibilmente, ridurre la pressione fiscale”.
In sostanza, i tre “infortuni” di cui parla Marattin hanno reso meno competitive le economie occidentali, ma la soluzione non sembra quella di adeguare il ricorso al debito alle nuove condizioni, bensì cercare di continuare a vivere a condizioni non compatibili con la ricchezza reale che si riesce a produrre. Se questo è il modo di affrontare la questione, ci saranno sempre “infortuni” a cui aggrapparsi per giustificare ulteriori ricorsi al debito. Il problema è che non basta stabilire con un trattato che il debito può essere al 90, al 100 o al 200 per cento del Pil perché esso sia sostenibile.
Negli ultimi anni le banche centrali degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Giappone hanno sostanzialmente monetizzato una parte consistente del nuovo debito emesso da quegli Stati. In via più indiretta, anche la politica monetaria della BCE ha consentito agli Stati di ridurre l’onere sostenuto per indebitarsi. Adesso si vorrebbe che emulasse in tutto e per tutto Fed, BoE e BoJ, e probabilmente finirà per farlo nei prossimi mesi.
 Ma un sistema in cui il debito aumenta più o meno illimitatamente arriva a un punto nel quale è sostenibile solo se i tassi di interesse sono strutturalmente azzerati, ossia se viene, esplicitamente o implicitamente, monetizzato. Supporre che ciò non crei mai una crisi di fiducia è quanto meno azzardato, perché presuppone credere che sia possibile prendere a prestito all’infinito ricchezza dal futuro. Un futuro in cui gli “infortuni” di cui parla Marattin potrebbero anche essere più gravi.
Ma un sistema in cui il debito aumenta più o meno illimitatamente arriva a un punto nel quale è sostenibile solo se i tassi di interesse sono strutturalmente azzerati, ossia se viene, esplicitamente o implicitamente, monetizzato. Supporre che ciò non crei mai una crisi di fiducia è quanto meno azzardato, perché presuppone credere che sia possibile prendere a prestito all’infinito ricchezza dal futuro. Un futuro in cui gli “infortuni” di cui parla Marattin potrebbero anche essere più gravi.
Marattin vorrebbe comunque porre dei limiti (non so quanto credibili, visto che quelli di Maastricht non lo sono stati), rendendo più stringente il Fiscal Compact, pur con il nuovo limite di riportare il debito al 90% del Pil e non al 60. Aggiungerebbe, poi, una transizione verso gli Eurobond, un classico dei propugnatori degli Stati Uniti d’Europa. Gira e rigira, si arriva sempre alla mutualizzazione dei debiti, invocando il senso di “solidarietà” tra europei. Però senza “sbragare” sulla spesa, almeno nelle intenzioni.
“Chi scrive è fermamente convinto che il rilancio di un sistema economico e in particolare dell’area euro non possa e non debba fondarsi su aumenti di spesa pubblica, ma che debba piuttosto incentrarsi su profonde riforme strutturali sul lato dell’offerta. Specialmente nel nostro Paese, in cui alle tre funzioni fondamentali della spesa pubblica (allocazione delle risorse, stabilizzazione macroeconomica e distribuzione del reddito) per troppo tempo se n’è aggiunta una quarta, vale a dire l’acquisto e l’inefficiente mantenimento del consenso politico”.
Peccato che finora Renzi non abbia ridimensionato la spesa pubblica: aveva esordito dichiarando non sufficientemente ambiziosi gli obiettivi indicati dall’allora commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, ma ha finito per sbarazzarsi di Cottarelli e lasciare indietro proprio i tagli di spesa nella legge di stabilità. Alla fine, la riduzione della spesa e le privatizzazioni sono i grandi assenti (anche) nel 2014.
Aggiunge poi Marattin: “Tuttavia nessun economista può seriamente negare che il contesto macroeconomico europeo, soprattutto se confrontato con quello di altre aree valutarie, necessiti ormai – oltre che di riforme strutturali per innalzare la competitività e completare il mercato unico – di una massiccia iniezione di domanda aggregata e di un percorso condiviso e responsabile verso maggiore integrazione fiscale”.
Un spruzzata di keynesismo alla fine non manca mai. Interessante, a mio avviso, il fatto che Marattin (al pari di tanti altri) non ritenga neppure necessario fornire argomentazioni a sostegno della sua proposta. In buona sostanza, dà per scontato che “nessun economista può seriamente negare” che L’Area euro necessiti di “una massiccia iniezione di domanda aggregata e di un percorso condiviso e responsabile verso maggiore integrazione fiscale”. Io credo, invece, che utilizzare una formula del genere sia tutt’altro che serio. La domanda non è mai carente in termini assoluti, non fosse altro per il fatto che i desideri dell’uomo sono tendenzialmente infiniti e che l’economia non esisterebbe neppure se non fosse necessario affrontare il concetto di scarsità.
Ciò che è carente è la domanda per determinati beni e servizi a determinate condizioni. L’interventismo volto a “sostenere” la domanda non fa altro che tentare di manipolare il mercato secondo i desiderata di chi governa.
Gli effetti di 80 anni di keynesismo più o meno intensamente e fedelmente praticato hanno generato un welfare insostenibilmente oberato di debiti. Non è aumentando politicamente soglie di sostenibilità o mutualizzandoli che si risolvono i problemi. Al più si rimandano ancora in avanti, con l’unica speranza, peraltro molto cinica, che a far fronte al disastro sia una generazione futura.
La cosa a mio parere drammatica è che queste cose le sostengano economisti e presidenti del Consiglio non ancora quarantenni.