La Grande Guerra fu l’occasione che la monarchia cercava per mettere alla prova la forza e l’unità del paese; i retori nazionalisti, per nobilitarne gli scopi e le ambizioni, la presentarono come “quarta guerra di indipendenza”. In realtà fu una guerra d’aggressione e di conquista, cominciata per la liberazione delle terre irredente di Trento e Trieste e conclusasi con l’occupazione del Tirolo austriaco e della Dalmazia slava.
L’Austria era nostra alleata e avrebbe ceduto gli ultimi territori italiani che ancora occupava senza colpo ferire. Ma la guerra non poteva essere evitata perché rientrava nelle ambizioni di una nazione che nell’imminente carneficina vedeva l’occasione di essere ammessa nel club esclusivo delle grandi potenze e perché vedeva in essa il solo modo di unire gli italiani, se non da vivi almeno da morti. Nel tributo di sangue e di sacrificio Nord e Sud si sarebbero finalmente sentiti uniti. Alberto Moravia scriverà, invece, che quella guerra esaltata come l’ultima del Risorgimento, “fu uno scoppio di nevrosi collettiva le cui cause andrebbero piuttosto studiate dagli psicanalisti che dagli storici” e che manco ad essa “il contrasto fra ragione e follia, tra verità e menzogna, fra civiltà e barbarie che nella seconda guerra mondiale, bene o male, finì per illuminare le tenebre del massacro”.
L’esercito era la pupilla del re, ma dopo l’unità gli venne affidato un nuovo difficile compito: quello di forgiare la nazione. Gli italiani, divisi per regioni, abitudini, storie e culture avrebbero ricevuto nell’esercito il battesimo della comune identità. Non la scuola, negata al popolo, ma la leva militare – che non faceva distinzioni tra nobili e plebei, colti e illetterati, della durata di tre anni, poi ridotti a due – avrebbe fatto da mastice unitario. Piemontesi e calabresi, lombardi e romani, siciliani e toscani avrebbero ricevuto la medesima educazione e sarebbero finalmente diventatati italiani. La guerra formava il popolo, ne rivelava le qualità migliori. Ne erano convinti Crispi e Mussolini. La guerra sarà fatale ad entrambi. Nulla come la logorante attesa della trincea, il pericolo, l’idea della morte, il comune destino avrebbero rafforzato lo spirito di solidarietà e di fratellanza. L’Italia si sarebbe scoperta unita e concorde grazie al bagno di sangue. Ma il calcolo d’ambizione si rivelò completamente errato. Non solo l’Italia, dopo Caporetto, rischiò di essere travolta e invasa se non fossero accorse in suo aiuto sul Piave le divisioni francesi e inglesi, ma la guerra acuì il contrasto tra Nord e Sud e il risentimento fra i due capi della penisola. I soldati meridionali, di fronte all’ignavia degli ufficiali, e non essendo abituati alla leva militare, disertavano in massa e accusavano il Nord di aver voluto la guerra per permettere agli industriali settentrionale di arricchirsi con le commesse militari e sulla pelle dei meridionali. Gli ufficiali, quasi tutti di origine piemontese, alteri e spocchiosi, venivano tutti dall’aristocrazia subalpina. Non combattevano per la nazione, ma per il re, al grido: “Avanti Savoia!”.
La guerra del ’15, che doveva cementare lo spirito della nazione, accelerò invece la crisi dello Stato dinastico e dei partiti tradizionali, fomentò il caos e la guerra civile del dopoguerra, preparò e favorì l’avvento del fascismo. Mancò a quella guerra la spinta ideale che è alla base dello spirito di sacrificio. Il generale Luigi Cadorna, piemontese, capo di Stato Maggiore, non si decideva a sferrare l’attacco. In compenso si distinse nelle decimazioni che colpivano i disertori e i vigliacchi, secondo il suo personalissimo metro di giudizio al quale, a ben vedere, non sarebbe scampato nemmeno lui. Dopo Caporetto Cadorna venne destituito, per manifesta incapacità e crudeltà. Al suo posto venne nominato il generale Armando Diaz, napoletano di ascendenze spagnole. Diaz era un coscienzioso burocrate, aveva fatto una lenta carriera. Nessuno lo conosceva. Il Nord Italia gli era perfettamente sconosciuto. Quando gli annunciarono la vittoria di Vittorio Veneto, si fece portare la carta geografica ed esclamò col suo migliore accento partenopeo: “Do’ cazzo sta Vittorio Veneto!”. Alla fine del conflitto Diaz pretese e ottenne il titolo di duca della vittoria con relativo vitalizio.
A Luigi Cadorna, il macellaio, Milano ha intitolato il piazzale davanti alla stazione Nord. Qualcuno mi sa dire perché?
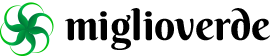



E’ pacifico che l’Italia non diventerà mai una nazione.
Troppo grandi sono le differenze culturali e linguistiche dei popoli che la compongono.
Ricordo che uno dei pochi( Giovanni Falcone ) che hanno sacrificato la vita per cercare di raddrizzare la baracca , ha scritto nel suo libro “Cose di cosa nostra” : “la mafia è nel nostro DNA”.
Chiarendo che per NOSTRO non intendeva l’intera Italia.
Si conferma che lo stato italiota è e rimarrà uno stato senza diventare mai una nazione ed i suoi abitanti: una somma di popoli costretti, da farabutti, a stare insieme ma ciò non costituisce il popolo italiano.
Ipocrisia, conformismo nazional-patriottici.
Il solito italiume filogovernativo e paraculo.
L’ignoranza del popolo di sudditi, la malafede storica delle scuole.
Un bugliolone in cui tutti rimestano appassionatamente.