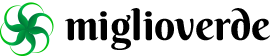di ANDREA ZAMBELLI*
di ANDREA ZAMBELLI*
La Republika Srpska non sarà mai indipendente, e i periodici annunci in tal senso da parte di Milorad Dodik vanno presi per quello che sono: solo vuote minacce. E’ la tesi dell’ultimo articolo di James Ker-Lindsay, professore alla LSE di Londra ed esperto di secessionismo e Balcani (qui il testo, in inglese).
Secondo l’accademico britannico sono molteplici gli impedimenti giuridici e legali che si frappongono tra il dire e il fare dell’uomo forte di Banja Luka. In linea generale, nel diritto internazionale del dopoguerra e in particolare al di fuori del processo di decolonizzazione, la norma dell’integrità territoriale degli Stati si è consolidata ben al di sopra del principio di autodeterminazione, comunque inteso.
Nel caso bosniaco in particolare, l’integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina è protetta anche da periodiche risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu, l’ultima solo del dicembre 2015. E se è evidente che Stati Uniti ed Unione europea si opporrebbero ad una dichiarazione d’indipendenza della Republika Srpska, nonostanti vari allarmi nulla suggerisce che la Russia di Putin farebbe diversamente, posto che Mosca continua a sostenere “l’integrità territoriale e la sovranità” della Bosnia ed Erzegovina in tutte le dichiarazioni del Peace Implementation Council.
Casi quali il veto alla risoluzione Onu su Srebrenica sembrano volti più ad assicurarsi la gratitudine della Serbia che non a minare la sovranità bosniaca. Né ci sarebbe poi tanto che Mosca potrebbe ottenere dal sostenere il secessionismo serbobosniaco: già gli staterelli de facto che la Russia sostiene nel Caucaso sono stati incapaci di garantirsi un qualsiasi sostanziale riconoscimento internazionale, e il governo russo dovrebbe ben cercare di evitare un ulteriore fallimento.
La Russia, che non ha confini di terra con la Republika Srpska, potrebbe poi fare ben poco in concreto per garantire la sopravvivenza nel medio termine di uno staterello secessionista nei Balcani, mostrando ancor di più la propria debolezza ed isolamento. «La Russia ha già perso nei Balcani. Non ha ragione di dimostrarlo», conclude Ker-Lindsay.
Gli eventuali precedenti citati dalla leadership secessionista di Banja Luka sono diversi, a partire dal Kosovo. Ma il caso della ex provincia serba dimostra proprio come un governo secessionista abbia bisogno di forti alleati: il relativo successo nel riconoscimento internazionale del Kosovo sta proprio nel sostegno fornitogli dagli Usa e dai principali Stati membri Ue.
Anche l’opinione della Corte internazionale di giustizia del 2010, talvolta citata, va in realtà a sfavore della Republika Srpska: benchè infatti essa affermi che in linea generale le dichiarazioni d’indipendenza non sono vietate, la Corte continua affermando che tale passo possa essere legalmente proibite da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu, ciò che per la Bosnia avviene a partire dalla risoluzione 787 (1992).
Altri casi a cui la Republika Srpska fa talvolta riferimento sono Scozia e Catalogna. Le due regioni a velleità secessioniste dell’Europa occidentale, in realtà, dimostrano proprio come sia fondamentale per un processo secessionista ottenere il consenso del proprio governo centrale (caso scozzese) e come, in caso contrario, ai secessionisti restino ben poche armi, come mostra il caso catalano.
La Crimea, infine, è stata citata come modello negli ultimi due anni a Banja Luka. Ma il caso crimeano è forse il più lontano dai sogni serbobosniaci: un referendum considerato una “farsa”, l’universale condanna e non-riconoscimento (incarnata dalla risoluzione 68/262/2014 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite) e infine l’annessione da parte di uno Stato confinante.
A differenza di Mosca, la Serbia non riconoscerebbe nè sarebbe interessata ad annettersi una Republika Srpska secessionista, scrive Ker-Lindsay. Già, perché per essere uno Stato secessionista di relativo successo, è necessario avere uno Stato-patrono, magari etnicamente vicino, che fornisca accesso a tutti quei servizi di base della vita internazionale (import/export, aeroporti, dogane, visti, investimenti, rimesse, aiuto allo sviluppo) da cui l’isolamento e il non-riconoscimento escludono gli Stati di fatto.
Così è con la Turchia per Cipro Nord, l’Armenia per il Nagorno Karabakh, la Russia per Abkhazia, Sud Ossezia, Transnistria e Donbass, e al contrario è forse per questo che il Kurdistan iracheno si è ben guardato finora dal dichiarare la propria indipendenza. Se la Republika Srpska volesse davvero tentare la strada dell’indipendenza unilaterale, avrebbe assoluto bisogno del sostegno della Serbia.
Un sostegno che Belgrado avrebbe potuto fornirle forse negli anni ’90, ma non più oggi: dopo aver speso anni a combattere con le armi del diritto internazionale contro il riconoscimento del Kosovo secessionista, e quindi ad impegnarsi in complicati e dolorosi negoziati con il Kosovo stesso per garantirsi un processo di adesione all’Unione europea.
Dall’altra parte, le relazioni tra Bosnia e Serbia sono migliorate negli ultimi anni, e l’attuale leadership di Belgrado non ha mai nascosto la propria insofferenza rispetto alla leadership serbo-bosniaca di Banja Luka. Così, conclude Ker-Lindsay, se la Serbia potrebbe non essere in grado di fermare una leadership serbo-bosniaca dal puntare alla secessione (come fu nel 1983 per Ankara con i turco-ciprioti), una Republika Srpska indipendentista resterebbe insostenibile senza il completo sostegno di Belgrado.
Che fare, quindi, con le ripetute minacce di Milorad Dodik di ricorrere a referendum e rincorrere la strada dell’indipendenza? Secondo Ker-Lindsay, basterebbe non prenderle troppo sul serio. Così fu, d’altronde, per il referendum con cui a inizio 2012 i serbi del Kosovo si pronunciarono al 99,7% contro il passaggio sotto la sovranità di Pristina.
Solo un anno dopo, i governi di Serbia e Kosovo si accordavano a Bruxelles per trasferire l’autorità sul nord del Kosovo alle autorità di Pristina. Tale referendum, condannato e dimenticato, non ebbe alcun impatto sostanziale. Ugualmente, in caso di dichiarazione di indipendenza della Republika Srpska, nessun effetto pratico ne decalerebbe.
Tale dichiarazione sarebbe presto dichiarata nulla dal governo bosniaco e dall’Alto Rappresentante internazionale. Se davvero il governo di Banja Luka volesse andare avanti, si troverebbe a far fronte alla chiusura delle frontiere da parte di Croazia, Serbia e Montenegro, oltre a ritrovarsi separata in due tronconi, per via del distretto di Brčko.
«Uno Stato secessionista serbobosniaco, tagliato fuori dal mondo esterno, e in due parti separate tra loro, dovrebbe far fronte a sfide enormi. L’opinione generale degli osservatori è che sarebbe insostenibile», conlude Ker-Lindsay. Una strategia di secessione light, con il boicottaggio delle istituzioni centrali da parte dei rappresentati della Srpska, non dovrebbe essere messa in grado di causare la paralisi della Bosnia ed Erzegovina.
Secondo la dottrina legale dello stato di necessità, applicata a Cipro dal 1960, le istituzioni comuni dovrebbero poter funzionare (con i dovuti accorgimenti) anche in mancanza di cooperazione della Republika Srpska. Tale incapacità di bloccare le istituzioni statali, assieme alla prospettiva di isolamento, dovrebbe essere sufficiente a convincere la leadership serbobosniaca a tornare al tavolo delle trattative.
Insomma, secondo Ker-Lindsay, un tentativo di secessione della Republika Srpska sarebbe destinato al fallimento, e anche in caso esso avvenisse potrebbe essere contrastato con mezzi non violenti. «Nel caso (estremamente improbabile) che la Republika Srpska cerchi di secedere, la Bosnia dovrebbe senza dubbio far fronte ad un periodo di grave crisi. Tuttavia, non dovrebbe necessariamente far fronte al ritorno alle armi».
* Articolo tratto da http://www.eastjournal.net/