di MARCO BASSANI
In questo brevissimo scritto sosterrò che l’unificazione politica irrealizzabile di un conglomerato geografico chiamato Italia ha condotto le due “sezioni” del paese verso sentimenti improntati ad una generale inimicizia. Si tratta dell’opposto degli esiti che Derrida, nel famoso saggio del 1994, immaginava potessero essere il risultato di azioni politiche. Un sentimento di disponibilità e apertura verso l’altro non poteva nascere da una conquista militare, seguita dalla repressione violentissima della guerriglia popolare (brigantaggio) e dall’asservimento para-coloniale del Mezzogiorno nei primi decenni di vita unitaria.
D’altro canto, l’oggettivo collocamento in una posizione di veri e propri “schiavi fiscali”, di una cospicua parte dei cittadini delle regioni settentrionali nell’ultimo mezzo secolo, ormai percepito come un dato perenne della politica economica romana, non aiuta certo a mitigare l’inimicizia. Si tratta di un’avversione che non ha nulla di naturale, ma appare quasi il risultato naturale e inevitabile dell’azione dello Stato italiano, ossia è una inimicizia creata dalla politica.
Setacciare le differenze culturali in Europa è operazione abbastanza agevole. Tuttavia, occorre muovere da un dato di fatto: l’area europea è nell’intero pianeta quella maggiormente omogenea dal punto di vista culturale. Aristotele e Gesù Cristo hanno permeato a fondo la cultura di ogni singola regione d’Europa, al punto che le declinazioni del cristianesimo e delle lingue sono solo differenze di facciata.
Fatta salva l’omogeneità fondamentale della cultura europea, le aree italiche sono sempre state caratterizzate dalla coesistenza di unità politiche, economiche e socio-culturali profondamente diverse, al punto che si potrebbero considerare le due aree in parola fra le meno omogenee dell’intera Europa.
Fin dal dodicesimo secolo quell’area che va dalla Toscana alle Alpi è stata il centro nevralgico di un fenomeno di modernizzazione economica che, ad avviso di innumerevoli autori, rappresenta la vera genesi del capitalismo. La nascita di una figura destinata a mandare in frantumi l’universo medievale, ossia il borghese, avviene in un’area che coincide più o meno con una striscia di territorio che va da Firenze ad Anversa. Oltre all’inclinazione verso il mercato e le professioni liberali, l’area centro-settentrionale è nota come quella dei comuni, delle città che si costruiscono un libero spazio di autogoverno. Lombardo era il termine riservato grosso modo a tutti gli abitanti dell’area fra Firenze e le Alpi nel corso del Medioevo ed è un aggettivo associato ancor oggi ai creditori migliori (Lombard rate), ossia a coloro che danno garanzie assolute di solvibilità. Tutti gli strumenti tecnici e “ideologici” dell’economia di mercato sono stati prodotti in un periodo, quello del Medio Evo maturo, nel quale fra gli Appennini e le Alpi si concentrava una ricchezza e una capacità di crearne di nuova senza precedenti. Fra parentesi questo dato di fatto è considerato da molti la maggiore confutazione in sé e per sé della nota tesi di Max Weber sulle origini calviniste del capitalismo. In breve, se l’antichità può essere racchiusa simbolicamente fra Atene e Roma, la valle del Po, con le sue diramazioni lotaringe e toscane rappresenta il centro nevralgico della modernità: non è solo in Occidente, ma è una vera e propria condizione di pensabilità dell’Occidente nel suo dipanarsi storico.
 Lo stesso Marx, in uno dei suoi numerosissimi peana alla borghesia, riconosce la grandezza e la gloria dell’età comunale. In fondo, proprio l’adozione del termine borghese è un omaggio alla rivoluzione delle città, ossia dell’insorgenza della politica e della separazione con il contado. È la frattura dalla quale tutto il nostro mondo ha avuto origine e le lande meridionali di questo paese non erano, in quel caso, che spettatrici disinteressate.
Lo stesso Marx, in uno dei suoi numerosissimi peana alla borghesia, riconosce la grandezza e la gloria dell’età comunale. In fondo, proprio l’adozione del termine borghese è un omaggio alla rivoluzione delle città, ossia dell’insorgenza della politica e della separazione con il contado. È la frattura dalla quale tutto il nostro mondo ha avuto origine e le lande meridionali di questo paese non erano, in quel caso, che spettatrici disinteressate.
Nel centro sud si crearono infatti regni di origine feudale, facilitate dalle caratteristiche del territorio (tendenzialmente agricolo). Come scriveva Gianfranco Miglio nel suo ultimo saggio, L’Asino di Buridano del 1999, “l’habitat del feudalesimo mediterraneo è caratterizzato dalla concentrazione delle curtes e delle casae coloniciae disperse tardo romane, in villaggi accentrati e forti tifati collocati su sommità di colli o su speroni di versante.” E questo “feudalesimo mediterraneo” è la principale causa di separatezza storica fra l’area lombarda e il Centro-sud.
Va detto però, che queste diversità non hanno mai dato luogo a nessun genere di contrasto prima dell’unificazione. Ognuno viveva la sua plurisecolare storia istituzionale in silenzio. In verità, se l’amicizia deve poter nascere da diversi, secondo Derrida, le due aree del Paese avevano un enorme grado di diversità sul quale si sarebbe potuto lavorare con conoscenza e rispetto reciproci. Così non fu. E uno dei più lucidi indagatori dei guasti dell’unità, Luigi Sturzo, riconosceva con franchezza, a quarant’anni dall’unificazione, che una sola politica economica non poteva tenere insieme le due parti del paese: “Parliamoci chiaro: nord e sud sono due termini irriducibili e inconciliabili”. “Non siamo pupilli – affermava – non abbiamo bisogno della tutela interessata dei fratelli del nord … seguiremo ognuno la nostra via economica, amministrativa e morale nell’esplicazione della nostra vita”.
Prima dell’unità, se la minuscola élite intellettuale italica che faceva parte della repubblica delle lettere e non riconosceva confini né nazionali, né regionali, e dialogava tanto con Genovesi, Verri e Beccaria, quanto con Jefferson e Voltaire, il popolo semplicemente non si conosceva. Cento anni dopo i drammi dell’emigrazione interna sono stati mirabilmente narrati in Rocco e i suoi fratelli da Visconti. Il popolo incominciava a conoscersi ex abrupto e non pare che i sentimenti amicali fossero fin da subito sovrabbondanti.
Ogni paese si costruisce tramutando un dialetto in lingua, ossia dotandosi di passaporto, esercito e istituzioni politiche. Ma la vera costruzione nazionale abbisogna di una storiografia, di santini e martirologi per il volgo. Come diceva Luhmann, “con la proclamazione dello Stato sovrano, in particolare nella Francia della seconda metà del XVI secolo, si mettono al lavoro gli storici. Il presente ha bisogno di un passato che gli si adatti”. In estrema sintesi, lo Stato forgia, o nel caso italiano tenta di forgiare, la nazione, e quindi cruciali sono soldati, giuristi e storici di corte.
 Per fare solo due esempi, in Francia è deciso che il nocciolo di un millennio di vita nazionale deve essere il 1789, al punto che ai bambini viene insegnato che dopo la creazione non vi è stato nulla di maggiormente significativo nella storia umana. In America il baricentro storico è invece cambiato: se un tempo la Rivoluzione e la Dichiarazione d’Indipendenza erano il cuore dell’esperienza americana di autogoverno, oggi è la guerra civile e il Gettysburg Address con la lincolniana esaltazione di democrazia e uguaglianza, a riassumere ogni “americanismo” accettabile.
Per fare solo due esempi, in Francia è deciso che il nocciolo di un millennio di vita nazionale deve essere il 1789, al punto che ai bambini viene insegnato che dopo la creazione non vi è stato nulla di maggiormente significativo nella storia umana. In America il baricentro storico è invece cambiato: se un tempo la Rivoluzione e la Dichiarazione d’Indipendenza erano il cuore dell’esperienza americana di autogoverno, oggi è la guerra civile e il Gettysburg Address con la lincolniana esaltazione di democrazia e uguaglianza, a riassumere ogni “americanismo” accettabile.
Gli storici italiani hanno deciso di considerare il Risorgimento “nazionale” il cuore di tutta la vicenda politica delle aree italiche. Il processo di unificazione nazionale (o meglio la conquista regia sotto la regia ideale del repubblicanesimo mazziniano) è diventato più rilevante del Rinascimento, della storia della Serenissima, delle glorie fiorentine, milanesi e, comunque, di qualunque accadimento precedente. Da Gramsci a Rosario Romeo la categoria della modernizzazione spiega e copre tutto: dalla guerra contro le plebi del sud, al corso forzoso, alle tasse sul macinato, alle guerre.
Se il Risorgimento è il cuore della nostra storia occorre effettivamente andare agli albori e scavare per scoprirne l’inizio. Fu un importante storico comunista non ortodosso, Armando Saitta, a individuare nel “celebre concorso” promosso dall’amministrazione franco-lombarda nel 1796 un orizzonte politico dal quale tutto partì. Nel 1964 Saitta raccolse i testi che aveva rinvenuto del concorso su Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d’Italia? e intitolò l’antologia Alle origini del Risorgimento. Il triennio giacobino diventa allora un momento davvero cruciale. L’arrivo di Napoleone in Lombardia – che a Sant’Elena disse “io mi sento toscano o italiano piuttosto che corso” – fu l’innesco di una serie di mutamenti che fecero lentamente slittare la Lombardia da una appartenenza acclarata all’Europa fredda, al calore dei problemi mediterranei.
Il concorso fu vinto da Melchiorre Gioia, il quale disse ai francesi ciò che essi volevano sentirsi dire, ossia che una sola Repubblica d’Italia unita ed indivisibile avrebbe potuto prosperare, ma ciò che davvero colpisce dei saggi del 1796 è che quasi tutti volevano una confederazione, e soprattutto nessuno aveva un’idea geografica dell’Italia che comprendesse il Meridione. Essenzialmente la visione dell’Italia non andava oltre Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia.
L’unificazione appariva davvero complicata a Giovanni Ranza giacché “l’Italia, tutto al contrario della Francia, è divisa in molti Stati da parecchi secoli; Stati diversi di costumi, di massime, di dialetto, d’interessi; Stati che nutrono (mi rincresce dirlo!) vicendevolmente un’avversione gli uni degli altri. Ora il voler unire questi Stati ad un tratto con una rigenerazione politica in un solo Governo, in un solo Stato, con una sola costituzione, è lo stesso che cercare il moto perpetuo e la pietra filosofale (Vera idea del federalismo italiano, 1796).
Dopo l’unificazione forse solo il progetto di Marco Minghetti sull’amministrazione pubblica avrebbe potuto suturare le ferite che si stavano creando.
 In ogni caso, il Mezzogiorno fu annesso al Regno d’Italia manu militari e fu governato non solo con pugno di ferro, ma in modo “coloniale”. Le vere e proprie unità combattenti che volevano restaurare la monarchia furono subito combattute duramente in una guerra civile promossa dal governo invasore contro una parte del popolo che causò decine di migliaia di morti. Nel 1863 Giuseppe Massari decise di creare una Commissione parlamentare, intesa a studiare il caso del Mezzogiorno e da allora, dopo il ferro e il sangue si sviluppò qualcosa che arreca fino ad oggi ancor più nocumento al Sud. Il Meridione fu infatti oggetto di decine di interrogazioni, studi, inchieste, interventi speciali.
In ogni caso, il Mezzogiorno fu annesso al Regno d’Italia manu militari e fu governato non solo con pugno di ferro, ma in modo “coloniale”. Le vere e proprie unità combattenti che volevano restaurare la monarchia furono subito combattute duramente in una guerra civile promossa dal governo invasore contro una parte del popolo che causò decine di migliaia di morti. Nel 1863 Giuseppe Massari decise di creare una Commissione parlamentare, intesa a studiare il caso del Mezzogiorno e da allora, dopo il ferro e il sangue si sviluppò qualcosa che arreca fino ad oggi ancor più nocumento al Sud. Il Meridione fu infatti oggetto di decine di interrogazioni, studi, inchieste, interventi speciali.
Si assiste a una pletora di progetti di puro paternalismo, a partire dalle inchieste parlamentari. Il Meridione diventa un’area arretrata nei confronti della quale è lecito sperimentare qualunque politica economica, ovviamente fallimentare, che non fa altro che aumentare il divario con il Settentrione. Il tentativo di industrializzazione del Sud, che prosegue imperturbabilmente da oltre un secolo, è la vera Caporetto civile italiana: ha distrutto le ricchezze del nord rendendo intere popolazioni totalmente parassitarie, in cerca di misere paghe pubbliche.
L’abbraccio paternalista e assistenzialista si è rivelato una disgrazia secolare: basti pensare che nel 1989 il Sud Italia era più ricco di ogni singola area post-comunista, mentre oggi si contano sulle dita di una mano le zone, un tempo del socialismo reale, che sono ancora meno ricche del Meridione. E non ve ne è neanche una che non abbia messo la freccia per il sorpasso. In breve, la lezione è questa: dal comunismo si può uscire, dall’assistenzialismo paternalista no.
Il Sud diventò il problema dei problemi del Regno e poi della Repubblica. Fra la fine dell’Ottocento e la Grande Guerra milioni di meridionali compresero che potevano finalmente risolvere il grande problema italiano, e anche il loro, emigrando. Oggi i loro discendenti vivono liberi dalle rendite e dalle sinecure pubbliche in decine di paesi.
In breve, dalla conquista regia ha inizio una vera e propria marginalizzazione del Meridione. Tutte le decisioni politiche cruciali sono prese altrove, e se il Sud passa dal ruolo di spettatore inerme a quello di vittima designata ovviamente il vittimismo (in parte giustificato) diventa la cifra ultima delle lamentationes di un certo meridionalismo d’accatto fino ai nostri giorni.
Nella storia italiana, il fascismo non è un episodio fortuito, una parentesi, ma l’esito conseguente di una vicenda politica e istituzionale che ha progressivamente marginalizzato i popoli, i singoli e le loro libertà. Non è stato un infausto ventennio, ma il cuore dell’intera vicenda “nazionale”, il baricentro di un’unificazione che è risultata impossibile da coordinare con gli strumenti della libertà. La lunga marcia dello statalismo inizia con un’unificazione “nazionale” inattuabile, prosegue con una “marcia” su Roma e si conclude ai nostri giorni con il fallimento del Paese sotto il giogo di debito, spesa pubblica fuori controllo e rapina fiscale ai danni della Nord. La prospettiva federale forse avrebbe potuto mitigare l’inimicizia, ma fu sconfitta nel corso del Risorgimento, annichilita dopo l’unificazione e oggi è ormai scomparsa dall’agenda politica.
Se da una marcia era nato il ventennio fascista (che altro non è stato che il tentativo estremo di cercare la pietra filosofale della quale parlava Ranza, ossia di forgiare una nazione da Capo Passero alle Alpi), la lunga marcia dello Stato proseguiva imperterrita nel Dopoguerra. Il grande sforzo fascista della costruzione nazionale non diede gli esiti sperati e le sezioni del paese continuarono a guardarsi in cagnesco.
L’Italia vive una sorta di naufragio nell’unità fin dalle sue origini. Se è pur vero che una certa cultura liberale permeava non poche figure del Risorgimento, con l’affermarsi della “questione nazionale” i temi liberali hanno lasciato il posto a spinte organicistiche tendenti alla creazione di una metafisica comunità nazionale. Allorché l’idea di Costituzione fu spazzata via da quella di Nazione si preparò il successo di un-Risorgimento nazionalista e unificazionista che si prefisse un solo grande compito: utilizzare soldati e moneta per costruire una nazione. Fondata sulla totale sfiducia verso le diverse comunità storiche, l’Italia teme e contrasta le aspirazioni all’autogoverno un tempo del Mezzogiorno e poi delle regioni del Nord.
Ciò che negli ultimi decenni sta aggravando un’inimicizia storicamente e politicamente alimentata anno dopo anno è la schiavitù fiscale del nord. La politica dovrebbe riuscire a mascherare chi le tasse le produce e chi le consuma, facendo sì che non si squarci il velo sulla “finzione secondo la quale tutti credono di poter vivere alle spalle di tutti gli altri” (nota definizione dello Stato dell’economista francese Bastiat del 1850).
Da noi, il debito, il suo mantenimento e il ruolo di Lombardia, Veneto ed Emilia, ossia ufficiali pagatori dei disastri pubblici italiani hanno fatto saltare la possibilità di qualunque camuffamento. Oggi è impossibile credere di esser parte di una ragnatela di relazione statuali dalle quali guadagniamo e perdiamo un po’ tutti. Chi paga e chi riceve, chi tiene i cordoni della borsa e chi la borsa la riempie e basta non possono in alcun modo essere confusi. Il cittadino del settentrione è ormai avvinghiato in una “lotta di tasse” con masse di richiedenti più welfare e “diritti di cittadinanza”, che per lo più risiedono in altre regioni.
Se gli italiani di ogni area sono emigrati in tutto il mondo e ovunque hanno dato prova di operosità e laboriosità, qui non può accadere, giacché il sistema fiscale italiano è destinato a riprodurre il calabrese come calabrese e il lombardo come lombardo all’infinito. Un dato di qualche anno fa (temo che oggi sia solo peggiorata la situazione per il contribuente lombardo) illustra plasticamente tutto ciò. Per generare un euro di spesa pubblica sul proprio territorio il contribuente lombardo versa al fisco 2,45 euro, al contribuente calabrese basterà il pagamento di 27 centesimi di euro per ottenere lo stesso risultato.
Quando si parla di tassazione, vale a dire del reale peso dello Stato, ben oltre l’elefantiaca macchina della compilazione di moduli e attese davanti a uno sportello, l’esperienza dei vari territori è talmente differenziata che si deve evincere che una piena diseguaglianza delle regioni davanti al fisco.
 Se la tirannia fiscale è il dato permanente del nostro vivere quotidiano, e questa coinvolge individui, famiglie, imprese, popolazioni, i lombardi sono costretti dal fisco a riscattare prima la propria terra, poi i propri corpi e infine le loro imprese. Paghiamo una taglia ulteriore rispetto a quella pro-capite che colpisce ogni malcapitato per il fatto di essere all’interno di un inferno fiscale di nome Italia. Questa tassa occulta è di circa il 18% del PIL lombardo. Si tratta di una vera e propria “dazione ambientale” che non ha precedenti nella storia e rende la Lombardia una delle aree che pagano il più alto tributo della storia al Leviatano governativo. La Lombardia ha una spesa pubblica liberista (circa 34%, pari a quella elvetica) e una tassazione socialista (oltre il 60%). I miei concittadini sono i finanziatori a piè di lista del socialismo degli altri. Questa tassa in più, quel residuo fiscale di quasi sessanta miliardi ogni anno, la paghiamo solo perché abitiamo in luoghi più produttivi di altri. È una sorta di estorsione territoriale occulta della quale non parla mai nessuno: sono i “soldi degli altri”, quelli che Margaret Thatcher definiva il fondamento ultimo del socialismo, ma che hanno una particolarità: prima o poi finiranno. Gianfranco Miglio non considerava né volgare né inconfessabile l’antico sogno popolare lombardo di essere ricchi per quanto si produce, senza venir taglieggiati. “Non è – spesso mi diceva – che se questi poveri lombardi sono tarantolati dal lavoro e se ne fregano della politica debbano perciò stesso essere sfruttati”.
Se la tirannia fiscale è il dato permanente del nostro vivere quotidiano, e questa coinvolge individui, famiglie, imprese, popolazioni, i lombardi sono costretti dal fisco a riscattare prima la propria terra, poi i propri corpi e infine le loro imprese. Paghiamo una taglia ulteriore rispetto a quella pro-capite che colpisce ogni malcapitato per il fatto di essere all’interno di un inferno fiscale di nome Italia. Questa tassa occulta è di circa il 18% del PIL lombardo. Si tratta di una vera e propria “dazione ambientale” che non ha precedenti nella storia e rende la Lombardia una delle aree che pagano il più alto tributo della storia al Leviatano governativo. La Lombardia ha una spesa pubblica liberista (circa 34%, pari a quella elvetica) e una tassazione socialista (oltre il 60%). I miei concittadini sono i finanziatori a piè di lista del socialismo degli altri. Questa tassa in più, quel residuo fiscale di quasi sessanta miliardi ogni anno, la paghiamo solo perché abitiamo in luoghi più produttivi di altri. È una sorta di estorsione territoriale occulta della quale non parla mai nessuno: sono i “soldi degli altri”, quelli che Margaret Thatcher definiva il fondamento ultimo del socialismo, ma che hanno una particolarità: prima o poi finiranno. Gianfranco Miglio non considerava né volgare né inconfessabile l’antico sogno popolare lombardo di essere ricchi per quanto si produce, senza venir taglieggiati. “Non è – spesso mi diceva – che se questi poveri lombardi sono tarantolati dal lavoro e se ne fregano della politica debbano perciò stesso essere sfruttati”.
In conclusione, l’Italia fin dalla sua unificazione si è appalesata come un progetto politico di danneggiamento e saccheggio ad aree alterne, and injustice for all. Ma soprattutto, ha finito per alimentare un’ostilità fra Nord e Sud che sotto la cenere non smetterà mai di covare.
Vi era dell’intenzione? Oppure si tratta di conseguenza indesiderate di sagge politiche governative degli ultimi 164 anni? Sfido chiunque a sostenere quest’ultima ben bizzarra tesi.
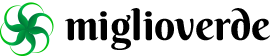


Ottima… I-TAGLIA TUTTA!!!