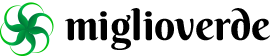di VLADIMIR MENSHIKOV
Siamo veramente sicuri che la spesa pubblica possa contribuire alla stabilità macroeconomica ed alla maggiore produttività del lavoro? Sono in molti a sostenerlo: credendo fermamente nell’assunto che la spesa in parola, se destinata a finanziare grandi progetti di investimenti pubblici, possa effettivamente stimolare la domanda aggregata e concorrere all’accumulo di capitale. In un mio precedente articolo (di critica nei confronti della concezione ancora prevalente, fortemente informata ai precetti economici Keynesiani) argomentavo che la spesa pubblica, lungi dall’essere uno strumento adeguato per contrastare la recessione e la disoccupazione, acuirebbe invece, sempre e comunque, quegli effettivi problemi economici, che dovrebbe essere chiamata a risolvere. In un altro articolo, ho cercato di dimostrare che è proprio il meccanismo bancario della riserva frazionaria, protetto e favoreggiato dai poteri pubblici, (a prescindere se via sia, o meno, l’istituzione della banca centrale) ad essersi sempre configurato come la fonte effettiva delle fluttuazioni della domanda aggregata.
Nel presente scritto mi propongo di sviscerare due punti:
- 1. non esiste proprio nulla che possa definirsi come un “investimento pubblico”: esiste solo ed esclusivamente il “consumo pubblico”. Questo corollario diventa ineludibile, una volta riconosciuti:
a. il carattere distintivo della posizione economica dello Stato, nell’ambito di un sistema economico caratterizzato dalla divisione del lavoro, e
b. la natura stessa dei principi di organizzazione e di gestione, in base ai quali le amministrazioni pubbliche conducono tutte le loro attività. - 2. Dal momento che sono esclusivamente gli investimenti privati a costituire l’unica fonte di accumulazione del capitale e di progresso economico, una tassazione eccessiva riduce il capitale disponibile e pregiudica la crescita economica.
Attività Produttive e atti di consumo nell’ambito di un sistema caratterizzato dalla divisione del lavoro
Per comprendere come lo Stato sia semplicemente un consumatore di risorse, ancorché di tipo speciale, diventa fondamentale cogliere l’idea che la spesa pubblica nel suo complesso – includendo nel novero anche le spese ascrivibili alla categoria dei cosiddetti “beni pubblici” (autostrade, ponti, porti, gallerie, ecc) – è, per definizione, fisiologicamente orientata al consumo; e non è affatto produttiva, nell’accezione che, con questo termine, si conviene di attribuire a quelle spese, le quali, nel settore privato, sono finalizzate alla produzione. [1]
Per cogliere appieno l’attuale status economico dello Stato e delle sue spese, nel contesto di una società caratterizzata dalla divisione del lavoro, abbiamo invece bisogno di capire i criteri che ci consentirebbero di classificare tutte le attività economiche, sussumendole in una delle due categorie di base: attività produttive ed attività volte al consumo.
Riferendoci ad una economia di tipo robinsoniano, ci potrebbero essere delle buone ragioni per distinguere tra le due categorie basiche di attività economiche – quelle produttive e quelle orientate al consumo – impiegando dei criteri espressi in termini di unità di beni fisici, ovvero di soddisfazione derivanti dal consumo di questi beni.
 Ma applicare gli stessi criteri e lo stesso modo di ragionare alle fattispecie riconducibili ad una moderna economia monetaria, postulerebbe solamente la commissione di un fatale errore concettuale.
Ma applicare gli stessi criteri e lo stesso modo di ragionare alle fattispecie riconducibili ad una moderna economia monetaria, postulerebbe solamente la commissione di un fatale errore concettuale.
La caratteristica distintiva di un sistema basato sulla divisione del lavoro è la struttura delle sue interdipendenze economiche; una struttura che, in maniera decisa, influenza, modella, e condiziona le azioni, suscettibili di trovare rispondenza economica, poste in essere da tutti i suoi attori interagenti.
Per comprendere correttamente la natura [e le caratteristiche, ndt] dell’esistenza che si svolge nell’ambito di un’economia incentrata sulla divisione del lavoro, dobbiamo innanzitutto afferrare le ineludibili ed irripetibili condizioni che definiscono e caratterizzano le motivazioni dei suoi partecipanti; ed, in particolare, il ruolo delle spese redditizie ed apportatrici di valore aggiunto, inerenti al processo di produzione.
In primo luogo, come lucidamente spiegato dal professor Reisman: <<Senza la possibilità di poter guadagnar soldi, un soggetto dovrebbe adattarsi a produrre e a vivere ad un livello che può definirsi intermedio tra una sussistenza di tipo robinsoniano ed il tenore di vita registrato dagli abitanti di Tobacco Road>>. [2] L’incredibile complessità di un sistema economico caratterizzato dalla divisione del lavoro trova una sintesi nel sistema dei prezzi, che a sua volta è ineludibilmente dipendente dalla presenza della moneta, [quale mezzo di scambio], nonché dall’esperibilità del calcolo monetario, come dimostrato da Ludwig von Mises e dalla Scuola Austriaca. [3] Nessuno di questi elementi impatta sulla consapevolezza e sulle motivazioni di Robinson Crusoe: né la necessità di acquisire il potere di acquisto, né la necessità di avvalersi di un calcolo monetario per apprezzare i risultati e le aspettative rivenienti dalle sue stesse azioni.
In secondo luogo, nell’alveo di un’economia monetaria in cui opera la divisione del lavoro, tutte le spese devono essere valutate o come produttive, ovvero come improduttive. (La spese improduttiva è definita anche “consumo”). Detto altrimenti, una data quantità di moneta e il volume della spesa possono essere ripartiti, in ultima analisi, in conformità allo scopo della spesa stessa – di consumo, ovvero di produzione. Tertium non datur.
Dal punto di vista del singolo consumatore, una volta che le risorse sono state spese nell’acquisizione di beni di consumo, diventa ineludibile trovare il sistema per ricostituire nuovi fondi, necessari per poter esperire, in futuro, ulteriori atti di consumo. L’evidenza che, una volta speso, il denaro non sia più disponibile si appalesa immediatamente nel fatto che un atto di consumo non fornisce alcun mezzo, né fisico né monetario, per ottenere beni ulteriori in un successivo momento. Siamo di fronte, letteralmente, ad un atto di distruzione dei beni che erano stati prodotti in precedenza. D’altra parte, la spesa produttiva, secondo il professor Reisman,
è sinonimo di spesa riproduttiva, in quanto trattasi di risorse che vengono al contempo consumate e ripristinate, in virtù della produttività della spesa …. E questo essenzialmente perché, nel contesto del processo di cui è parte, la spesa in questione non costituisce un mero esborso di denaro. I fondi che vengono spesi in maniera produttiva producono un successivo ritorno economico, a cui solitamente è associato un profitto. Al contrario, i fondi che sono spesi improduttivamente, di regola, o non producono alcun ritorno, ovvero lo generano in misura alquanto limitata, e pertanto devono intendersi dei meri atti di consumo … In un caso, assistiamo alla ricostituzione e all’incremento. Nell’altro, semplicemente ad una perdita secca. [4]
Risulta pertanto evidente che le spese produttive possono essere effettuate esclusivamente da imprese commerciali, orientate a produrre beni e servizi, i quali, a loro volta, saranno poi oggetto di scambi monetizzabili sul mercato. Lo scopo primario per la costituzione di una qualsiasi impresa commerciale è, in primo luogo e naturaliter, la realizzazione dei profitti. E dal momento che la quantità di moneta e il volume di spesa sono da intendersi, in un qual certo senso, delle variabili sostanzialmente stabili, vi è una costante competizione, tra le stesse imprese commerciali, per accaparrarsi la maggior quota di risorse monetarie scarse.
 È del tutto irrilevante stabilire, in quale misura, l’attività in questione sia fisicamente produttiva. Un’attività deve essere classificata come produttiva se viene intrapresa con lo scopo di realizzare o di contribuire a realizzare dei profitti, suscettibili di essere valutati in denaro, o esprimibili nella forma di ricavi da vendite, di redditi da locazione, oppure di redditi da interessi.
È del tutto irrilevante stabilire, in quale misura, l’attività in questione sia fisicamente produttiva. Un’attività deve essere classificata come produttiva se viene intrapresa con lo scopo di realizzare o di contribuire a realizzare dei profitti, suscettibili di essere valutati in denaro, o esprimibili nella forma di ricavi da vendite, di redditi da locazione, oppure di redditi da interessi.
Basti un esempio: sia una lavanderia professionale, che una casalinga, fanno uso di lavatrici. L’obiettivo di entrambe le parti è di rendere nuovamente puliti i vestiti sporchi: potremmo dire, in un qual certo senso, che sono “produttori” di vestiti puliti. E similmente, in ambedue le situazioni, le lavatrici sono soggette ad usura e a deterioramento naturale. Eppure, nonostante tutte le similitudini riguardanti gli aspetti esteriori e fisici del processo messo in atto, i soggetti in parola svolgono due attività profondamente diverse, in relazione alla loro importanza economica.
Nel primo caso, la casalinga, per i suoi “servizi” domestici, non riceve alcun corrispettivo, che potrebbe poi reimpiegare per l’acquisto di una nuova lavatrice, una volta che la vecchia si fosse rotta. Ella deve rivolgersi ad altri canali per ricostituire i fondi necessari all’acquisto di una macchina nuova.
Nel secondo caso, invece, la lavanderia riceve dei pagamenti in virtù della prestazione del proprio servizio di pulizia. I ricavi ottenuti possono così essere utilizzati per rimpiazzare le lavatrici, mano a mano che le stesse si usurano. L’utilità effettiva, traibile dall’attività di lavare i propri vestiti in casa, potrebbe essere, invero, alquanto elevata; i capi curati da una casalinga potrebbero essere più puliti e profumare ancor di più, rispetto a quelli trattati dalla lavanderia professionale, ma questo fatto è del tutto irrilevante per quanto attiene alla natura delle relazioni economiche che si registrano nell’ambito di un contesto economico, qualificato dalla divisione del lavoro.
Se spingiamo l’analisi ancor più a ritroso, non possiamo naturalmente prescindere dalle modalità con cui la casalinga e suo marito abbiano costituito il potere d’acquisto, per potersi consentire la lavatrice, innanzi tutto. E come ho avuto modo di spiegare dettagliatamente in un altro scritto, la fonte dei salari non può essere identificata in un mero atto di consumo, bensì in una spesa produttiva realizzata esclusivamente da aziende del settore privato. [5]
Lo status economico dello Stato in un sistema economico caratterizzato dalla divisione del lavoro
Ora, al fine di rispondere al quesito se lo Stato possa o meno configurarsi come un produttore di ricchezza – o se almeno alcuni dei suoi progetti possano annoverarsi nella categoria degli investimenti(produttivi) – abbiamo bisogno di focalizzare i seguenti punti, attinenti al suo ruolo quale ente economico.
In primo luogo, il fatto stesso che lo Stato debba ricorrere all’esazione delle imposte (o alla stampa di moneta fiat) per finanziare le proprie attività e i propri progetti, già ciò si pone, prima facie, come un argomento decisivo contro l’assimilazione di questo modus operandi a quello integrato dalla produzione e dallo scambio.
In secondo luogo, le modalità con cui lo Stato raccoglie ed impiega i fondi raccolti – in breve, come lo stesso gestisce le risorse economiche di cui si è appropriato – non è affatto equiparabile alla natura delle operazioni intraprese dalle imprese commerciali, la cui esistenza è soggetta alle leggi della concorrenza di mercato, in funzione dei profitti o delle perdite realizzate. In effetti, il modus operandidello Stato è integralmente informato al principio burocratico, che è quanto di più lontano possa esservi rispetto alle logiche fondative di un sistema basato sulle informazioni trasmesse da profitti e perdite. Ed è proprio perché lo Stato si assicura le risorse per via di riscossioni coatte, e non certo guadagnandosi il denaro necessario a finanziare i propri progetti, che dobbiamo equiparare il suostatus, né più né meno, a quello di un consumatore.
Ma chi meglio di Ludwig von Mises può spiegarci, in maniera efficace, queste argomentazioni: affidiamoci ad alcuni stralci tratti da Bureaucracy, in una versione del 1962:
Gli obiettivi della Pubblica Amministrazione non possono essere misurati in termini monetari e nemmeno possono essere sottoposti a verifica per mezzo di metodologie che si avvalgono della contabilità … Nella Pubblica Amministrazione non sussiste la benché minima connessione tra entrate e uscite. I servizi pubblici postulano solo ed esclusivamente delle uscite; i proventi, pressoché irrisori, derivanti da fonti speciali (ad esempio, la vendita di stampati da parte del Poligrafico dello Stato) sono più o meno accidentali. Le entrate originate dai dazi doganali e dalle tasse non sono “prodotte” dall’apparato amministrativo. La loro scaturigine è la legge, e non certo le attività dei funzionari doganali o degli esattori. E ancora, non è certo merito di un gabelliere se i residenti nel suo distretto sono più ricchi e pagano tasse più elevate rispetto agli abitanti di un altro distretto. (pp. 48-50)
Un’Amministrazione pubblica non è un’impresa dedita alla ricerca del profitto; e non può far uso di alcun calcolo economico. Inoltre, deve far fronte a problemi che sono del tutto alieni alla gestione di profitto. (p. 51)
La conduzione degli affari dello Stato è tanto differente dai processi utilizzati nell’industria, quanto il perseguire, il giudicare, e il condannare un assassino lo siano dal coltivare mais o dal produrre scarpe. Quando parliamo di efficienza dello Stato o di efficienza nell’industria stiamo parlando di concetti diametralmente opposti. La gestione di una fabbrica non può essere implementata prendendo a modello un dipartimento di polizia, così come un ufficio dell’Agenzia delle Entrate non può diventare più efficiente, adottando i metodi produttivi di un impianto che produce automobili… Nessuna riforma potrebbe mai trasformare un ufficio pubblico in una sorta di impresa privata. Lo Stato non è certo un’impresa che tende alla massimizzazione del profitto. La gestione dei suoi affari non può essere sottoposta ad alcuna verifica, informata alla logica del calcolo dei profitti e delle perdite. I suoi risultati non possono essere valutati in termini monetari. (p. 55).
Lo Stato, pertanto, è un mero consumatore di risorse, ancorché un consumatore di tipo speciale. Quindi, tutte le sue attività ed i suoi programmi – dal finanziamento dei più svariati progetti sociali, alla pubblica istruzione, dalla costruzione delle strade, a quella delle dighe, passando per le infrastrutture – si configurano come atti di consunzione, per loro stessa natura.
Come qualsiasi altro consumatore, lo Stato deve rivolgersi al processo di produzione – ovvero, ai produttori – per reperire i suoi fondi. Ma a differenza degli ordinari consumatori, che ottengono il loro reddito per via degli scambi volontari, lo Stato acquisisce le risorse in forza di una spoliazione forzosa, che va sotto il nome di “tassazione”.
Note:
[1] È sicuramente facile comprendere i motivi in base ai quali la gente considera i ponti ed i porti quali investimenti dotati di un intrinseco potenziale produttivo; ad ogni modo, qualora tali progetti fossero veramente meritevoli di essere presi in considerazione, il libero mercato non se li farebbe di certo sfuggire, ambendo alla loro realizzazione.
[2] George Reisman, Capitalism: A Treatise on Economics, p. 443.
[3] Si rimanda a Ludwig von Mises (1922): Economic Calculation in the Socialist Commonwealth
[4] George Reisman, Capitalism, p. 444.
[5] Il professor George Reisman ha formulato queste idee, eccezionalmente feconde, in relazione alla distinzione tra spese produttive e spese orientate al mero consumo, come applicata nella fattispecie di un contesto economico caratterizzato dalla divisione del lavoro. Per una dettagliata analisi dei principi che stanno alla base della distinzione e per una serie di importanti implicazioni per la teoria economica, si rimanda al suo libro Capitalism: A Treatise on Economics, chapter 11: “The Division of Labor and Productive Activity”.
TRATTO DA: Articolo di Vladimir Menshikov su Mises.org. – Traduzione di Cristian Merlo per http://vonmises.it