di MARCO TAMBURELLI* E MAURO TOSCO**
Prima di tutto vorremmo ringraziare Oneto per avere lanciato un dibattito sulla questione della lingua.
 Sappiamo benissimo che viviamo in un periodo in cui chi è esperto in materia è malvisto, e che in internet “uno vale uno”, però vorremmo provare ugualmente a suggerire un’analisi dal punto di vista di chi la linguistica la pratica per lavoro, particolarmente nel campo delle lingue in pericolo.
Sappiamo benissimo che viviamo in un periodo in cui chi è esperto in materia è malvisto, e che in internet “uno vale uno”, però vorremmo provare ugualmente a suggerire un’analisi dal punto di vista di chi la linguistica la pratica per lavoro, particolarmente nel campo delle lingue in pericolo.
Vorremmo iniziare precisando un paio di cose:
1. che l’uso di termini lombardi in italiano arricchisca la lingua italiana a sua volta impoverendo quella dei lombardi non è un “mio dire”, ma un dato empiricamente dimostrato e dimostrabile in tutti i casi di deriva linguistica riportati negli ultimi cinquant’anni. Per vari motivi di subordinazione socio-linguistica, vocaboli o costruzioni grammaticali della lingua discriminata vengono importati nella lingua di regime o “maggioritaria”. A lungo andare, questi “neologismi” vengono accettati come parte della lingua maggioritaria ed introdotti nei suoi dizionari. Il risultato è che la lingua maggioritaria si arricchisce, avvicinandosi alla lingua discriminata (perché ora condivide più vocaboli e strutture con essa), facendo in modo che la lingua discriminata diventi suo dialetto, anche in casi in cui – come il nostro – non si trattava di dialetto in partenza. Aggiungendo danno alla beffa, i dizionari scriveranno la mezza verità secondo la quale i neologismi in questione sono di etimologia latina o gotica o germanica, ma non di certo di origine lombarda. Questo ovviamente accade già con le parole che le lingue padane hanno regalato all’italiano nei secoli scorsi, come per esempio l’oggi italianissimo “riva” (in opposizione all’italiano antico “ripa”) o “sabbia” (in opposizione all’italiano antico “rena”), che il Garzanti riporta orgogliosamente come etimi “dal latino”, ignorando bellamente il passaggio intermedio.
Traduzione in padano: se tu continui a pagare le tasse finisci per arricchire chi ti discrimina, ed inoltre legittimi pure le sue affermazioni quando sostiene che “anche tu sei uno di noi, come dimostrato dal fatto che paghi le nostre tasse, non quelle di un altro Paese”. Aggiungendo danno alla beffa, diranno poi che le ricchezze dello stato non vengono dalle tue tasse, ma da una manovra latina fatta da loro.
2. La lingua italiana non “andrebbe trattata come strumento di oppressione”, la lingua italiana è stata ed è tuttora obiettivamente uno strumento di oppressione. Oppressione socio-culturale prima e dei diritti di parola e di pensiero adesso. Quanti cittadini italiani nei decenni passati evitavano di andare in un ufficio o di parlare con persone in posizioni di autorità perché “mi no so miga parlar il tagliano”? Un’intera generazione a cui viene imposta una lingua estranea alla propria cultura e a cui inoltre viene vietato di parlare la propria lingua madre nei contesti dove avviene la mobilità sociale è una generazione discriminata. Non lo diciamo noi, lo dice il diritto internazionale.
Oggi, quando ormai l’italiano lo parliamo tutti, non è più lo stesso tipo di discriminazione, ma sempre di discriminazione si tratta. E’ ormai risaputo da decenni che la lingua che si parla ha effetti sulla struttura del pensiero e della sua formazione. Quando ci obbligano a parlare italiano ci obbligano dunque a pensare italiano, che ci piaccia o meno. E’ inoltre riconosciuto dal diritto internazionale che la libertà di espressione non si limita a ciò che si esprime, ma comprende anche la facoltà di scelta della lingua in cui ci si esprime (là dove quella lingua è storicamente radicata). Un lombardo che non può parlare il lombardo negli uffici e nelle scuole della Lombardia è vittima di discriminazione, a prescindere dal suo livello di conoscenza dell’italiano (così come lo è, mutatis mutandis, un piemontese o un siciliano). Non lo diciamo noi, lo dice il diritto internazionale.
Non dimentichiamoci poi le oppressioni “attive” contro le lingue del territorio.
Maggio 2005: una scuola media napoletana istituisce una multa di 10 centesimi per ogni studente scoperto mentre parla napoletano. Gli studenti vengono incoraggiati a spiarsi l’un l’altro. Simili misure venivano prese in Galles nell’800. Oggi scatenerebbero la furia dei tribunali gallesi.
Dicembre 2009: in un mercato locale, un pescivendolo etichetta i suoi prodotti in veneto. La polizia locale lo multa 1167 euro. Simile alla “Legge sul Commercio” che, nella Spagna di Franco, vietava l’uso del catalano per le attività commerciali. In quel tempo, anche in Catalogna, che ora vediamo giustamente come una storia di successo, si pensava che la loro questione della lingua fosse “una battaglia persa perché in realtà mai cominciata”. Certo, è cominciata poi. Ma come si dice in lingua lombarda (senza dieresi), “prima de rivar-ga i g’eran mìa”. Ovvero una cosa può incominciare solo quando la si incomincia.
Oneto ha ovviamente ragione da vendere quando dice che i “puristi della dieresi” sono nemici della battaglia linguistica. Non esiste alcuna operazione di mantenimento linguistico di successo che sia limitata al dialetto di una città o provincia. I casi di successo hanno sempre e inevitabilmente raggruppato i dialetti locali sotto il “tetto” di una lingua regionale. Sempre. La “lingua basca” raggruppa sei zone dialettali (NB, sei zone, non sei dialetti, perché i dialetti locali sono molti di più), la “lingua catalana” cinque, la “lingua gallese” tre, e così via. Non esiste esempio dove il dialetto specifico di una città è stato recuperato come singolo dialetto o trasformato in “lingua cittadina”. Nessuno, zero, nisba, niente, nemmeno uno. Questo è un semplice ed importante dato di fatto che va riconosciuto da chiunque abbia a cuore le lingue locali. Il dialetto tarragonese è ancora parlato perché inserito come variante della lingua catalana, con tutti i vantaggi linguistici e socio-economici che ne conseguono. Nessuna fantomatica “lingua tarragonese” avrebbe resistito in opposizione ad altre “lingue” cittadine, con una sua grafia diversa da quella di una “lingua barcellonese” o una “lingua gironese” che si fanno la guerra della dieresi. Il dialetto di Tarragona come variante della lingua catalana, invece, resiste con successo, a dimostrazione che il “sacrificio” è minimo, mentre la ricompensa è grande.
Come potenziale soluzione, Oneto rispolvera l’ipotesi di “koiné padanese”. A questo proposito è bene ricordare che Hull propose (in modo egregio e accademicamente ineccepibile) un modello di evoluzione storica, non una lingua da ricostruire dopo un migliaio di anni. Le posizioni dell’ottimo divulgatore Salvi puntano invece sulla diversità linguistica dell’Italia, fatto sul quale c’è ancora bisogno di molta sensibilizzazione. Né l’uno né l’altro sono in grado di creare una “lingua padanese” di cui, ci sembra, nessuno sente la necessità.
Quanto alla “battaglia persa perché mai cominciata”, ci appelliamo all’onestà intellettuale di Oneto: anche l’indipendentismo non è mai stato preso seriamente, solo “un po’ all’inizio dalla Lega e poi basta”, ma non vediamo Oneto usare questo fatto come ragione per “lasciare perdere e accettare la vittoria dell’Italia, e magari studiare l’inglese”.
La cosa cruciale però è che nella lista di potenziali soluzioni fornita da Oneto manca il punto essenziale: quello che ha il supporto dell’UNESCO, dell’ISO, e (dal giugno 2013) anche del parlamento europeo attraverso la relazione Alfonsi: l’integrazione delle parlate locali nei sistemi di lingua regionale quali l’emiliano, il ligure, il lombardo, il napoletano, il piemontese, il romagnolo, il siciliano, il veneto. Lo stesso metodo che ha trasformato i dialetti di Catalogna, Galizia, Frisia e Galles in “lingua catalana”, “lingua galiziana”, “lingua frisone” e “lingua gallese” rispettivamente, e che sta trasformando gli ormai “dialetti scozzesi” nella rinata “lingua scozzese”, con il pieno supporto del parlamento scozzese (vedete per esempio qui: http://www.scotslanguage.com/). Questa è quindi la via che, oltre ad essere pavimentata dal supporto di organizzazioni e linguisti di fama internazionale, è anche la via che ha dimostrabilmente avuto successo in molte realtà regionali nonostante le grandi differenze socio-politiche (Catalogna e Frisia non potrebbero essere più diverse dal punto di vista socio-economico).
Raggruppare i dialetti locali sottoforma di lingua regionale – laddove questo non sia già stato fatto (come nel caso del piemontese o del friulano) *non* vuole dire “inventare” qualcosa. Le varianti locali della Lombardia o della Sicilia sono già per loro natura linguisticamente “unite”, anche se non assolutamente identiche (esattamente come accade o è accaduto già per le varianti del catalano, del gallese, dello scozzese, ecc.). Raggrupparle sottoforma di lingua regionale vuole semplicemente dire applicare l’unico modello di sviluppo linguistico che ha dimostrato di funzionare.
L’accademia della polenta lasciamola alle conversazioni da osteria, importanti anche loro per molti motivi, ma che dubitiamo riusciranno a cambiare l’assetto linguistico di una regione. Le direttive Unesco invece…
* Università di Bangor, Galles
** Università di Torino
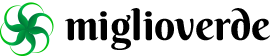


Ho sempre sostenuto che l’italiano fosse una lingua morta. La tesi nasce dal fatto che l’italiano non fu mai parlato (negli anni sessanta lo parlava il 20% della popolazione) e che in realtà è una lingua artificiale, come l’esperanto, nata dal dialetto fiorentino. E’ una lingua morta perché incapace di creare neologismi, penso all’inglese che ne sforna in continuo con creazioni come smog (smoke + fog). L’italiano per i neologismi si è sempre appoggiato al greco antico e al latino (anch’esse lingue morte) ed negli ultimi decenni all’inglese. Un notevole contributo viene dalle lingue locali, queste invece ricchissime, naturali e vive, l’italiano è infarcito di regionalismi con due conseguenze: essendo una lingua morta non riesce ad essere al loro livello, pensate a quanti termini esistono in genovese per indicare le varie condizioni del mare o in piemontese per il tipo di neve, termini spesso intraducibili in italiano perché manca un termine corrispondente. Ecco perché usare termini di lingue gallo-padane in italiano vuol solo dire aiutare gli invasori, l’italiano è la lingua degli invasori, una lingua destinata a scomparire dalle nostre parti con l’indipendenza, una lingua morta, una lingua inutile visto che al contrario di inglese, spagnolo, francese non è parlata da nessuna parte (Canton Ticino escluso ma credo che con la nostra indipendenza anche loro la abbandoneranno).
Penso che il far capire che all’indomani dell’indipendenza l’italiano non solo sarà abbandonato ma neppure tollerato sia fondamentale, da un lato a noi servirà per distinguerci finalmente dai fastidiosi vicini (se no rimarremo come gli irlandesi considerati ancora oggi britannici, rito del te, pub e birra, guida a sinistra, lingua inglese = sono inglesi….) ed evitare danni da future follie nazionalistiche provenienti dal sud della linea gotica, dall’altro servirà a farci identificare per quel che siamo. Se nascesse lo Stato della Fiandra ed il popolo dei fiamminghi nessuno so stupirebbe perché sono noti da secoli. I padani sono sconosciuti, una novità, sono ben noti i “Longobardi” con un loro regno. Il termine longobardo in francese ed inglese è tradotto in “lombard”, “Lombardia” oggi è una piccola frazione di quel che è un tempo era la “Longobardia”. I mercanti, i banchieri lombardi nel senso di astigiani, milanesi, veneziani, ecc erano noti in tutta Europa, ancora oggi esistono le varie “Lombard street” che era il luogo in cui risiedevano.
Se vogliamo essere “Longobardi” non possiamo parlare una lingua foresta e pure apparentata alla lontana come l’italiano, sarebbe come riconoscere la legalità dell’occupazione, accettare i danni subiti. Occorre far capire alla gente che all’indomani dell’indipendenza l’italiano sparirà, i giornali saranno in lingue locali, i programmi TV, i libri, le lezioni a scuola ed università, i cartelli stradali, le istruzioni negli elettrodomestici, gli atti notarili. Negli uffici pubblici si dovrà parlare nelle lingue locali. Così chi è favorevole all’indipendenza inizierà fin da oggi ad attrezzarsi per l’indomani dell’indipendenza, i coloni italiani, gli immigrati italiani che non si sentono “longobardi” nonostante vivano da decenni tra noi, i quisling, non lo faranno e ne pagheranno le conseguenze.
Ovviamente, come ho detto nell’articolo di Oneto, tra le lingue ufficiali “longobarde” ci sono il tedesco ed il francese, in quanto già parlate da minoranze locali. Credo che per un certo periodo di tempo debbano essere le lingue franche, in ogni caso è meglio studiare e far studiare ai nostri figli il francese ed il tedesco piuttosto che l’inutile ed artificiale italiano. Vogliamo esagerare? Adottiamo l’inglese, ripristiniamo la monarchia ed affidiamola ad uno dei figli di Elisabetta oppure diventiamo membri del Commonwealth, così il fossato sulla linea gotica sarà più ampio, ma questa è fantapolitica.