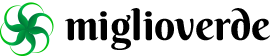Non posso che associarmi a coloro che – simpatizzanti del “si” e del “no” all’indipendenza della Scozia – hanno esaltato la lezione che lo svolgimento del referendum ha impartito al mondo. L’intera vicenda, tutt’altro che chiusa dall’esito elettorale, sollecita alcune riflessioni.
L’unità dello Stato non è un dogma.
La prima riflessione è che gli Stati, anche quelli contemporanei, non sono unità indiscutibili e immutabili. Può sembrare inconcepibile a noi, italiani, dal momento che la nostra Costituzione non si accontenta di ‘descrivere’ l’Italia come “una Repubblica democratica” (art. 1) ma si spinge a ‘prescrivere’, poco più oltre, che essa è “una e indivisibile” (art. 5). Inserendo la norma entro i primi 12 articoli, cioè nei “principi fondamentali”, esplicitamente il legislatore costituente negava che la questione dell’unità del Paese avrebbe mai potuto diventare, in futuro, oggetto di ripensamento.
Questa scelta costituzionale non è un caso. Il suo fondamento o retroterra culturale, prima che ideologico, pare una idea dello sviluppo della storia come qualcosa che procede irreversibilmente in un senso (positivo), di talché il punto di arrivo di un processo unitario possa (e debba!) darsi come acquisito per sempre. Volendo ragionare con mente sgombra da pregiudizio è … davvero una bella pretesa! Quanto meno la si giudicherebbe così se fosse rivolta alla vita degli individui, la quale notoriamente non conosce punti fermi e definitivi ma è in continuo cambiamento. Perché mai, allora, attribuire validità a tale pretesa quando riguardi una pluralità di individui, ovvero una grande moltitudine di individui, ovvero ancora quella istituzione sociale che si chiama ‘Stato’? Sul piano ontologico e metodologico – sia che si tratti di individui sia che si tratti di organizzazioni o gruppi di individui – la storia ha sempre a che fare, ed anzi è soltanto sviluppo di interazioni tra esseri umani. Dunque, per come considero la pretesa – non so se Karl Popper concorderebbe – è possibile che si tratti di una declinazione del modo di pensare storicista.
Questo pensiero, che chiamo appunto storicista, propugna oggi una crescente reductio ad unum dei vari Stati che compongono l’Unione Europea, come compimento di un lungo, risalente tragitto. Giudica necessaria una unione politica, una armonizzazione delle legislazioni, a cominciare da quella fiscale, e reputa regressiva ogni ipotesi di segno contrario. Sposa integralmente una dinamica centripeta e respinge in modo altrettale (anzi, tiene in orrore) ogni spinta centrifuga. Il punto di arrivo del processo unitario – che sembra tutt’altro che promanare, come si dice, ‘dal basso’ -, la sua ‘magnifica sorte e progressiva’, è una entità analoga ad uno Stato nazionale. Questo progetto non si preoccupa di cosa si trovi o starà sotto il coperchio, non si fa carico di analizzare, di conoscere e rispettare la multiforme, l’articolata realtà che ambisce a incasellare.
Probabilmente altro termine adatto (o anche più adatto) a descrivere certo pensiero è ‘costruttivismo’. A ben riflettere dovrebbe appartenere alla stessa famiglia dello storicismo; quella che ha, quale membro (più) illustre, il pensiero utopico ed il cui tratto comune è la pretesa di attribuire all’uomo poteri demiurgici: l’uomo che aspira a cambiare la natura dell’uomo, l’uomo capace di una perfetta conoscenza, che attribuisce un significato definito alla storia, l’uomo onnipotente che pianifica la vita e le istituzioni umane.
A questa famiglia la storia ha dato e continuerà ad impartire, malgrado tutto, sonore lezioni.
La negazione del diritto alla dissociazione è violenza.
La seconda riflessione riguarda le conseguenze (nefaste) di questo e di analogo modo di pensare. Laddove l’unità di uno Stato sia data come intangibile, vuoi che lo si sia sancito in una costituzione rigida, vuoi che lo si spenda comunque come principio politico assiomatico, ciò fa sì che l’eventuale dialettica con forze politiche e/o comunità territoriali che aspirano alla indipendenza rischi di tradursi, presto o tardi, in un vero e proprio conflitto (violento). La sistematica negazione del tema dall’agenda politica, dinanzi e malgrado la diffusione di pressioni indipendentiste all’interno di uno Stato, è foriera di sviluppi non pacifici. E’ essa stessa istanza tutt’altro che pacifica.
 Da un punto di vista liberale, uno Stato siffatto sembra non avere le carte in regola. Per Chandran Kukhatas (in “Arcipelago liberale”, Liberilibri) la tolleranza è virtù fondamentale. Ne è espressione quella ‘libertà di associazione’ (intesa in senso ampio, evidentemente, come libertà di unirsi, secedere o restare all’interno di una compagine statale) che “va intesa non come la libertà di associarsi con altri (poiché questi potrebbero non volerlo), ma come la libertà di dissociarsi dagli individui con i quali non si desidera restare”. Dunque, la controprova della sussistenza di un regime di libertà all’interno di un’organizzazione è, per il filosofo malese, la possibilità di uscita dalla stessa. Non sarebbe un semplice requisito, bensì la conditio sine qua non. Per Ludwig von Mises “il diritto di autodeterminazione, per quanto concerne la questione dell’appartenenza allo Stato, non significa che questo: ogniqualvolta gli abitanti di un dato territorio – a prescindere che si tratti di un singolo villaggio, di un’intera contea, o di una serie di distretti contigui – hanno espresso, mediante il ricorso a libere votazioni, il desiderio di non voler più far più parte dell’ordinamento statale cui al momento appartengono, bensì di ambire alla costituzione di uno Stato autonomo, ovvero di venire a fare parte di un altro Stato, di queste volontà bisogna naturalmente tener conto. Questo è l’unico modo praticabile ed efficace per prevenire rivoluzioni, guerre civili e conflitti internazionali” (da “Liberalism” e anche in “La secessione nel pensiero di Mises” di H. H. Hoppe [trad. Cristian Merlo, “Ludwig von Mises Italia”, 17 gennaio 2013]).
Da un punto di vista liberale, uno Stato siffatto sembra non avere le carte in regola. Per Chandran Kukhatas (in “Arcipelago liberale”, Liberilibri) la tolleranza è virtù fondamentale. Ne è espressione quella ‘libertà di associazione’ (intesa in senso ampio, evidentemente, come libertà di unirsi, secedere o restare all’interno di una compagine statale) che “va intesa non come la libertà di associarsi con altri (poiché questi potrebbero non volerlo), ma come la libertà di dissociarsi dagli individui con i quali non si desidera restare”. Dunque, la controprova della sussistenza di un regime di libertà all’interno di un’organizzazione è, per il filosofo malese, la possibilità di uscita dalla stessa. Non sarebbe un semplice requisito, bensì la conditio sine qua non. Per Ludwig von Mises “il diritto di autodeterminazione, per quanto concerne la questione dell’appartenenza allo Stato, non significa che questo: ogniqualvolta gli abitanti di un dato territorio – a prescindere che si tratti di un singolo villaggio, di un’intera contea, o di una serie di distretti contigui – hanno espresso, mediante il ricorso a libere votazioni, il desiderio di non voler più far più parte dell’ordinamento statale cui al momento appartengono, bensì di ambire alla costituzione di uno Stato autonomo, ovvero di venire a fare parte di un altro Stato, di queste volontà bisogna naturalmente tener conto. Questo è l’unico modo praticabile ed efficace per prevenire rivoluzioni, guerre civili e conflitti internazionali” (da “Liberalism” e anche in “La secessione nel pensiero di Mises” di H. H. Hoppe [trad. Cristian Merlo, “Ludwig von Mises Italia”, 17 gennaio 2013]).
In più, la reputazione di questa libertà non può essere condizionata al colore politico di chi reclama l’indipendenza. Nel caso scozzese, mi pare di aver compreso che le forze politiche impegnate nella battaglia secessionista siano tutt’altro che di segno liberale; anzi, un misto di nazionalismo e di socialismo(democratico). Come ha scritto M. Faraci (“Referendum Scozia: le ragioni liberali per l’indipendenza”, “The Fielder”, 9 settembre 2014), “le argomentazioni entrate nel dibattito referendario non sono entusiasmanti dal punto di vista liberale… sarebbe sbagliato, tuttavia, derivare un pregiudizio sulla scelta indipendentista dalla cifra politica dei nazionalisti scozzesi”.
La teoria liberale, tutto sommato, affronta il tema con il dovuto realismo. Realismo qui significa: presa d’atto della realtà (umana) così come è. Si fonda sull’idea, persino banale, che non si può tenere insieme per forza – almeno troppo a lungo e men che mai per sempre – ciò che insieme volontariamente non sta. Quanti esempi possiamo trarre dalla storia, anche recente? Non c’è bisogno di citarli. E’ molto, molto più saggio e producente prendere atto delle circostanze, piuttosto che (pretendere di) imporre una volontà contraria. Certa imposizione, comunque declinata (ripeto, sia a partire da precetti costituzionali, che da scelte politiche dei gruppi di maggioranza, ecc.), è destinata a dar vita ad ambienti conflittuali permanenti, striscianti, quando non ad aperte esplosioni di violenza.
E’ un fatto che ad oggi, nel mondo, la via generalmente seguita risulta proprio la seconda.
Il referendum scozzese è esempio di libertà.
 Terza riflessione: proprio per quanto sopra argomentato il referendum scozzese è (stato) un evento molto importante. Esso ha dimostrato che è possibile, davvero possibile, che un processo di distacco di un territorio da uno Stato possa essere gestito in modo pacifico e non violento. Anche se, probabilmente, non in modo del tutto agevole – non cioè senza pesanti conseguenze. Mi riferisco in particolare alle ritorsioni minacciate dal Regno Unito (o meglio, dal “Rest of United Kingdom”), sia di tipo economico-finanziario che di altro genere. Questi segni di debolezza politica e morale non tolgono tuttavia alla Gran Bretagna il merito di aver dato, volente o nolente, una grande lezione di libertà. Capita a fagiolo la riflessione di Kukhatas (ancora da “Arcipelago liberale”, op. cit.) quando non si nasconde che la scelta dell’uscita possa essere sottoposta a condizioni gravose, ad un prezzo molto alto: “il costo può avere un grande peso sulla decisione, ma non ha nessun peso sulla libertà dell’individuo di prenderla”. Insomma, la Scozia ha avuto per le mani la concreta opportunità di separarsi dal Regno Unito e questo è un fatto incontestabile, pacifico. Se la maggioranza degli scozzesi ha potuto liberamente e legittimamente rifiutare questa opportunità, significa che avrebbe potuto accadere anche il contrario. E’ la possibilità di dire “si” o no” che nella generalità di queste situazioni viene negata a priori, perché le èlites al potere non amano cedere il controllo dei processi decisionali, ritenendolo per lo più ‘affare loro’.
Terza riflessione: proprio per quanto sopra argomentato il referendum scozzese è (stato) un evento molto importante. Esso ha dimostrato che è possibile, davvero possibile, che un processo di distacco di un territorio da uno Stato possa essere gestito in modo pacifico e non violento. Anche se, probabilmente, non in modo del tutto agevole – non cioè senza pesanti conseguenze. Mi riferisco in particolare alle ritorsioni minacciate dal Regno Unito (o meglio, dal “Rest of United Kingdom”), sia di tipo economico-finanziario che di altro genere. Questi segni di debolezza politica e morale non tolgono tuttavia alla Gran Bretagna il merito di aver dato, volente o nolente, una grande lezione di libertà. Capita a fagiolo la riflessione di Kukhatas (ancora da “Arcipelago liberale”, op. cit.) quando non si nasconde che la scelta dell’uscita possa essere sottoposta a condizioni gravose, ad un prezzo molto alto: “il costo può avere un grande peso sulla decisione, ma non ha nessun peso sulla libertà dell’individuo di prenderla”. Insomma, la Scozia ha avuto per le mani la concreta opportunità di separarsi dal Regno Unito e questo è un fatto incontestabile, pacifico. Se la maggioranza degli scozzesi ha potuto liberamente e legittimamente rifiutare questa opportunità, significa che avrebbe potuto accadere anche il contrario. E’ la possibilità di dire “si” o no” che nella generalità di queste situazioni viene negata a priori, perché le èlites al potere non amano cedere il controllo dei processi decisionali, ritenendolo per lo più ‘affare loro’.
L’opportunità di un inedito (o, quanto meno, insolito) esperimento sociale.
Questo porta direttamente alla quarta riflessione: il perché del mio favore verso l’indipendenza scozzese.
Non sono così attaccato al nazionalismo scozzese, non posso d’altronde affermare di conoscerne le origini, le ragioni, le istanze politiche. In più, ammetto che mi piace davvero poco qualunque tipo di nazionalismo: da liberale, non sono tanto interessato alle pretese delle nazioni, quanto alla vicenda, alla sorte degli individui, del loro concreto status all’interno di un qualsivoglia gruppo sociale.
Il mio “si” all’indipendenza scozzese è stato ispirato ad una generale simpatia per tutte le istanze che implicano una libertà negativa o di uscita, nonché al desiderio di osservare nel suo svolgimento – fatto piuttosto unico, nella storia – un processo non violento di separazione e di acquisizione dell’indipendenza. Un interesse accentuato, dunque, verso un inedito esperimento sociale che, per quanto già detto, avrebbe potuto costituire un importante precedente politico, terreno eccezionale di confronto, di crescita culturale e sociale, capace di predisporre negli individui sentimenti meno drammatici, meno catastrofici, di fronte a certe sfide.
Molti hanno sparso e venduto un vero e proprio terrorismo psicologico contro l’addio della Scozia al Regno Unito. Mi piace citare il sempre sorprendente (ormai non per quello che scrive, ma per il fatto di continuare regolarmente a scrivere su uno dei più importanti quotidiani a tiratura nazionale) Guido Rossi, che su “Il Sole 24 Ore” di domenica 21 settembre ce ne fornisce un esempio a posteriori. Leggete qua: “L’effetto storico prorompente e globale del referendum scozzese, indipendentemente dal suo risultato, ha distrutto definitivamente le basi dello Stato moderno” (!) di hobbesiana memoria. “Il ‘contratto sociale’, che serviva a controllare la ‘guerra di tutti contro tutti’ e assicurare un nuovo ordine razionale basato sul controllo della violenza e dell’egoismo individuale, veniva affidato al nuovo sovrano artificiale: cioè lo Stato”. Il punto di vista di Rossi è certamente illiberale ed è molto diffuso, purtroppo anche tra alcuni liberali. Mostra essenzialmente incapacità di immaginazione, di intraprendenza e di fiducia; nasce da una profonda refrattarietà verso tutto ciò che produce o è elemento di cambiamento, di innovazione, di crisi, di imprevisti. La curiosità intellettuale, il desiderio di sperimentare, vorrei dire perfino la passione per le res humanae, sembrano lontani anni luce da questa mentalità. Dalle frasi riportate risaltano evidenti l’equazione secessione-violenza, la contrapposizione tra una realtà razionale (lo Stato) e una dinamica irragionevole (tutto quanto attenti alla sua maestà e intangibilità), l’accostamento di un processo indipendentista alla riedizione del cavernicolo homo homini lupus. Vi pare un modo fondato di argomentare, questo?
Nel suo “Il prezzo della separazione” (“Il Sole 24 Ore”, 18 settembre 2014) Jeffrey D. Sachs ha invece ipotizzato una secessione della Scozia, con la vittoria dei si, che non avrebbe procurato choc sistemici nella misura in cui le parti in causa avessero accettato di gestire il processo in modo ragionevole e senza pretese esorbitanti o ricatti. Convengo con lui “che i costi della separazione sono una questione di scelte, non frutto di qualcosa di inevitabile” come invece pretende l’incallito pianificatore.
Ecco le cose buone del referendum scozzese. Di una storia che in ogni caso avrà, con il suo prosieguo, altre cose – buone e meno buone – da insegnarci.