Il giornalista Glenn Greenwald, vincitore con il Guardian del Premio Pulitzer per il reportage con Edward Snowden su alcuni programmi segreti di intelligence, si è dimesso da The Intercept, il giornale che aveva co-fondato perché fosse una voce libera e indipendente e come tale potesse essere la casa di tanti freelance indipendenti, difficilmente pubblicati altrove.
Si è dimesso, perché gli è stato censurato un articolo su Biden e il figlio di Biden e perché a suo dire ormai The Intercept non è più quello di un tempo. È diventato un normale media che si posiziona tra idee liberal e sinistra moderata, sostiene attivamente Biden e ha paura di fare brutta figura nella “buona società” dei media mainstream liberal progressisti.
Sotto trovate la sua lettera di dimissioni, che non è solo una denuncia di quello che è diventato The Intercept, ma di quello che sono diventati tutti i media americani.
LE MIE DIMISSIONI DA “TNE INTERCEPT”
di GLENN GREENWALD
Oggi ho inviato la mia lettera di dimissioni da The Intercept, il giornale che ho fondato nel 2013 con Jeremy Scahill e Laura Poitras, nonché dalla società madre First Look Media.
L’ultima ragione, che mi ha fatto infine decidere, è che i redattori di The Intercept, in violazione del mio diritto contrattuale alla libertà editoriale, hanno censurato un articolo che ho scritto questa settimana, rifiutando di pubblicarlo a meno che non avessi eliminato tutte le sezioni critiche del candidato democratico alla presidenza Joe Biden, sostenuto con veemenza da tutti i redattori newyorkesi di Intercept, coinvolti in questo sforzo di censura.
L’articolo censurato, basato sulle e-mail e le testimonianze uscite di recente, ha sollevato questioni critiche sulla condotta di Biden. Non contenti di impedirne semplicemente la pubblicazione presso il giornale che ho co-fondato, questi redattori di Intercept mi hanno anche chiesto di astenermi dall’esercitare un altro diritto contrattuale, quello di pubblicare l’articolo su un’altra pubblicazione.
Non ho alcuna obiezione al loro disaccordo con le mie opinioni su ciò che quanto uscito su Biden dimostra: come ultimo tentativo di evitare di essere censurato, li ho incoraggiati ad esprimere il loro disaccordo, scrivendo degli articoli critici rispetto al mio punto di vista e lasciando ai lettori il compito di decidere chi ha ragione, come farebbe qualsiasi media sicuro di sé e in buona salute. Ma i media moderni non mandano in onda il dissenso, lo reprimono. Quindi la censura del mio articolo, piuttosto che il confronto con esso, è stata la strada scelta da questi sostenitori di Biden.
L’articolo censurato sarà pubblicato a breve su questa pagina (è ora pubblicato qui, e qui invece ci sono le e-mail dei redattori di Intercept che dimostrano la censura). La mia lettera di dimissioni, che ho inviato questa mattina al presidente di First Look Media, Michael Bloom, è pubblicata qui sotto.
A partire da ora, pubblicherò i miei articoli qui su Substack, dove numerosi altri giornalisti, tra cui il mio buon amico, il grande e intrepido reporter Matt Taibbi, sono già venuti, per praticare un giornalismo libero dal clima sempre più repressivo che sta inghiottendo i principali media di tutto il Paese.
Non è stata una scelta facile: sto sacrificando volontariamente il sostegno di una grande organizzazione e uno stipendio garantito in cambio di nient’altro che la convinzione che ci siano abbastanza persone che credono nelle virtù del giornalismo indipendente e nella necessità di un discorso libero che saranno disposte a sostenere il mio lavoro abbonandosi.
Come chiunque abbia figli piccoli, una famiglia e numerosi obblighi, lo faccio con una certa trepidazione, ma anche con la convinzione che non ci sia altra scelta. Non riuscivo a dormire la notte sapendo di aver permesso a una qualche istituzione di censurare ciò che volevo dire e in cui credevo – tanto meno a un mezzo di comunicazione che ho co-fondato con l’esplicito obiettivo di garantire che questo non accada mai agli altri giornalisti, figuriamoci a me, figuriamoci perché ho scritto un articolo critico su un potente politico democratico sostenuto con veemenza dai redattori nelle imminenti elezioni nazionali.
Ma queste patologie, illiberalismo e mentalità repressiva, che hanno portato allo spettacolo bizzarro del mio essere censurato dal mio stesso canale mediatico non sono assolutamente uniche di The Intercept. Questi sono i virus che hanno contaminato praticamente tutte le principali organizzazioni politiche di centro-sinistra, le istituzioni accademiche e le redazioni. Ho iniziato a scrivere di politica quindici anni fa con l’obiettivo di combattere la propaganda e la repressione mediatiche, e – indipendentemente dai rischi che comporta – semplicemente non posso accettare alcuna situazione, per quanto sicura o lucrativa, che mi costringa a sottomettere il mio giornalismo e il mio diritto di libera espressione alle sue soffocanti costrizioni e ai suoi dogmatici dettami.
Da quando ho iniziato a scrivere di politica nel 2005, la libertà giornalistica e l’indipendenza editoriale sono state qualcosa di sacrosanto per me. Quindici anni fa, quando lavoravo ancora come avvocato, ho creato un blog su Blogspot: non con la speranza o il progetto di iniziare una nuova carriera come giornalista, ma proprio come cittadino preoccupato di ciò che vedevo accadere con la Guerra al Terrore e sulle libertà civili, e desideroso di esprimere ciò che credevo fosse importante che la gente ascoltasse. È stato un lavoro fatto per amore, e basato su un’etica di dedizione alla causa e convinzione, dipendente dalla garanzia di una completa libertà editoriale.
Ha prosperato perché i lettori che ho saputo riunire sapevano che, anche quando erano in disaccordo con le particolari opinioni che esprimevo, ero una voce libera e indipendente, non legata a nessuna fazione, non controllata da nessuno, che cercava di essere la più onesta possibile su ciò che vedeva, e sempre incuriosita dalla saggezza di vedere le cose in modo diverso. Il titolo che scelsi per quel blog, “Unclaimed Territory”, rifletteva quello spirito di liberazione dalla prigionia di qualsiasi dogma politico o intellettuale e da qualsiasi vincolo istituzionale.
Quando Salon mi ha offerto un lavoro come editorialista nel 2007, e poi di nuovo quando il Guardian ha fatto lo stesso nel 2012, ho accettato le loro offerte a condizione che avessi il diritto, tranne in situazioni strettamente definite (come articoli passibili di creare responsabilità legali per l’emittente), di pubblicare i miei articoli e le mie rubriche direttamente senza censure, interferenze editoriali, o qualsiasi altra necessità di approvazione e consenso. Entrambi i giornali hanno rinnovato il loro sistema di pubblicazione per soddisfare questa condizione, e nel corso dei molti anni in cui ho lavorato con loro, hanno sempre rispettato questi impegni.
Quando ho lasciato il Guardian all’apice del reportage con Snowden nel 2013 per creare un nuovo media, non l’ho fatto, inutile dirlo, per imporre a me stesso ulteriori vincoli e restrizioni alla mia indipendenza giornalistica. Se mai l’esatto contrario: l’innovazione di base di The Intercept era soprattutto quella di creare un nuovo mezzo di comunicazione in cui giornalisti di talento e responsabili potessero godere dello stesso diritto di libertà editoriale che ho sempre preteso per me stesso. Come ho detto all’ex direttore esecutivo del New York Times Bill Keller in uno scambio del 2013 che abbiamo avuto sul New York Times a proposito delle mie critiche al giornalismo mainstream e sull’idea alla base di The Intercept: “I redattori dovrebbero essere lì per dare potere e consentire un forte giornalismo antagonista, altamente fattuale e aggressivo, non per ostacolare, sterilizzare o sopprimere il giornalismo”.
Quando noi tre, come co-fondatori, abbiamo deciso in anticipo che non avremmo tentato di gestire le operazioni quotidiane del nuovo giornale, per poterci invece concentrare sul nostro giornalismo, abbiamo negoziato il diritto di approvazione per i redattori senior e, soprattutto, per il caporedattore. La responsabilità centrale di chi deteneva tale titolo era implementare, in stretta consultazione con noi, la visione e i valori giornalistici unici su cui abbiamo fondato questo nuovo media.
Tra questi valori spiccavano la libertà editoriale, la tutela del diritto di un giornalista di parlare con voce onesta, e la diffusione, piuttosto che la soppressione del dissenso dalle ortodossie tradizionali e persino dei disaccordi tra noi colleghi. Ciò sarebbe stato realizzato, soprattutto, assicurando che i giornalisti, una volta compiuto il loro primo dovere rispetto all’accuratezza dei fatti e all’etica giornalistica, non solo sarebbero stati autorizzati, ma sarebbero stati incoraggiati a esprimere opinioni politiche e ideologiche che si discostassero dall’ortodossia tradizionale e da quelle dei loro stessi editori; ad esprimersi con la propria voce e con passione e convinzione piuttosto che con il tono corporativo e artificioso dell’obiettività artificiale, senso di superiorità e onniscienza; e ad essere completamente liberi da convinzioni dogmatiche o agende ideologiche di chiunque altro, compresi i tre co-fondatori.
L’attuale pratica di The Intercept è completamente irriconoscibile se paragonata a quella visione originale. Piuttosto che offrire un luogo per esprimere dissenso, voci emarginate e prospettive inascoltate, sta rapidamente diventando solo un altro media con una fedeltà ideologica e partigiana obbligatoria, una gamma rigida e ristretta di punti di vista consentiti (che vanno dalle idee liberal dell’establishment alla sinistra moderata, ma sempre ancorata al sostegno finale del Partito Democratico), una profonda paura di offendere le idee dei liberal culturalmente egemoni e dei luminari di Twitter di centro-sinistra, e un bisogno generale di assicurarsi l’approvazione e l’ammirazione dei media mainstream, proprio quelli che abbiamo creato The Intercept per contrastare, criticare e sovvertire.
Di conseguenza, è un evento raro, in effetti, quando la voce radicale di un freelance non gradito nei media mainstream viene pubblicata su The Intercept. I reporter o gli scrittori esterni che non hanno alcuna pretesa di essere accettati dal mainstream – esattamente le persone cui avevamo deciso di dare un megafono – non hanno quasi nessuna possibilità di essere pubblicati. È ancora più raro che The Intercept pubblichi contenuti che non si adatterebbero molto bene ad almeno una dozzina o più di pubblicazioni di centro-sinistra di dimensioni simili che hanno preceduto la sua fondazione, da Mother Jones a Vox e persino a MSNBC.
Ci vuole coraggio per fare un passo fuori dalla linea, per mettere in discussione e punzecchiare le convinzioni più sacre del proprio ambiente, ma la paura di alienarsi i guardiani dell’ortodossia liberal, soprattutto su Twitter, è l’attributo predominante del team editoriale, con sede a New York, che guida The Intercept. Di conseguenza, The Intercept ha praticamente abbandonato la sua missione principale, che consisteva nello sfidare l’ortodossia e nel ficcare il naso, piuttosto che nel tranquillizzare e confortare le istituzioni e i guardiani dei vari circoli culturali e politici.
A peggiorare tutto questo, The Intercept – pur escludendo gradualmente i cofondatori da qualsiasi ruolo editoriale o di direzione, e facendo una dopo l’altra scelte a cui mi sono opposto perché tradivano la nostra missione principale – ha continuato pubblicamente a usare il mio nome per raccogliere fondi per un giornalismo che sapeva che non supportavo. Ha volutamente permesso che si diffondesse la percezione che io fossi la persona responsabile dei suoi errori giornalistici, per far sì che la colpa di quegli errori ricadesse su di me, piuttosto che sui redattori che stavano consolidando il controllo e che ne erano responsabili.
L’esempio più eclatante, ma non il solo, di come hanno sfruttato il mio nome per sottrarsi alle responsabilità è stata la debacle di Reality Winner. Come ha recentemente riportato il New York Times, si è trattato di una storia in cui non ho avuto alcun coinvolgimento. Pur essendo di base in Brasile, non mi è mai stato chiesto di lavorare sui documenti che Winner ha inviato alla nostra redazione di New York, senza alcuna richiesta che nessun giornalista specifico ci lavorasse. Sono venuto a conoscenza dell’esistenza di quel documento solo poco prima della sua pubblicazione. La persona che ha supervisionato, curato e controllato quella storia è stata Betsy Reed, che era proprio ciò che doveva avvenire data la grandezza e la complessità di quel reportage e la sua posizione di caporedattrice.
Sono stati i redattori di The Intercept a fare pressione sui reporter affinché inviassero rapidamente quei documenti al governo per l’autenticazione – perché erano ansiosi di dimostrare ai media mainstream e ai liberal di spicco che The Intercept era disposta a salire a bordo del treno del Russiagate. Volevano contrastare la percezione, creata dai miei articoli che esprimevano scetticismo sulle affermazioni centrali di quello scandalo, che l’Intercept avesse superato il limite su una storia di grande importanza per i liberal statunitensi e per la sinistra. Quel desiderio – di ottenere l’approvazione dei media mainstream che ci eravamo proposti di contrastare – è stata la causa principale della velocità e dell’incoscienza con cui è stato trattato il documento di Winner.
Ma The Intercept, fino ad oggi, si è rifiutato di fornire un resoconto pubblico di quanto accaduto con la storia di Reality Winner: di spiegare chi erano i redattori che hanno commesso gli errori e perché è successo. Come chiarisce l’articolo del New York Times, questo rifiuto persiste ancora oggi, nonostante le mie insistenti richieste, di Scahill, Laura Poitras e di altri, secondo cui The Intercept, in quanto esige trasparenza dagli altri, ha l’obbligo di fornirla lei stessa.
Il motivo di questo silenzio e di questo insabbiamento è ovvio: rendere conto al pubblico di quello che è successo con la storia di Reality Winner rivelerebbe chi sono i veri redattori responsabili di quell’imbarazzante fallimento, e ciò negherebbe la loro capacità di continuare a nascondersi dietro di me e lasciare che il pubblico continui a credere che io sia la persona colpevole di qualcosa in cui non c’entro nulla fin dall’inizio. Questo è solo un esempio che illustra il frustrante dilemma di far sì che una redazione sfrutti il mio nome, il mio lavoro e la mia credibilità quando conviene, negandomi sempre più spesso la possibilità di influenzare il suo indirizzo e la sua direzione editoriale, il tutto perseguendo una missione editoriale completamente antitetica rispetto a ciò in cui credo.
Nonostante tutto questo, non volevo lasciare The Intercept. Mentre si deteriorava e abbandonava la sua missione originaria, ho pensato tra me e me – forse razionalizzando – che finché The Intercept avesse almeno continuato a fornirmi le risorse per poter fare io personalmente il giornalismo in cui credo, senza interferire o ostacolare la mia libertà editoriale, avrei potuto ingoiare tutto il resto.
Ma la brutale censura avvenuta questa settimana del mio articolo – sui materiali riguardanti Hunter Biden e sulla condotta di Joe Biden riguardo all’Ucraina e alla Cina, così come la mia critica al tentativo dei media di serrare i ranghi per sopprimere queste rivelazioni, in un’unione profondamente empia con la Silicon Valley e la “comunità d’intelligence”, ha eroso l’ultima giustificazione a cui potevo aggrapparmi per restare. Significava che non solo questo giornale non fornisce la libertà editoriale agli altri giornalisti, come avevo sperato sette anni fa, ma ormai non la fornisce più nemmeno a me. Nei giorni che precedono le elezioni presidenziali, vengo in qualche modo messo a tacere, mi viene impedito di esprimere un’opinione che i redattori di New York trovano sgradevole, e ora devo in qualche modo conformare la mia scrittura e il mio reportage ai loro desideri partigiani e alla loro volontà di sostenere l’elezione di specifici candidati.
Dire che una simile censura è per me una linea rossa, una situazione che non accetterei mai, a prescindere dal prezzo da pagare, è un eufemismo. È sorprendente per me, ma è anche un riflesso della situazione attuale del nostro discorso pubblico e della attuale illiberalità dell’ambiente mediatico, che io sia stato messo a tacere su Joe Biden dal mio stesso giornale.
Numerosi altri episodi hanno contribuito alla mia decisione di andarmene: l’insabbiamento di quanto accaduto sul caso Reality Winner; la decisione di impiccare Lee Fang e di costringerlo a scusarsi quando un collega ha cercato di distruggere la sua reputazione bollandolo pubblicamente, senza fondamento e ripetutamente come razzista; il rifiuto di riferire sull’avanzamento quotidiano dell’udienza per l’estradizione di Assange perché il reporter freelance sul caso, che faceva un lavoro eccezionale, era politicamente di cattivo gusto; la totale mancanza di standard editoriali quando si tratta di punti di vista o di reportage che lusingano le credenze della sua base liberal (The Intercept ha pubblicato alcune fra le più assurde e false affermazioni proprie della follia massimalista anti russa, e, spaventosamente, ha preso l’iniziativa di bollare l’archivio della vicenda Hunter Biden come “disinformazione russa”, citando in modo acritico – tra tutte le cose – una lettera di alcuni ex funzionari della CIA che conteneva questa insinuazione senza darle alcun fondamento).
So che sembra banale da dire, ma – pur con tutte queste frustrazioni e fallimenti – me ne vado, e scrivo queste cose, con vera tristezza, non con rabbia. Per dare vita a quel giornale io e numerosi amici e colleghi abbiamo riversato una quantità enorme del nostro tempo, energia, passione e amore.
L’Intercept ha fatto un grande lavoro. I suoi capi editoriali e i manager di First Look hanno sostenuto con fermezza il difficile e pericoloso reportage che ho fatto l’anno scorso con i miei coraggiosi giovani colleghi di The Intercept Brasil per denunciare la corruzione ai più alti livelli del governo di Bolsonaro, e sono rimasti dietro di noi mentre subivamo minacce di morte e di prigionia.
Continua ad impiegare alcuni dei miei più cari amici, giornalisti d’eccezione il cui lavoro – quando supera le resistenze editoriali – non suscita in me che la più alta ammirazione: Jeremy Scahill, Lee Fang, Murtaza Hussain, Naomi Klein, Ryan Grim e altri. Non ho alcun risentimento personale per nessuno di loro, né alcun desiderio di ferire The Intercept come istituzione. Betsy Reed è una redattrice eccezionalmente intelligente e un’ottima persona con la quale ho sviluppato una stretta e preziosa amicizia. E Pierre Omidyar, il finanziatore ed editore originario di First Look, ha sempre onorato il suo impegno personale a non interferire mai nel nostro processo editoriale, anche quando pubblicavo articoli direttamente in contrasto con le sue forti convinzioni e anche quando attaccavo altre istituzioni che lui finanziava. Non me ne vado per vendetta o conflitto personale, ma per convinzione.
E nessuna delle critiche che ho espresso su The Intercept è solo per lui. Al contrario: queste sono le battaglie che infuriano oggi, per la libertà di espressione e il diritto al dissenso, all’interno di ogni grande istituzione culturale, politica e giornalistica. Questa è la crisi che il giornalismo, e più in generale i valori del liberalismo, stanno affrontando. Il nostro discorso pubblico sta diventando sempre più intollerante nei confronti delle opinioni dissenzienti, e la nostra cultura chiede sempre più sottomissione alle ortodossie prevalenti imposte dai monopolisti della Verità e della Giustizia, sostenuti da eserciti di forze dell’ordine online.
E nulla è paralizzato da questa tendenza in modo più grave del giornalismo, che, più di ogni altra cosa, richiede la capacità dei giornalisti di offendere e di far arrabbiare i centri di potere, di mettere in discussione o di rifiutare ogni dogma, di dissotterrare fatti che si riflettono negativamente anche (soprattutto) sulle figure più amate e potenti, e di mettere in evidenza la corruzione, indipendentemente da dove si trova e da chi ne trae vantaggio o ne viene ferito.
Prima della straordinaria esperienza di essere censurato questa settimana dalla mia stessa testata giornalistica, avevo già esplorato la possibilità di creare un nuovo media. Ho trascorso un paio di mesi in discussioni attive con alcuni dei giornalisti, scrittori e commentatori più interessanti, indipendenti e vivaci di tutto lo spettro politico, sulla fattibilità di finanziare un nuovo media che sarebbe stato progettato per combattere queste tendenze. I primi due paragrafi del nostro documento di lavoro recitano quanto segue:
I media americani sono coinvolti in una guerra culturale polarizzata che sta costringendo il giornalismo a conformarsi a narrazioni tribali e di gruppo, spesso divorziate dalla verità e che non riflettono il pubblico più ampio, ma una minoranza di élite iper-partigiane. La necessità di conformarsi a narrazioni culturali e identità di parte altamente restrittive e artificiali ha creato un ambiente repressivo e illiberale in cui vaste fasce di notizie e reportage non vengono coperte o sono presentate attraverso una lente del tutto distorta e distaccata della realtà.
Con quasi tutte le principali istituzioni mediatiche catturate in qualche modo da questa dinamica, esiste un profondo bisogno di mezzi di comunicazione che siano liberi e liberi di trasgredire i confini di questa guerra culturale polarizzata e di rispondere alla domanda di un pubblico affamato di un giornale che non giochi a favore di una parte e che invece persegua le sue piste di reportage, di pensiero e di indagine ovunque esse conducano, senza timore di violare gli altarini sacri della cultura o le ortodossie dell’élite.
Non ho assolutamente abbandonato la speranza che questo ambizioso progetto possa essere realizzato. E teoricamente avrei potuto rimanere all’Intercept fino ad allora, garantendo un reddito stabile e sicuro alla mia famiglia, ingoiando le imposizioni dei miei nuovi censori.
Ma mi vergognerei profondamente se lo facessi, e credo che tradirei i miei principi e le stesse convinzioni che esorto gli altri a seguire. Così, nel frattempo, ho deciso di seguire le orme di numerosi altri scrittori e giornalisti che sono stati espulsi da circoscrizioni giornalistiche sempre più repressive per varie forme di eresia e dissenso e che qui hanno cercato rifugio.
Spero di poter sfruttare la libertà che questa nuova piattaforma offre non solo per continuare a pubblicare il giornalismo d’inchiesta indipendente e incisivo e le candide analisi e opinioni che i miei lettori si aspettano, ma anche per sviluppare un podcast, e continuare il programma di YouTube, “System Update”, che ho lanciato all’inizio di quest’anno in collaborazione con The Intercept.
Per fare questo, per rendere possibile tutto ciò, avrò bisogno del vostro sostegno: le persone in grado di abbonarsi e di iscriversi alla newsletter allegata a questa piattaforma permetteranno al mio lavoro di prosperare e di essere ascoltato, forse anche più di prima. Ho iniziato la mia carriera di giornalista dipendendo dalla volontà dei miei lettori di sostenere il giornalismo indipendente che ritengono necessario sostenere. È un po’ scoraggiante a questo punto della mia vita, ma anche molto emozionante, tornare a quel modello in cui si risponde solo al pubblico che è il padrone che un giornalista dovrebbe servire.
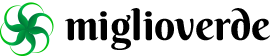



Chapeau! Ce ne fossero di personaggi cosi’!