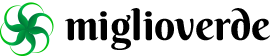di LUDWIG VON MISES
[Questo saggio venne originalmente pubblicato come “Die Legende von Versagen des Kapitalismus” in Der Internationale Kapitalismus und die Krise, Festschrift für Julius Wolf (1932)[1]]
L’opinione quasi universale espressa in questi giorni è che la crisi economica degli ultimi anni abbia segnato la fine del capitalismo. Il capitalismo ha fallito, si è dimostrato incapace di risolvere i problemi economici e così l’uomo non ha altra alternativa, se vuole sopravvivere, che optare per un’economia pianificata.
Questa non è certo un’idea nuova. I socialisti hanno sempre sostenuto che le crisi economiche sono il risultato inevitabile del metodo di produzione capitalistico, e che non vi è altro mezzo per eliminare le crisi economiche se non con una transizione verso il socialismo. Se queste affermazioni sono espresse con più forza in questi giorni e suscitano una maggiore risposta della popolazione, non è perché la crisi attuale è più lunga o più profonda rispetto a quelle precedenti, ma perché l’opinione pubblica di oggi è molto più influenzata dalle idee socialiste di quanto non lo fosse nei decenni passati.
I
Quando non esisteva la teoria economica, la convinzione era che chi avesse il potere ed era determinato ad usarlo poteva fare qualsiasi cosa. I governanti, ai fini del loro benessere spirituale e con uno sguardo verso la loro ricompensa in cielo, venivano ammoniti dai loro sacerdoti affinché moderassero l’uso del potere. Inoltre, non si trattava di una questione di ciò che limita le condizioni della vita umana e della natura di questo potere, ma piuttosto che fossero considerati senza limiti ed onnipotenti nella sfera degli affari sociali.
La fondazione delle scienze sociali, il lavoro di un gran numero di grandi intelletti, fra cui David Hume ed Adam Smith tra i più eccezionali, ha distrutto questa concezione. Uno scoprì che il potere sociale era di tipo spirituale e non (come si credeva) materiale, nel senso stretto della parola. Ed esisteva la comprensione di una coerenza necessaria nei fenomeni di mercato, cosa che il potere non è in grado di distruggere. Emerse anche una presa di coscienza sull’esistenza di qualcosa di operativo nel settore sociale, che i potenti non potevano influenzare ed a cui dovevano arrendersi, proprio come dovevano adeguarsi alle leggi della natura. Nella storia del pensiero umano e della scienza non esiste altra scoperta più grande.
Se si procede da questo riconoscimento delle leggi del mercato, la teoria economica dimostra che tipo di situazione emerge dall’interferenza della forza e del potere nei processi di mercato. L’intervento isolato non può raggiungere il fine per cui lottano le autorità e deve portare a conseguenze che sono indesiderabili dal loro punto di vista. Anche dal punto di vista delle autorità stesse l’intervento è inutile e dannoso. Procedendo da questa percezione, se si vuole organizzare l’attività di mercato in base alle conclusioni del pensiero scientifico — e riflettiamo su tali questioni non solo perché siamo alla ricerca di conoscenza, ma anche perché vogliamo organizzare le nostre azioni in modo tale da poter raggiungere gli obiettivi a cui aspiriamo — allora si arriva inevitabilmente al rifiuto di tali interventi marchiandoli come superflui, inutili e dannosi, una nozione che caratterizza l’insegnamento liberale. Il liberalismo non vuole portare standard di valore nella scienza; vuole prendere dalla scienza una bussola per le azioni di mercato. Il liberalismo utilizza i risultati della ricerca scientifica per costruire una società in grado di realizzare più efficacemente possibile gli scopi che intende realizzare. I partiti politico-economici non si differenziano in base al risultato finale per il quale lottano, ma in base ai mezzi che devono utilizzare per raggiungere il loro obiettivo comune. I liberali sono del parere che la proprietà privata dei mezzi di produzione sia l’unico modo per creare ricchezza per tutti, perché considerano il socialismo impraticabile e perché credono che il sistema di interventismo (che secondo il parere dei suoi sostenitori è una via di mezzo tra capitalismo e socialismo) non possa raggiungere gli obiettivi dei suoi proponenti.
La visione liberale ha trovato una dura opposizione. Ma gli avversari del liberalismo non sono riusciti ad indebolire la sua teoria di base, né l’applicazione pratica di questa teoria. Non hanno cercato di difendersi dalle critiche schiaccianti che i liberali hanno mosso contro i loro piani; le hanno semplicemente evase. I socialisti si consideravano avulsi da questa critica, perché il Marxismo aveva dichiarato eretica l’efficacia di un commonwealth socialista ed aveva evocato un certo distacco dall’establishment; hanno continuato ad amare lo stato socialista come il paradiso in terra, ma hanno rifiutato di impegnarsi in una discussione sui dettagli del loro piano. Gli interventisti hanno scelto un’altra strada. Su basi insufficienti, hanno contestato la validità universale della teoria economica. Non essendo in grado di contestare con la logica la teoria economica, non potevano far riferimento ad altro se non ad un po’ di “pathos morale,” di cui hanno parlato alla riunione della Vereins für Sozialpolitik [Associazione per la Politica Sociale] a Eisenach. Al posto della logica hanno inserito il moralismo, al posto della teoria emotiva i pregiudizi, al posto del ragionamento il riferimento alla volontà dello stato.
 La teoria economica ha predetto gli effetti dell’interventismo e del socialismo statale e municipale. Tutti gli avvertimenti sono stati ignorati. Per 50 o 60 anni la politica dei paesi Europei è stata anticapitalista ed antiliberale. Più di 40 anni fa Sidney Webb (Lord Passfield) ha scritto, ora si può ragionevolmente sostenere che la filosofia socialista di oggi non è che l’affermazione cosciente ed esplicita dei principi di organizzazione sociale che sono già stati in gran parte adottati inconsciamente. La storia economica di questo secolo è un record quasi continuo dei progressi del Socialismo.[2]
La teoria economica ha predetto gli effetti dell’interventismo e del socialismo statale e municipale. Tutti gli avvertimenti sono stati ignorati. Per 50 o 60 anni la politica dei paesi Europei è stata anticapitalista ed antiliberale. Più di 40 anni fa Sidney Webb (Lord Passfield) ha scritto, ora si può ragionevolmente sostenere che la filosofia socialista di oggi non è che l’affermazione cosciente ed esplicita dei principi di organizzazione sociale che sono già stati in gran parte adottati inconsciamente. La storia economica di questo secolo è un record quasi continuo dei progressi del Socialismo.[2]
L’inizio di tale processo lo troviamo in Inghilterra, dove il liberalismo è stato in grado di tenere a bada per lungo tempo le politiche economiche anticapitaliste. Da allora le politiche interventiste hanno fatto passi da gigante. In generale, l’opinione di oggi è che viviamo in un’epoca in cui regna “un’economia ostacolata” — precursore della coscienza socialista collettiva del futuro. Ora, poiché è accaduto ciò che la teoria economica ha predetto, poiché sono venuti alla luce i frutti delle politiche economiche anticapitaliste, si leva un grido da tutte le parti: questo è il declino del capitalismo, il sistema capitalistico ha fallito!
Il liberalismo non può essere ritenuto responsabile per l’atteggiamento che le istituzioni perseguono con le politiche economiche di oggi. (il liberalismo) Era contrario alla nazionalizzazione e alla messa sotto il controllo comunale di quei progetti che ora si dimostrano catastrofici per il settore pubblico ed una fonte di sporca corruzione; era contrario alla negazione di protezione per coloro che erano disposti a lavorare e contrario al potere dello stato messo a disposizione dei sindacati, contrario all’indennità di disoccupazione che ha reso la disoccupazione un fenomeno permanente ed universale, contrario alla previdenza sociale che ha reso gli assicurati dei brontoloni, dei finti malati e dei nevrastenici, contrario ai dazi (ed implicitamente contrario ai cartelli), contrario alla limitazione della libertà di vivere, di viaggiare, di studiare, contrario alla tassazione eccessiva e contrario all’inflazione, contrario agli armamenti, contrario alle acquisizioni coloniali, contrario all’oppressione delle minoranze, contrario all’imperialismo e contrario alla guerra. Ha innalzato una resistenza ostinata contro la politica del consumo del capitale. E il liberalismo non ha creato il partito delle truppe armate che aspetta solo la possibilità conveniente di iniziare una guerra civile.
II
La linea di ragionamento che porta ad incolpare il capitalismo, almeno per alcune di queste cose, si basa sulla nozione che gli imprenditori ed i capitalisti non sono più liberali, ma interventisti e statalisti. Ciò è corretto, ma le conclusioni che la genete ne trae sono sbagliate. Queste deduzioni derivano dal punto di vista Marxista del tutto insostenibile secondo cui imprenditori e capitalisti proteggono i loro interessi di classe attraverso il liberalismo quando il capitalismo prospera ma ora, alla fine del periodo capitalista e al suo declino, li proteggono attraverso l’interventismo. Questa dovrebbe essere la prova che “l’economia ostacolata” dell’interventismo è l’economia storicamente necessaria nella fase del capitalismo in cui ci troviamo oggi. Ma il concetto di economia classica e di liberalismo come ideologia (nel senso Marxista del termine) della borghesia è una delle molte tecniche distorte del Marxismo. Se imprenditori e capitalisti erano pensatori liberali intorno al 1800 in Inghilterra e pensatori interventisti, statalisti e socialisti intorno al 1930 in Germania, il motivo è che gli imprenditori ed i capitalisti sono anche affascinati dalle idee prevalenti dei tempi. Nel 1800, come anche nel 1930, gli imprenditori avevano interessi particolari che sono stati protetti dall’interventismo e danneggiati dal liberalismo.
Oggi i grandi imprenditori sono spesso citati come “leader economici”. La società capitalistica non conosce alcun “leader economico.” Questa è la differenza tra le economie socialiste da un lato e le economie capitalistiche dall’altro: in quest’ultime, gli imprenditori ed i proprietari dei mezzi di produzione non seguono alcuna leadership salvo quella del mercato. L’usanza di citare iniziatori di grandi imprese come leader economici già ci fa capire come in questi giorni uno non raggiunga queste posizioni attraverso il successo economico, ma piuttosto con altri mezzi.
Nello stato interventista non è più di importanza cruciale, per il successo di un’impresa, che le operazioni siano eseguite in modo tale che le esigenze del consumatore vengano soddisfatte nel modo migliore e meno costoso possibile; è molto più importante che uno abbia ” buoni rapporti” con le fazioni politiche al comando, che gli interventi vadano a vantaggio e non a svantaggio dell’impresa. Alcuni ritengono che la produzione dell’impresa sia degna di protezione tariffaria, altri (in misura inferiore) ritengono che la protezione tariffaria degli input possa aiutare di più l’impresa rispetto alla prudenza nello svolgere le operazioni. Un’impresa può essere ben gestita, ma fallirà se non sa come proteggere i propri interessi mediante le tariffe, i negoziati salariali davanti ai collegi arbitrali, ed i cartelli. E’ molto più importante avere “connessioni” piuttosto che produrre bene ed a buon mercato. Di conseguenza, gli uomini che raggiungono la vetta di tali imprese non sono quelli che sanno come organizzare le operazioni di produzione e direzionarle secondo la richiesta del mercato, ma piuttosto gli uomini che sanno come andare d’accordo con la stampa e con tutti i partiti politici, in particolare con i radicali, in modo tale che i loro rapporti non causino offesa. Si tratta di quella classe di direttori generali che si occupa di più dei dignitari federali e dei dirigenti di partito piuttosto che di coloro da cui acquistano o a cui vendono.
 Poiché molte imprese dipendono da favori politici, coloro che intraprendono tali imprese devono rimborsare i politici con altri favori. Non c’è stata alcuna grande impresa negli ultimi anni che non abbia dovuto spendere somme considerevoli per operazioni che fin dall’inizio erano chiaramente non redditizie, ma che, nonostante le perdite attese, dovevano essere concluse per motivi politici. Per non parlare dei contributi a questioni non imprenditoriali — fondi elettorali, istituzioni sociali/pubbliche e simili.
Poiché molte imprese dipendono da favori politici, coloro che intraprendono tali imprese devono rimborsare i politici con altri favori. Non c’è stata alcuna grande impresa negli ultimi anni che non abbia dovuto spendere somme considerevoli per operazioni che fin dall’inizio erano chiaramente non redditizie, ma che, nonostante le perdite attese, dovevano essere concluse per motivi politici. Per non parlare dei contributi a questioni non imprenditoriali — fondi elettorali, istituzioni sociali/pubbliche e simili.
La strada verso l’indipendenza degli amministratori delle grandi banche, delle imprese industriali e delle società di capitali si sta affermando con più forza. Questa “tendenza delle grandi imprese a socializzarsi,” cioè, a lasciare che altri interessi tranne “il più alto rendimento possibile per gli azionisti” determinino la gestione delle imprese, è stata accolta dagli scrittori statalisti come un segno che abbiamo già sorpassato il capitalismo.[3] Nel corso della riforma dei diritti azionari Tedeschi, sono stati addirittura utilizzati sforzi legali per mettere l’interesse e il benessere dell’imprenditore, vale a dire “la sua autostima economica, giuridica, e sociale e la sua indipendenza rispetto alla maggioranza degli azionisti che cambiano,”[4] al di sopra di quelli dei soci.
Con l’influenza dello stato dietro di loro e supportati da un’opinione pubblica interventista, i leader delle grandi imprese si sentono così forti in relazione agli azionisti che credono di non dover necessariamente tener conto dei loro interessi. Nella loro gestione delle imprese in quei paesi in cui lo statalismo ha un governo più forte, — per esempio nei nuovi stati del vecchio impero Austro-Ungarico — sono tanto incuranti della redditività quanto i gestori delle utenze pubbliche. Il risultato è la rovina. La teoria che è stata avanzata sostiene che queste imprese sono troppo importanti per essere gestite con un punto di vista rivolto al profitto. Questo concetto è straordinariamente opportuno ogni volta che la conduzione degli affari, in rinuncia della redditività, sfocia nel fallimento dell’impresa. E’ opportuno perché in questa circostanza la suddetta teoria richiede l’intervento dello stato affinché sostenga le imprese che sono dichiarate troppo grandi per fallire.
III
E’ vero che socialismo ed interventismo non sono ancora riusciti ad eliminare completamente il capitalismo. Se lo avessero fatto, noi Europei, dopo secoli di prosperità, avremmo riscoperto il senso della fame su vasta scala. Il capitalismo è ancora abbastanza prominente poiché stanno nascendo nuove industrie, e quelle già esistenti stanno migliorando e ampliando le loro attrezzature ed operazioni. Tutti i progressi economici che sono stati raggiunti e saranno raggiunti derivano dal residuo persistente del capitalismo nella nostra società. Ma il capitalismo è sempre vessato dall’intervento del governo e deve pagare fiscalmente, con una parte considerevole dei suoi profitti, la produttività inferiore delle imprese pubbliche.
La crisi in cui il mondo è attualmente immerso è la crisi dell’interventismo e del socialismo statale e comunale; in breve, la crisi delle politiche anticapitaliste. La società capitalista è guidata dal meccanismo del mercato. Su tale questione non vi è alcuna differenza di opinione. I prezzi di mercato adeguano l’offerta e la domanda, e determinano la direzione e la portata della produzione. E’ dal mercato che l’economia capitalista riceve il suo senso. Se la funzione del mercato come regolatore della produzione viene sempre ostacolata da politiche economiche atte a determinare prezzi, salari e tassi di interesse, invece di lasciarlo fare al mercato, allora è sicuro che ne scaturirà una crisi.
Non ha fallito Bastiat, ma Marx e Schmoller.
*Traduzione di Francesco Simoncelli Francesco Simoncelli
________________________________________________
Note
[1] Questo saggio è stato tradotto dal Tedesco da Jane E. Sanders, che desidera riconoscere con gratitudine i commenti ed i suggerimenti del Professor John T. Sanders, Rochester Institute of Technology, e del Professor David R. Henderson, University of Rochester, nella preparazione della traduzione.
[2] Cf. Webb, Fabian Essays in Socialism. […] Ed. by G. Bernard Shaw. (American ed., edited by H.G. Wilshire. New York: The Humboldt Publishing Co., 1891) p. 4.
[3] Cf. Keynes, “The End of Laisser-Faire,” 1926, consultare, Essays in Persuasion (New York: W.W. Norton & Co., Inc., 1932) pp. 314–315.
[4] Cf. Passow, Der Strukturwandel der Aktiengesellcschaft im Lichte der Wirtschaftsenquente, (Jena 1939), S.4.