Il neo rieletto Presidente della Regione Veneto: Luca Zaia non vuole perdere altro tempo sul rischio di nuovi ricorsi alla magistratura che mischino per la quarta volta le carte dell’elezione dei Consiglieri regionali, e ha chiesto che non si aspetti un’altra settimana per riconvocare il Consiglio regionale. Ha tuonato: «Si è votato il 31 maggio e nel giro di 20 giorni il Consiglio regionale del Veneto ha subìto tre modifiche. Sono profondamente indignato per la situazione inaccettabile e paradossale che si è venuta a creare». E, in cerca di sostegno alle sue posizioni, si è affidato ai social network dove ottiene in poche ore oltre 1500 segnali di solidarietà. «Quanto sta accadendo oggi – ha proseguito Zaia – è vergognoso ed irrispettoso nei confronti degli eletti ma soprattutto degli elettori che vedono disattendere le scelte compiute nel momento massimo di espressione di una democrazia: il voto. Ricorrerò in tutte le sedi opportune affinché venga fatta chiarezza e la mia squadra possa continuare il percorso intrapreso cinque anni fa per il bene dei veneti».
A nostro modesto parere la mossa di Zaia è semplice fuffa buona per i gonzi. Infatti, la nuova e recentissima legge elettorale della Regione Veneto porta la firma dell’amministrazione uscente presieduta proprio dal leghista Luca Zaia. Se è vero che la magistratura italiana non brilla per la sua efficienza, è altrettanto indiscutibile che opera – in questo caso – su una legge voluta e approvata dallo stesso Zaia. Chi è cagion del suo mal, pianga se stesso… e non ci arronzi con la sua sicumera, aggiungiamo noi!
Ci sono anche molti “quasi-consiglieri” (o che perlomeno si sentono tali) che sono rimasti esclusi, sono furiosi a loro volta e si rivolgeranno probabilmente al TAR perché valuti se in base alla tanto discussa nuova legge elettorale è possibile che loro siano riammessi, ovviamente a discapito di altrettanti loro compagni di lista. Ad esempio, il sindaco Giuseppe Pan di Cittadella (Lega), che si è trovato messo fuori all’ultimo, ha parlato di «attentato alla democrazia. Sono stato promosso dal popolo, ma bocciato dai giudici italiani». È singolare come s’invochi la democrazia quando si devono tutelare gli interessi personali, e la si disattenda quando gli interessi sono collettivi. Riteniamo inutile fare esempi in questa sede.
Dal momento che la società è divisa in uomini che ordinano e uomini che eseguono, tutta la vita sociale è governata dalla lotta per il potere, e la lotta per la sussistenza interviene solo come un fattore della prima, anche se indispensabile. La storia dell’umanità viene a coincidere con la storia dell’asservimento che fa degli uomini, oppressi e oppressori, il puro zimbello degli strumenti di dominio che essi stessi hanno fabbricato, e riduce così l’umanità vivente a essere cosa fra le cose inerti. Di ciò, i sinceri indipendentisti (coloro che hanno interiorizzato il fatto che non è perseguendo la presunta via democratica e istituzionale che otterranno l’autodeterminazione) possono trovare conferma nelle vicende storiche di questo paese.
Prendiamo come esempio la vicenda di Giovanni Guareschi. L’autore di “Don Camillo” (scomparso il 22 luglio 1968) è stato uno degli scrittori italiani più venduti nel mondo: oltre 20 milioni di copie, nonché lo scrittore italiano più tradotto in assoluto. La sua creazione più nota, anche per le trasposizioni cinematografiche è don Camillo appunto. Il “robusto” parroco che parla col Cristo dell’altare maggiore, che ha come antagonista l’agguerrito Sindaco comunista Peppone, in un paese immaginario nella bassa padana, fra il Po e la via Emilia.
 Giovannino Guareschi nel 1950 fu condannato con la condizionale a otto mesi di carcere nel processo per vilipendio al Capo dello Stato, Luigi Einaudi. Alcune vignette sul settimanale «Candido» avevano messo in risalto che Einaudi, sulle etichette del vino di sua produzione (un Nebbiolo), permetteva che venisse messa in evidenza la sua carica pubblica di “Senatore”. Guareschi non era l’autore materiale della vignetta (l’autore fu Carletto Manzoni), ma fu condannato in quanto direttore responsabile del periodico.
Giovannino Guareschi nel 1950 fu condannato con la condizionale a otto mesi di carcere nel processo per vilipendio al Capo dello Stato, Luigi Einaudi. Alcune vignette sul settimanale «Candido» avevano messo in risalto che Einaudi, sulle etichette del vino di sua produzione (un Nebbiolo), permetteva che venisse messa in evidenza la sua carica pubblica di “Senatore”. Guareschi non era l’autore materiale della vignetta (l’autore fu Carletto Manzoni), ma fu condannato in quanto direttore responsabile del periodico.
Nel 1954 Guareschi venne nuovamente condannato per diffamazione su denuncia di Alcide De Gasperi (questi era stato a capo del governo ininterrottamente dal dicembre 1945 al 1953). Guareschi era venuto in possesso di due lettere del politico trentino risalenti al 1944. In una di esse il futuro presidente del Consiglio, che all’epoca viveva a Roma, avrebbe chiesto agli Alleati anglo-americani di bombardare la periferia della città allo scopo di demoralizzare i collaborazionisti dei tedeschi.
Secondo Guareschi le missive erano autentiche. Prima di pubblicarle, aveva sottoposto le lettere addirittura a una perizia calligrafica affidandosi a un’autorità in materia, il dottor Umberto Focaccia. Al processo Giovannino affermò di aver agito in buona fede. Focaccia, perito dello stesso Tribunale di Milano, affermò in aula di avere effettuato un «lungo, attento e scrupoloso esame di confronto con molti altri scritti sicuramente autentici del De Gasperi…», per poi dichiarare «in piena coscienza, di riconoscere per autentiche del De Gasperi la scrittura del testo e la firma di cui sopra.»
Il processo fu rapido. Il 15 aprile Guareschi fu condannato in primo grado a dodici mesi di carcere. Non presentò ricorso in appello poiché ritenne di avere subito un’ingiustizia: «No, niente Appello. Qui non si tratta di riformare una sentenza, ma un costume. […] Accetto la condanna come accetterei un pugno in faccia: non mi interessa dimostrare che mi è stato dato ingiustamente». Prese la via della galera, così come – è lui stesso a dirlo – aveva preso quella del lager per non avere voluto collaborare con il fascismo ed il nazionalsocialismo. Commentando la condanna, il padre di don Camillo e Peppone si affidò ad una citazione di dantesca memoria: «E il modo ancor mi offende».
A metà pomeriggio di mercoledì 26 maggio lo scrittore parte dalla fattoria di Roncole su di un camioncino Fiat 1400 a nafta, per presentarsi spontaneamente alle carceri di Parma. Alla vigilia dell’imprigionamento concorda col suo «vice», Alessandro Minardi, le modalità della collaborazione con «Candido»: utilizzerà lo pseudonimo di Giuseppe Bottazzi, per aggirare la legge che impedisce ai detenuti di pubblicare. Ma sottovaluta l’intreccio tra direttive politiche governative e burocrazia carceraria, che bloccherà il progetto (anticipato, imprudentemente, dal quotidiano «Il Secolo d’Italia»).
Nelle ultime ore di libertà, ripete ossessivamente agli amici che lo rincuorano: «È un niente, non fateci castelli; è proprio una fesseria andare in carcere: ci vado e ne ritornerò». E, quasi parlasse a se stesso: «Il fatto ch’io vada in galera è una cretineria, una cosa da niente, ma io mi considero un pretesto, un’occasione, un reagente, se per me dieci, cento, mille italiani si sveglieranno, benedetto quest’anno di galera!». Ragionamenti scaramantici, per esorcizzare il salto nel buio… in realtà ritornerà dalla carcerazione minato nel fisico, e soprattutto nello spirito.
Ha in spalla lo zaino della prigionia tedesca; sulla tela sdrucita, scritto a mano, il numero di matricola 8865; contiene biancheria, un barattolo di bicarbonato e la macchina da scrivere. Stringe la mano a un ufficiale della guardia carceraria che gli esprime la propria simpatia; alla sua sinistra, il senatore Turchi (MSI), interessato al lato politico dell’evento, cui l’indomani «Il Secolo d’Italia» dedicherà grande spazio. I fotografi scattano a raffica e ne scaturisce una spiacevole polemica, poiché interpretazioni malevole sostengono che Guareschi viene accolto in carcere con reverenza e simpatia. Il ministero dell’Interno dispone un’indagine e la cortese guardia che al suo ingresso gli aveva stretto la mano riceve un «cicchetto».
Completato il rito della registrazione, ha un lungo colloquio con il direttore Emanuele Chirico e col magistrato Zeffirino Mezzatesta, che gli illustrano lo statuto del reclusorio. Il regolamento penitenziario risale al 1932; ispirato a pesanti logiche punitive d’ispirazione fascista, è stato blandamente attenuato nel dopo guerra. Di fatto la Direzione del carcere asseconderà con eccessi di zelo la volontà dei governanti. Un alto funzionario, simpatizzante con Guareschi, descrive a un amico il direttore Chirico: «Burocrate fino alla punta dei capelli, con una paura matta di sbagliare e sempre alla ricerca di indovinare il desiderio recondito dei suoi superiori per fare bella figura… L’impressione è che oltre alla paura del direttore vi sia anche lo zampino di qualcuno del Ministero, non tanto forse di autorità politiche, quanto di funzionari che vogliono ingraziarsi le autorità politiche».
Sotto la maschera ironica che Guareschi sfoggia per il pubblico, la depressione gli mostra come desiderabile sia persino la prospettiva dell’esilio. Valutato che «non è possibile, in un’Italia come l’attuale, scrivere onestamente senza rischiare la galera», non resta che l’espatrio: «Io me ne andrò da questa Italia di corrotti e di corruttori: lontano potrò pensare a essa con nostalgia». «Candido» mostra unicamente il versante solare di Guareschi, ignorando – per ragioni di immagine e di riservatezza – la dimensione notturna, di gran lunga predominante. Curioso di ogni nuovo ingresso, Guareschi vede entrare nel carcere “San Francesco” uomini di ogni ceto sociale, ma non poliziotti né giudici: «Arriva ogni giorno gente nuova e io m’informo. Fino a oggi nessuno della polizia, nessuno della magistratura. Quelli non li beccano mai». La storia di Giovannino Guareschi proseguirà, ma noi la abbandoniamo qui. (1)
Ci è parso interessante esporre l’esperienza di un uomo unanimemente considerato onesto, che un giorno incappò, in assoluta buona fede, in quello che potremmo definire un “incidente” professionale. Era uomo eticamente formato, e malgrado molti gli avessero indicato la via “istituzionale” per evitare la galera, egli non si sottrasse. Ma questo non gli evitò la repressione del potere, ed il servilismo allo stesso potere costituito di alcuni funzionari.
La nozione di forza che, secondo noi, dovrebbero interiorizzare gli indipendentisti, è lungi dall’essere semplice, e tuttavia è la prima a dover essere chiarita per porre le questioni sociali. La forza e l’oppressione sono cose distinte; ma occorre capire innanzitutto che non è il modo in cui una forza qualsiasi viene usata, ma la sua natura stessa a determinare se essa è o non è oppressiva. Anche le armi del privilegio sono abbastanza potenti da rendere impossibile ogni difesa agli uomini in buona fede. Insomma, lo ripetiamo, non è perseguendo la presunta via democratica e istituzionale che i veneti (e gli altri popoli) otterranno l’autodeterminazione. Si potrà (dovrà?) addivenire alla secessione, purché prima si riesca a produrre una proposta di nuovo assetto istituzionale, e su di essa si ricerchi il favore del cosiddetto popolo sovrano.
* * *
NOTE:
Per coloro che fossero interessati alla vicenda di Giovanni Guareschi, si veda: Mimmo Franzinelli «BOMBARDATE ROMA!» – Guareschi contro De Gasperi: uno scandalo della storia repubblicana – Con perizia grafologica di Nicole Ciccolo – © 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano – I edizione aprile 20l4.
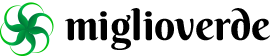




Mi pare ovvio che non si possa giocare con le carte truccate dell’avversario, sapendo che questi sia notoriamente un baro.
La cosa è da tenere ben presente nel caso si volesse fare un referendum per l’indipendenza.
Mi pare evidente che avendo a che fare con un avversario che “bara”, si dovrà avere la certezza assoluta che non vi siano brogli, ma essendo questi la norma nelle elezioni italiane, mi pare assurdo pretendere all’improvviso la correttezza. Quindi il tutto dovrà essere organizzato e controllato solo da noi, anche affidarsi ad enti o Società esterne è impossibile, vista la probabilità di corruzione (altra caratteristica italica).
Altro punto è che come in tutti i paesi a votare sono i cittadini di quel paese (e non gli stranieri residenti o i lavoratori esteri o i turisti in transito) così nella votazione di un paese della Padania possono votare solo i cottadini padani e non i coloni, gli immigrati, i lavoratori italiani ed esteri in genere.
Perciò il passo primario è la cittadinanza padana, da concedersi solo per ius sanguinis.