Ottanta anni fa, nel 1936, veniva pubblicata la Teoria Generale dell’occupazione, interesse e moneta dell’economista di Cambridge, John Maynard Keynes (1883–1946), una delle opere di economia più influenti che siano mai state scritte. Un giornalista americano la definì il Das Kapital del 20°secolo. Keynes conquistò il mondo politico e accademico occidentale come Carlo Marx conquistò la Russia e la Cina. Contenuti a parte, altrimenti si farebbe un torto a Marx, entrambi hanno un punto in comune: mirarono ad abbattere l’edificio logico creato dagli economisti classici (Smith, Ricardo, Mill) con due “teologie”: Marx con quella del ‘plusvalore’; Keynes con quella del ‘deficit’.
Prima dell’avvento della “rivoluzione keynesiana” la condotta fiscale dei governi era stata improntata ai chiari principi degli economisti classici, per i quali i bilanci pubblici dovevano essere in equilibrio e i deficit dovevano essere tollerati solo in circostanze straordinarie per evitare ripercussioni sulle generazioni future. Keynes si sbarazzò di questa “superstizione” facendo della deliberata creazione dei deficit uno dei cardini della sua dottrina. Adam Smith aveva scritto: «Ciò che è prudenza nella condotta di una famiglia privata può difficilmente essere follia in quella di un grande stato». Keynes capovolse l’analogia e la sua dottrina può essere così sintetizzata: Ciò che è sperpero privato può essere saggezza nella condotta di un governo.
Keynes nega esplicitamente che il debito pubblico ponga oneri a carico dei contribuenti futuri perché la spesa che consente non solo viene riassorbita ma promuove la piena occupazione. In che modo? Per capirlo bisogna far riferimento al secondo pilastro della sua dottrina: «la domanda effettiva», che è la quantità di reddito spesa in consumi e in investimenti. In opposizione agli economisti classici per i quali il livello del reddito reale dipende dalla capacità produttiva, Keynes afferma che dipende dal volume della domanda aggregata che diventa così la vera determinante del reddito nazionale. E’ il suo calo, non quello della capacità produttiva, a provocare la crisi. Il calo si verifica perché secondo Keynes, l’economia di mercato è intrinsecamente instabile e lasciata a se stessa si autodistrugge. Per Keynes «l’investimento è volatile, incostante ed irrazionale. Il mondo dell’economia è governato da una incontrollabile e disobbediente psicologia» (Teoria Generale, Utet, pag.145). Gli investitori causano, involontariamente, i collassi economici e i consumatori sono automi passivi alla mercé degli investitori. Poiché l’economia di mercato si basa sulle loro aspettative, produzione e occupazione sono sempre a rischio. Se, scrive Keynes, l’attività di investimento fosse nelle mani dei governi, non sarebbe più in balia di evanescenti “animal spirits”, cioè dei fattori psicologici che causano ondate di pessimismo o ottimismo (ibid.p.292). Pertanto se la domanda di investimenti cala, per evitare il collasso di quella complessiva, la si sostituisca con la domanda a scopo di consumo che è quella propulsiva. Allo scopo, non esitino le autorità finanziarie e monetarie ad accrescere la capacità di acquisto della popolazione mediante spese pubbliche, con la copertura, però, non di nuove imposte ma di emissioni monetarie riducendo il tasso di interesse anche allo zero per rendere disponibile il capitale illimitatamente. L’economista di Cambridge ci mostra così come legiferare la prosperità perenne: «Chi possiede capitale guadagna un interesse perché il capitale è scarso, allo stesso modo di come il proprietario di terre può percepire un affitto perché la terra è scarsa. Ma mentre ci possono essere motivi reali per la scarsità della terra non sussistono reali motivi per la scarsità di capitale. Pertanto, in pratica … un aumento dello stock monetario può continuare fino a che il capitale cessi di essere scarso…»(ibid. p. 514 ).
 Uno dei cardini della dottrina keynesiana è la manovra del tasso di interesse che Keynes, commettendo un clamoroso errore, definisce come compenso per rinunciare alla domanda di moneta (propensione alla liquidità), ossia alla liquidità tenuta in banca per far fronte alle spese correnti, e non, invece, come pensavano i classici, il prezzo di equilibrio tra l’offerta e domanda di risparmio. L’aumento della domanda di moneta, identificata col tesoreggiamento, penalizza l’investimento e, soprattutto la spesa in consumo. Appare dunque chiaro l’importanza, in questo schema, della riduzione dell’interesse, ad opera delle autorità monetarie, per far diminuire la propensione alla liquidità e curare il vero male economico: non spendere. Ma se la politica monetaria fallisce in questo tentativo, allora vuol dire che investitori e consumatori sono caduti nella “trappola della liquidità” hanno cioè paura di spendere. Allora, per stimolare la domanda di consumo, si rende necessario un ulteriore, massiccio stimolo di spesa pubblica. Per cui: «Costruzione di piramidi, terremoti, perfino guerre possono servire ad aumentare la ricchezza se la formazione dei nostri uomini di stato, plasmatasi sui principi degli economisti classici non impedisse di fare qualcosa di meglio». (ibid. pag. 259).
Uno dei cardini della dottrina keynesiana è la manovra del tasso di interesse che Keynes, commettendo un clamoroso errore, definisce come compenso per rinunciare alla domanda di moneta (propensione alla liquidità), ossia alla liquidità tenuta in banca per far fronte alle spese correnti, e non, invece, come pensavano i classici, il prezzo di equilibrio tra l’offerta e domanda di risparmio. L’aumento della domanda di moneta, identificata col tesoreggiamento, penalizza l’investimento e, soprattutto la spesa in consumo. Appare dunque chiaro l’importanza, in questo schema, della riduzione dell’interesse, ad opera delle autorità monetarie, per far diminuire la propensione alla liquidità e curare il vero male economico: non spendere. Ma se la politica monetaria fallisce in questo tentativo, allora vuol dire che investitori e consumatori sono caduti nella “trappola della liquidità” hanno cioè paura di spendere. Allora, per stimolare la domanda di consumo, si rende necessario un ulteriore, massiccio stimolo di spesa pubblica. Per cui: «Costruzione di piramidi, terremoti, perfino guerre possono servire ad aumentare la ricchezza se la formazione dei nostri uomini di stato, plasmatasi sui principi degli economisti classici non impedisse di fare qualcosa di meglio». (ibid. pag. 259).
Questa, in sintesi, è la teologia keynesiana di cui è evidente il potenziale totalitario. Nella prefazione all’edizione tedesca scrive:«Quanto esposto in questo libro è stato concepito con riferimento ai paesi di cultura anglosassone. Tuttavia, si adatta assai più facilmente alle condizioni di uno Stato totalitario [eines totalen Staates] di quanto lo possa la teoria della produzione e della distribuzione in condizioni di libera concorrenza e di prevalente regime di laissez faire». (ibid. p.119.)
Ma, come osservò la sua famosa allieva, Joan Robinson, (che coniò il termine ‘keynesianismo’), Hitler non aveva bisogno dei consigli di Keynes perché, istituendo il New Deal tedesco per ristrutturare l’economia e promuovere la piena occupazione con un imponente programma di spesa pubblica, «aveva già trovato la cura per la disoccupazione prima che Keynes avesse finito di spiegarla». La politica di espansione monetaria e del basso saggio di interesse, adottata in Germania nel 1933, proclamava la fine dei cicli economici. Nella “nuova economia”, si affermò non c’è posto per le “congiunture”. Keynes nel 1936 enunciò gli stessi principi che improntarono l’insegnamento nelle università e nei circoli accademici occidentali.
Keynes desume la crescita economica da una tautologia: spesa per consumo e investimenti = reddito = prodotto lordo. La spesa genera reddito, la spesa di un individuo corrisponde al reddito di un altro individuo e più si spende meglio è. Ma questa identità sempliciotta che somma in modo atemporale e indistinto la produzione a lungo termine con quella a breve del consumo e in base alla quale una classe di burocrati illuminati dovrebbe guidare l’economia, non dice proprio nulla sul processo di crescita. Secondo Keynes l’insufficiente spesa per investimenti deve essere compensata da quella in consumi che diventa reddito e spesa corrispondente e il meccanismo è attivato dal deficit spending i cui effetti sono moltiplicati se la propensione al consumo aumenta e quella al risparmio diminuisce essendo quest’ultimo la causa riduzione di reddito e della caduta della domanda. E’ il famoso paradosso del risparmio (paradox of thrift): «Ogni tentativo di risparmiare di più riducendo i consumi, colpirà talmente i redditi da rendere vano il tentativo stesso di risparmiare». (ibid p. 84). Se, per Keynes, risparmiare significa “tesaurizzare” o come afferma, aumentare “la domanda di moneta” (la preferenza per la liquidità) e se nel suo schema la domanda è il motore dello sviluppo, è naturale che il risparmio, così concepito, venga considerato come ostacolo al consumo. Ma allora, per l’economista di Cambridge, a cosa serve il risparmio? Serve a pagare i debiti. Ogni deficit spending crea investimenti e questi a loro volta daranno successivamente luogo al risparmio per ripagarli. Il risparmio è dunque la conseguenza dell’investimento non il presupposto, prima si investe e poi si risparmia! Il totale capovolgimento dell’economia classica.
Nella realtà avviene, invece, che quel tasso di interesse che Keynes vuole annullare per rendere il capitale non scarso e che serve a creare deficit, stimola su larga scala sprechi, investimenti rischiosi e antieconomici che non rilasceranno affatto risparmio, non pagheranno i deficit, faranno crollare la domanda e si dovranno tenere in vita con ulteriori e perenni deficit da scaricare sulle generazioni future. Così Keynes ci fornisce, involontariamente, la chiave interpretativa delle crisi che non sono gli animal spirits ma la loro stessa cura, i deficit.
Che delle sciocchezze siano state accolte, nel 1936, come nuove scoperte della scienza economica e siano diventate ortodossia economica, non deve stupire. Keynes ha attinto al deposito di immondizie di vecchie dottrine già screditate dai classici avvolgendole in un involucro sofisticato: la macroeconomia di cui la politica ha colto il potenziale per avocare a sé la gestione dell’economia.
Nell’universo keynesiano, i veri ingredienti della crescita, imprenditorialità, risparmio, produttività, innovazione, tecnologia e voglia di lavorare, non hanno cittadinanza. Dopo di lui l’economia ha interessato solo grandezze astratte, gli “aggregati” che la politica può manipolare a piacere facendo recitare ai veri artefici dell’economia, gli individui e le imprese il ruolo di comparse. Al comando delle forze macroeconomiche della moneta e del credito, i deficit sono diventati terreno di pascolo dell’affarismo politico che, intrecciatosi a quello finanziario, ha consegnato le economia al potere di oligarchi. Keynes ha fornito a quelle organizzazioni di irresponsabili e incompetenti che chiamiamo governi, la copertura intellettuale al saccheggio dell’economia privata con la formula inflaziona-spendi-tassa. Ai nostri giorni c’è stata una drammatica accelerazione, in versione monetarista dai tratti sempre più autoritari, di queste politiche che continuano a devastare le economie industriali e che tuttavia mantengono ancora il potere di persuasione. Per tornare a crescere, il mondo deve ripudiare in via definitiva la distruttiva dottrina keynesiana.
Il problema è riuscirci senza dover passare per l’Apocalisse.
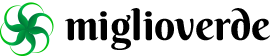



Qualcuno fece credere a Keynes di esser un ottimo economista, intelligente, previdente, accorto ed originale.
E lui ci ha creduto, purtroppo, impegnandosi nel produrre quell’accozzaglia di bestialità e non sense contenuti nel suo testo.
I politici, poi, ne hanno approfittato in ogni modo delle sue astruse teorie.
Fino alla miseria ed all’eccezionale indebitamento internazionale.