di SERGIO SALVI
 Ho sbirciato più volte, proprio su MiglioVerde, una foto eloquente: una siepe fittissima di catalani dietro un immenso striscione che reca scritto a caratteri cubitali: som una nació (e non basta con le tasse, come preferirebbero alcuni “secessionisti” nostrani di dubbia fede indipendentista).
Ho sbirciato più volte, proprio su MiglioVerde, una foto eloquente: una siepe fittissima di catalani dietro un immenso striscione che reca scritto a caratteri cubitali: som una nació (e non basta con le tasse, come preferirebbero alcuni “secessionisti” nostrani di dubbia fede indipendentista).
Un piccolo sfogo biografico: studio i movimenti indipendentisti delle nazioni senza stato da almeno mezzo secolo. Ho scritto otto libri in proposito, alcuni dei quali citati anche su questo giornale. In nessuno dei movimenti di liberazione che ho seguito con attenzione per così tanto tempo ho trovato (e trovo) la minima traccia di quel pensiero, in questo momento alla moda nel nostro paese, che si denomina libertario: se non nel movimento più debole e, lasciatemelo dire, più incosciente e confuso di tutti: quello padano (suscitato e affossato dalla malemerita Lega Nord).
Farò un esempio: i nostri libertari, di ispirazione americana, evitano, quando non lo negano apertamente, il concetto di nazione, attorno al quale si catalizzano invece tutti, dico tutti, questi movimenti. I catalani sono, in questo ambito, i più catalizzati. Esprimono la coscienza di essere nazione impegnandosi per essere anche stato, così come hanno fatto i loro antagonisti castigliani. E non si lasciano sedurre dalle sirene americane che si chiamano libertarie, libertariane, anarco-capitaliste, agoriste, panarchiste, miniarchiste.
La fascinazione dell’America, intesa come USA, ha investito, con una certa violenza mediatica, il nostro paese a partire almeno dagli anni cinquanta del secolo appena trascorso, diventando una opzione di massa e interferendo sul costume di tutti i giorni.
Va rammentato in proposito il film di Steno, Un americano a Roma, del 1954, dove campeggia la figura di Nando Moriconi, interpretato da Alberto Sordi, sicuramente un precursore in senso patetico-ridicolo di questo interesse in ascesa. È invece del 1956, la consacrazione musicale del fenomeno, che avviene con la canzone Tu vuo’ fa’ l’americano di Renato Carosone. Passando dal piano del costume e della satira a quello delle cose serie, dirò che proprio alla fine di quel decennio, nel 1960, appare il primo frutto “culturale” (e non conformista) di un interessamento sempre più coinvolgente: l’economista Bruno Leoni fa conoscere in Italia il libertarismo americano e Rothbard, il teorico dell’anarco-capitalismo. È una specie di rivoluzione nell’informazione colta. Fino allora esistevano sull’America soltanto ponderosi studi accademici di politologi eruditi ma distratti e appropriazioni indebite da parte dei soliti politici di professione.
Dirò subito che non ho intenzione di sminuire il contributo di Leoni, intellettualmente “pesante”, con la premessa ultraleggera da cui ho preso le mosse: ho soltanto scherzato coi santi, senza tralasciare i fanti, come fanno i toscani, tradizionalmente irriverenti e per questo invisi ai più. Mi proverò addirittura a delineare un tracciato in qualche modo storico e pertinente.
Un pugno di neofiti libertari di cittadinanza italiana si è inserito, una dozzina di anni fa, all’interno della Lega Nord nell’intento, di per sé nobilissimo, di contribuire al disfacimento di uno stato, quello italiano, da essi (ma, grazie a Dio, anche da altri) giustamente aborrito. Come tutti gli stati, del resto. Quello italiano era il più a portata di mano nella loro lotta planetaria per l’affermazione del binomio libertà e proprietà. Il manipolo di cui parlo era composto da giovanotti preparatissimi (purtroppo a senso unico) e intelligenti, in grado di sconvolgere un partito rozzo e confuso in fase di crescita quantitativa ma privo di idee, soprattutto di idee chiare. Le idee di questi giovanotti erano invece chiarissime anche se inguaribilmente viziate, per me almeno, da una utopia dal sapore sgradevole, soprattutto a proposito del diritto di proprietà e di quello alla Libertà. Per me, la prima libertà dell’uomo, rimane infatti quella dal bisogno.
Conto amici sinceri all’interno di questo manipolo e sono animato da un sentimento di autentica gratitudine nei confronti di almeno uno di loro. Li trovo però piuttosto fanatici: la loro forsennata opposizione alle tasse e la loro fede assoluta nel libero mercato si apparentano agevolmente al mio fanatismo per le lingue e le nazioni. Un fanatismo uguale e contrario. Per testimoniare questo contrario mi esporrò deliberatamente al loro ludibrio dichiarando qui, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, che, in un domani che mi auguro prossimo, preferirei pagare molte tasse a uno stato indipendente toscano piuttosto che vivere in uno stato italiano che avesse abolito ogni tassa possibile e immaginabile. E che, fino all’estinzione di tutti gli stati esistenti, mi schiererò a favore della creazione di uno stato, toscano e sovrano, nel tentativo di combattere o di collaborare ad armi pari sulla scena internazionale con tutti gli stati costituiti, uno dei quali si è costituito alle mie spalle. Magari lotterò anche contro ogni eventuale ingiustizia fiscale, ma all’interno di questo stato, del mio stato, dello stato della mia nazione.
L’esempio americano, e addirittura il modello di comportamento politico che esce da questo esempio, non è, a mio avviso, utile per noi indipendentisti europei. Gli indipendentisti europei credono per prima cosa nella loro nazione oppressa e negata (som una nació) da altre nazioni divenute stati anche a loro spese.
L’America non è una nazione, anche se è uno stato potente. Ho già delineato in un articolo precedente il perché, da un punto di vista linguistico. Aggiungerò qui alcuni esempi utili a ribadire gli USA come una “a-nazione”. Anzitutto, il loro stesso parere in merito.
Gli americani hanno stentato assai nel definirsi “nazione”. Lo provano l’uso esclusivo, nei documenti ufficiali iniziali, dei termini “Unione” (il messaggio sullo “stato dell’Unione”), “People”(we the People del Preambolo), “United States”. Nel testo del 1787 il termine “nazione” compare una sola volta («to regulate commerce with the foreign nations») ed è riferito soltanto agli stati stranieri. È appena dopo la guerra di secessione che il termine, mutuato dagli usi degli stati europei, prende campo. Dobbiamo però constatare che questa “nazione” emersa improvvisamente nei documenti ufficiali è la “Federazione”, l’ “Unione”, in riferimento ai singoli “Stati” che la compongono: la “nazione”, secondo il vocabolario europeo, è lo Stato e gli Stati, nel vocabolario americano, sia pure dotati di vistosa autonomia e di qualche sovranità da noi inimmaginabili, sono le nostre “regioni”. Secondo William Kristol e David Brooks, che sono neo-con (cioè, in termini europei, conservatori espansionisti) e non certo libertari, l’America è invece «una nazione eccezionale fondata su un principio universale, su ciò che Lincoln chiamava “una verità astratta applicabile a tutti gli uomini e a tutti i tempi”». Ai giorni nostri, Newt Gingrich, ribadendo che «l’America è la prima nazione universale» del mondo, ha esplicato con disinvoltura una vera e propria contraddizione in termini. L’universale è soltanto, almeno in politica, la dilatazione onnivora di una parte che pretende di inglobare il tutto. È un concetto astratto, non una realtà concreta.
Le nazioni, in senso europeo, esistono ancora e resistono. Sono nate nell’alto medioevo per aggregazione intorno a una lingua in qualche modo privilegiata dalla situazione storica. Non sarà stato bello ma è stato così. Gli Stati Uniti allora proprio non esistevano. Nasceranno mille anni dopo. E nasceranno in un modo particolare, attorno a un piccolo nucleo nazionalmente definito (cioè inglese) di transfughi europei che ha innescato (e continua a innescare), col suo espansionismo sempre più vorace, ondate successive anch’esse nazionalmente definibili ma certamente non come inglesi. Che non si sono mai integrate, come i nomi di Martin Luther King e di Malcolm X dimostrano.
- Walzer, nel suo saggio Che cosa significa essere americani sostiene che l’America non è una nazione in quanto è «composta da un’infinità di minoranze che mantengono una forte caratterizzazione etnico-linguistica: il pluralismo caratteristico di questa società ha prodotto non degli “americani” ma degli hyphenated Americans (“americani col trattino”: italo-americani, ebrei-americani, afro-americani, irlandesi-americani, ispano-americani)». L’evoluzione demografico-linguistica in corso che sta portando gli USA dalla lingua inglese oggi ancora maggioritaria a quella spagnola è il sintomo di un viaggio dentro un labirinto in qualche modo frenetico ma determinante.
Gli hyphenated Americans sono sparsi all’interno degli USA senza caratterizzare nessun territorio peculiare se non un quartiere, una frazione, un villaggio, per giunta qua e là e in modo fluttuante. La loro straordinaria mobilità non ha riscontro in Europa, nonostante la vistosa immigrazione di questi ultimi tempi. Parigi, Londra e Berlino non sono ancora New York e Los Angeles. Le nazioni, in Europa, ci sono e sono ancora relativamente compatte sul territorio. Fino a quando non si sa: ma io spero a lungo.
Va, comunque, tenuto presente che nel discorso comune, il termine “nazione” è ancora sinonimo di “stato”. È una eredità giacobina e soprattutto napoleonica, quando la nation per antonomasia era la Francia rivoluzionaria, che aveva la missione di esportare la civilisation (il suo modello politico) con le armi fin dove le era possibile, senza badare a territori, popoli e lingue conquistati. I miei antenati toscani sono stati, dal 1807 al 1814, cittadini francesi, inclusi nel territorio metropolitano francese, aggregati in tre dipartimenti (Arno, Ombrone, Mediterraneo) mentre un quarto dipartimento (Serchio) restava in attesa di realizzazione per rispetto a Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, reggente solo formalmente il finto trono di Lucca.
Il concetto di “nazione” al quale si rifanno oggi i catalani procede invece, sintetizzando assai, dal XII “Discorso” di Fichte “alla Nazione tedesca”: «dovunque c’è una lingua c’è anche una nazione, che ha il diritto di curare in modo autonomo i propri affari e di governarsi da sé» (1808). La “nazione” tedesca era allora sotto il giogo francese e non appariva certo soddisfatta da questa sua dipendenza “universale” da una nazione straniera. Poi si darà essa stessa all’annessionismo sfrenato con la scusa dello “spazio vitale”.
Certo, da Fichte a oggi, ne è stata fatta di strada. Prendiamo la lingua, che continua ad essere il carattere principale di una nazione. Appare paradossale ma il contributo maggiore in proposito è stato quello di due eminenti linguisti americani, Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, enunciato negli anni trenta del XX secolo. Dallo studio delle lingue dei nativi americani, che sono lingue particolari, i due studiosi sostennero che ogni lingua porta con sé una diversa concezione del mondo. Ogni lingua “costringe” gli individui che la parlano (la comunità dei parlanti, la “nazione” quando è radicata in un territorio non importa quanto esteso), li obbliga a interpretare, addirittura a “costruire”, la realtà, in modo proprio. La “realtà” di chi parla inglese è diversa da quella di chi parla spagnolo.
A quella opinione tutt’altro che peregrina si opposero linguisti non meno illustri, i quali sostennero che il pensiero non dipende dalla struttura delle singole lingue ma dalle leggi universali della ragione. Fra questi l’americano Noam Chomsky, che si dichiara però anarco-socialista e considera l’anarco-capitalismo dei libertari, se realizzato, «la peggiore dittatura cui verrebbe sottoposta l’umanità». Una calda e una fredda, dunque.
Dalla fine degli anni 80 dello scorso secolo, i progressi della psicologia cognitiva e della linguistica antropologica hanno riproposto la validità dell’ipotesi Sapir-Whorf, temperata da una concezione meno diretta del rapporto tra lingua e pensiero e fondata piuttosto sulle ineliminabili interferenze di base tra questi due aspetti, che determinano in fondo il concetto stesso di nazione e motivano la conseguente lotta di liberazione nazionale in corso in Europa e in altre porzioni di mondo da parte delle nazioni senza stato, che vogliono uno stato proprio e non fanno certo delle tasse la ragione della loro vita politica.
Il nostro interlocutore ormai tradizionale che si cela sotto il nome di “Marco” ci offre a questo proposito un assist formidabile. Egli scrive: «È vero o non è vero che la rivoluzione americana che ha portato all’indipendenza delle 13 colonie del XVIII secolo è stata una rivolta fiscale e non una ragione linguistica?». Ha “ragione”, anche se non si trattò soltanto di una rivolta fiscale. Ciò sarebbe riduttivo e offensivo nei confronti di questi “rivoluzionari”, così devoti all’idea della libertà e della prosperità. C’erano infatti altri e più alti motivi di fondo quali la facoltà piena di commerciare e di legiferare senza l’intervento di una madrepatria sempre più lontana ma ancora operante. Che era, tutto sommato, ancora la loro.
Come avrebbero potuto esplicare rivendicazioni linguistiche quando parlavano la stessa identica lingua dell’Inghilterra? L’inglese americano era ancora di là da venire e le lingue “americano-americane”, quelle studiate da Sapir-Whorf, erano state “espulse” dalle 13 colonie insieme a coloro che le parlavano.
Non era però questa la situazione di un’altra colonia inglese, questa volta “interna” in quanto europea, l’Irlanda, dove gli indigeni non erano stati espulsi e parlavano ancora la loro lingua, così diversa dall’inglese. La loro oppressione coloniale era incredibilmente più dura di quella degli inglesi americani ed è stata descritta perfino sulle pagine di MiglioVerde. Anche gli irlandesi si ribellarono, dieci anni dopo gli americani e sul loro esempio, ma furono repressi in un modo assai più radicale e brutale. Tra le ragioni della loro rivolta c’erano, ben chiare, le motivazioni linguistiche.
È vero o non è vero, carissimo “Marco”?
D’accordo: nemmeno gli irlandesi amavano pagare le tasse agli inglesi britannici anche se, al contrario degli inglesi americani che si dice buttassero nel mare di Boston le celebri casse di tè, preferivano il fuoco all’acqua. Come gli consigliò di fare il grande Jonathan Swift quando li esortò a «bruciare ogni cosa che venisse dall’Inghilterra tranne il carbone».
Ci sono, del resto, dubbi recenti sulle ragioni profonde che stanno dietro l’ormai mitologico Tea Party. Si dice infatti che, mediamente, le tasse pagate dagli inglesi in Inghilterra ammontassero a 26 scellini e quelle pagate dai coloni inglesi in America, a 1 soltanto. Non sappiamo se questa affermazione sia vera. Del resto, obbiettivamente, il Tea Party non è uno spartiacque nella storia dell’umanità, una tappa fondamentale sul cammino verso una libertà al solito universale. È, tutto sommato, un evento locale, così come la Battaglia di Legnano per Bossi, la Disfida di Barletta per Giorgia Meloni e la Beffa di Buccari per Ignazio la Russa.
Concludendo: anche se le 13 colonie del XVIII secolo sono diventate i 50 stati di oggi, la loro nazionalità originaria è profondamente mutata e si è tanto confusa (ma non fusa) nel tempo, al punto da qualificare gli USA come uno stato senza nazione. La loro vicenda non appare direttamene utile, da questo punto di vista, come ispirazione e fonte di imitazione, agli indipendentisti europei: perlomeno a tutti quelli che, nelle loro lingue madri, affermano ciò che in catalano si dice som una nació. Magari sbagliano, ma fanno derivare tutto da questo assioma. E sono tutti, propri tutti, di questa balzanissima idea. Bah.
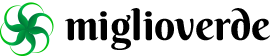


I neocon sono ex trotzkisti i quali cambiarono orientamento politico solo quando la politica estera della sinistra cominiciò a non favorire più così platealmente la loro Nazione di riferimento. Aborrono l’identitarismo della maggioranza bianca degli USA, difendendo solo quello delle minoranze.
David Brooks crede nel concetto della nazione (quella identitaria), solo non quella americana. Idem per Bill Kristol e la stragrande maggioranza dei neocon.
http://www.haaretz.com/life/books/.premium-1.620890
Sempre sul nazionalismo di Brooks:
http://tinyurl.com/kyblam5
Io la giro in positivo più che essere contento di vivere in uno stato padano peggiore dell’italia, sarei convinto di fare la secessione quand’anche l’italia diventasse il miglior stato del mondo e gli svizzeri emigrassero da zurigo a quarto oggiaro!!!! Questo perchè semplicemente io sono altro, semplicemente non sono italiano. Punto.
Il libertarismo alla moda!? In questo paese?!
Questa è bella!
Siamo quattro gatti!
Troppa roba, caro Salvi. Roba buona, eh, anche se sono un libertario.
Pagare un sacco di tasse allo stato della Toscana non è un grosso problema se i toscani sono d’accordo, ma sarebbe assai poco probabile che il governo della Toscana riuscisse a imporre un prelievo che (fuori tutto) si aggira al 70% del frutto del lavoro dei cittadini onesti, per assumere, chessò, 10.000 forestali a presidiare la Maremma o istituire un fondo per registi e artisti sfigati (e affrancarli, così, dalla schiavitù del bisogno …)
Uno stato italiano che avesse abolito ogni tassa possibile e immaginabile vedrebbe nascere molte comunità indipendenti nelle quali le presumibilmente le persone si autotasserebbero, come fanno in Svizzera, per incaricare qualcuno, che se ci piace possiamo chiamare stato, a gestire quei compiti che ai privati non interessa svolgere ma di cui hanno bisogno. Un po’ come gli americani primordiali che davano un dollaro a testa allo sceriffo perchè sorvegliasse il loro insediamento, mentre di notte si riposavano dalle fatiche del duro lavoro.
Comunque grazie per i notevoli spunti di riflessione. Articoli del genere sono, almeno per quanto mi riguarda, oltre che ottimamente argomentati, una ghiottissima occasione per raccontare che i libertari sono tutto meno che sognatori e utopisti. E neanche fanatici. Estremisti sì però, perchè non si possono fare compromessi nella difesa della Libertà.