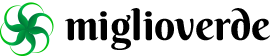di PAOLO L. BERNARDINI
Traiano Boccalini, nato a Loreto nel 1556, è uno dei maggiori pensatori politici tra tardo Rinascimento e prima età barocca, diede alle stampe, proprio a Venezia, i suoi mirabili, unici, sorprendenti e modernissimi Ragguagli di Parnaso nel 1612 — la dedica al Cardinal Borghesi porta la data del 21 settembre. Un anno prima di morire. Morì infatti nella Serenissima alla vigilia della minaccia spagnola (degli spagnoli ormai alle porte di Venezia – dove rimarranno – egli aveva pessima opinione) sul finire del 1613, probabilmente il 29 novembre nella parrocchia di Santa Maria Formosa. I Ragguagli sono animati dialoghi “in Parnaso” appunto, tra letterati vivi e morti, dialoghi immaginari, ove si tratta di una moltitudine di temi. Nel V Ragguaglio si tratta appunto di Venezia, città sommamente cara a Boccalini, amico di Paolo Sarpi, città dove scelse di pubblicare la prima parte del suo capolavoro (ne seguiranno altre due, l’ultima postuma nel 1615), e dove scelse di morire. Per chi voglia accostarsi a Boccalini, la voce magistralmente redatta da Luigi Firpo (1969) sul Dizionario biografico degli italiani rimane il miglior viatico.
 Boccalini amava Venezia; tra infinite altre testimonianze, vale, e qui la riporto per intiero, sperando possa essere lettura utile e gradevole, il ragguaglio V. Tra le altre cose, si discute di un tema assai importante, ovvero il legame tra carità pubblica e patriziato. Perché a Venezia i patrizi mettevano saggiamente e costantemente le loro fortune al servizio, diremmo oggi, del “sociale”, non solo per sano spirito cristiano e umanitario, ma anche, accortamente, per eliminare possibili malcontenti cittadini, possibili sollevazioni in una città che aveva un equilibrio urbano fragilissimo, e, al di fuori delle acque, praticamente, nessuna via di fuga.
Boccalini amava Venezia; tra infinite altre testimonianze, vale, e qui la riporto per intiero, sperando possa essere lettura utile e gradevole, il ragguaglio V. Tra le altre cose, si discute di un tema assai importante, ovvero il legame tra carità pubblica e patriziato. Perché a Venezia i patrizi mettevano saggiamente e costantemente le loro fortune al servizio, diremmo oggi, del “sociale”, non solo per sano spirito cristiano e umanitario, ma anche, accortamente, per eliminare possibili malcontenti cittadini, possibili sollevazioni in una città che aveva un equilibrio urbano fragilissimo, e, al di fuori delle acque, praticamente, nessuna via di fuga.
Attraverso opere di carità, e la promozione connessa delle arti e manifatture, i patrizi mantenevano saldamente il controllo della città, e ascendevano nella scala sociale, mentre la gens nova poteva aspirare alla cittadinanza con maggiori diritti. V’era, dunque, un culto del dare, una generosità naturale che in qualche modo è stata trasmessa al popolo veneto. Che ne continua la tradizione attraverso una vasta rete di assistenza privata, di “volontariato”. La nobiltà aveva in qualche modo istituzionalizzata la carità, e questo era un modo per preservare, innanzi tutto, la propria libertà e quella, congiunta, di Venezia. Attraverso un complesso sistema di aiuto ai poveri, veicolato da corporazioni e confraternite, e aiuto alle arti.
Ecco dunque uno stato che anziché invecchiare, “ringiovanisce”. Meravigliosa metafora che indica un sistema di governo che non altera mai le sue solide basi, e il suo consenso dal basso, ma li rinnova tatticamente e senza passaggi bruschi, per rimanere all’altezza dei tempi. Da notare poi come Boccalini avesse ben chiaro il problema abilmente risolto dai veneziani: non v’era solo disparità di ricchezza tra popolo e patriziato, ma anche all’interno della nobiltà stessa. Ma anche questa disparità non era mai fomite di rivolte potenzialmente distruttive. La carità agiva in modo verticale ed orizzontale, e molto discretamente. Non solo, ma uno degli interlocutori nota come, anziché imporre nuove tasse al popolo, il patriziato molto spesso mettesse le mani nelle proprie tasche per opere di interesse pubblico. Ecco che la carità privata assumeva un’ulteriore dimensione pubblica. E la Repubblica proseguiva nella propria diuturna vicenda. La carità privata era fondamento dunque del benessere pubblico, e del consenso “dal basso” di cui questa città – ma ogni città, ogni Stato – ha fondamentale bisogno.
 “La contesa nata tra molti letterati, quale nella floridissima republica di Vinegia sia la più preclara legge politica, quale il più prestante costume degno di lode straordinaria, dalla stessa serenissima Libertà veneziana, dai medesimi letterati concordemente eletta arbitra, è decisa e terminata”. Degna di esser scritta è la virtuosa contesa che sei giorni sono nacque tra alcuni letterati di questo stato; i quali mentre discorrevano degli ordini egregi, delle leggi prestantissime e degli altri più rari instituti che in così sublime grandezza mantengono la serenissima repubblica veneziana, sorse tra essi disparere, qual meritasse di avere il primo luogo. E perché ognuno di quei virtuosi ostinatamente come migliore difendeva la sua opinione, affine che tanta differenza senza alterazion di animi fosse decisa, concordemente vennero in questa risoluzione di comparir tutti avanti la stessa serenissima Libertà veneziana, alla quale prima dicessero i sensi loro, e poi a quello si quietassero ch’ella avesse giudicato. Il tutto dunque fu fatto saper a quella serenissima dama, la quale graziosamente si contentò di dar a quei virtuosi la soddisfazione che desideravano.
“La contesa nata tra molti letterati, quale nella floridissima republica di Vinegia sia la più preclara legge politica, quale il più prestante costume degno di lode straordinaria, dalla stessa serenissima Libertà veneziana, dai medesimi letterati concordemente eletta arbitra, è decisa e terminata”. Degna di esser scritta è la virtuosa contesa che sei giorni sono nacque tra alcuni letterati di questo stato; i quali mentre discorrevano degli ordini egregi, delle leggi prestantissime e degli altri più rari instituti che in così sublime grandezza mantengono la serenissima repubblica veneziana, sorse tra essi disparere, qual meritasse di avere il primo luogo. E perché ognuno di quei virtuosi ostinatamente come migliore difendeva la sua opinione, affine che tanta differenza senza alterazion di animi fosse decisa, concordemente vennero in questa risoluzione di comparir tutti avanti la stessa serenissima Libertà veneziana, alla quale prima dicessero i sensi loro, e poi a quello si quietassero ch’ella avesse giudicato. Il tutto dunque fu fatto saper a quella serenissima dama, la quale graziosamente si contentò di dar a quei virtuosi la soddisfazione che desideravano.
Pietro Crinito dunque fu il primo, che disse che, essendo legge certissima che tutte le cose che si veggono sotto la luna nascano prima, crescano poi e invecchiando manchino alla fine, cosa degna di molta ammirazione gli pareva che la sola republica veneziana con gli anni ogni giorno più si vedesse ringiovenire, e che quelle leggi, quegli ordini e quegli ottimi instituti, che negli altri principati, dopo molto essersi rilassati, andavano alla fine in dimenticanza, solo in Vinegia si vedessero crescere in rigore, in accuratezza, in maggior diligenza di più stretta osservanza: beneficio quale operava che nella eccelsa republica veneziana non si erano giammai vedute quelle riforme di governo, quei ripigliamenti di stato, che con infiniti tumulti tanto spesso usarono la republica romana e la fiorentina, essendo proprissima virtù del senato veneziano, con la severa osservanza delle sue antiche leggi, perpetuarsi nella sua florida libertà; e che in Vinegia non vedendosi quei difetti che par che non sappiano schifar gli altri potentati, che le diligenze, anco esquisite, in brieve tempo terminino in quelle supine negligenze che ad ogni libertà e a tutti i principati togliono la vita, meritamente gli parea di poter affermare come per cosa certissima, per così fatta prudenza la republica veneziana dover essere eterna col mondo sopra la terra.
Appresso disse Angelo Poliziano che e quello che avea raccontato Pietro Crinito e altri mille ordini veramente eccellentissimi egli ammirava nella prudentissima republica veneziana; ma che rarissima cosa li pareva essere che una republica aristocratica, il vero fondamento della quale dagli scrittori più intendenti delle republiche era riputata la parità de’ beni tra la nobiltà, così lungo tempo avesse potuto mantenersi in tanta pace e grandezza in quella sproporzionata disuguaglianza di ricchezze che grandissima si vede nella nobiltà veneziana; nella quale ancor che si trovino i due tanto pericolosi estremi delle immense facoltadi e della molta povertà, in Vinegia nondimeno non si vedeva quel difetto che pareva che con umane leggi non fosse possibile proibire, che il ricco calpestasse il povero; il quale, ancor che grandemente invidiasse la fortuna dei facoltosi, o per la sviscerata carità che in tutta la nobiltà veneziana regna verso la pubblica libertà, o perché le ricchezze, ancorché grandissime, da chi le possiede verso gl’inferiori non fossero abusate, tanto il povero quanto il facoltoso in quella felicissima patria con somma modestia si vedevano viver in pace.
Dopo il Poliziano, disse Pierio Valeriano che l’unico miracolo che altri sommamente doveva ammirare nella republica veneziana, era il sito raro e mirabilissimo dove ella ha fondata la metropoli del suo imperio; dal quale credeva che i signori veneziani immediatamente dovevano riconoscere il benefizio grandissimo dell’augustissima libertà loro, come quello che perpetuamente gli ha assicurati dalle forze di molti prencipi stranieri, che hanno tentato di por loro la catena della servitù al piede.
Seguì poi Giulio Cesare Scaligero, e disse che lo stupor grande della Libertà veneziana, quale di meraviglia empiva il mondo tutto, era che la stessa nobiltà che governava, non solo con animo pazientissimo pagava le gravezze antiche al pubblico erario, ma che con prontezza e facilità incredibile contro se stessa spesso ne pubblicava delle nuove, le quali rigorosamente erano poi esatte dai publici riscuotitori; e che molte volte si era veduto che i nobili veneziani negli urgenti bisogni della republica, prima di aggravar con nuovi dazi i popoli loro, avevano posto mano alla borsa propria: e il tutto con tanta liberalità e prontezza di animo sviscerato verso la pubblica libertà, che simil azione meritava di esser preposta a tutte le meraviglie che si notavano nella felicissima Libertà veneziana, come quella che chiaramente faceva conoscere ad ognuno ch’ella esquisitamente possedeva quella eccellente qualità che rende le republiche eterne, di aver la sua nobiltà tanto svisceratamente innamorata del viver libero, che alla privata utilità allegrissimamente preponeva i pubblici interessi.
Poi disse Bernardo Tasso ch’egli lungo tempo era dimorato in Vinegia, dove di niuna altra cosa più era rimaso meravigliato, che di veder quei nobili medesimi, che tanto si compiacevano de’ piaceri, delle delizie e dell’ozio, con tanta virtù di animo governar le cose pubbliche, che altrui sembravano e uomini di vita molto esemplare e signori nati alle perpetue fatiche.
Dopo il parere del Tasso, Francesco Berni, come è suo costume, con piacevolezza che diede gusto alla serenissima Libertà veneziana, disse che la più rara e mirabil cosa che gl’ingegni grandi dovevano ammirar nella republica veneziana era che non solo le lagune, ma i canali tutti della città essendo pieni di granci, i senatori veneziani nondimeno ne pigliavano così pochi, che meritamente da tutte le nazioni erano stimati il sale della terra.
Seguì poi il Sabellico, e disse che, mentre egli scriveva l’istoria veneziana, diligentemente avendo osservato gli ottimi instituti di così prestante Libertà, niuna cosa più ammirava in lei, che il danaro pubblico anco dai senatori bisognosi venisse maneggiato con tanta fedeltà, che tra la nobiltà non solo eccesso capitale, ma somma infamia fosse riputata il bruttarsi le mani di un soldo di san Marco.
Disse appresso Iacopo Sannazzaro che maravigliosa cosa gli pareva nella republica veneziana che, nella nobiltà trovandosi molti mal proveduti de’ beni di fortuna, questi nondimeno con pazienza indicibile si vedessero tollerar le miserie private, senza pur nemmeno col pensiero affettar le immense ricchezze pubbliche con quelle sediziose leggi frumentarie e agrarie, con le quali da’ suoi cittadini tanto fu travagliata la famosa republica romana; e che era cosa degna di lode e di meraviglia grande, veder che in Vinegia il nobil povero con la sola virtù si sforzava di sollevarsi dalle sue miserie, studiando rendersi meritevole di esser dalla sua patria impiegato ne’ carichi lucrosi: onde accadeva che la virtù, il valore e la bontà dell’animo al nobil povero nella republica veneziana servivano per molto ricco patrimonio.
 Soggiunse poi Giovanni Gioviano Pontano che tutto quello che era stato detto erano meraviglie grandi, ma che la maggior cosa ch’egli sempre nella Libertà veneziana avea ammirata, era che le immense ricchezze che si trovavano in alcuni soggetti nobili, non operassero quei perniziosi effetti di far gonfiar di boria e di superbia quei che le possedevano, molti de’ quali sempre si erano veduti nelle altre republiche; che però instituto rarissimo era che in Vinegia quei senatori che aveano ricchezze da prencipe, in casa poi sapessero viver da privati cittadini e nelle piazze in niuna cosa fossero differenti dai più poveri: e che solo i veneziani avevano saputo trovare il vero modo da separar dalle molte ricchezze quei mali dell’ambizione, della superbia e del séguito dei cittadini poveri, che la famosa Libertà romana non seppe e non poté proibir in Cesare, in Pompeo e in molti altri senatori facoltosi.
Soggiunse poi Giovanni Gioviano Pontano che tutto quello che era stato detto erano meraviglie grandi, ma che la maggior cosa ch’egli sempre nella Libertà veneziana avea ammirata, era che le immense ricchezze che si trovavano in alcuni soggetti nobili, non operassero quei perniziosi effetti di far gonfiar di boria e di superbia quei che le possedevano, molti de’ quali sempre si erano veduti nelle altre republiche; che però instituto rarissimo era che in Vinegia quei senatori che aveano ricchezze da prencipe, in casa poi sapessero viver da privati cittadini e nelle piazze in niuna cosa fossero differenti dai più poveri: e che solo i veneziani avevano saputo trovare il vero modo da separar dalle molte ricchezze quei mali dell’ambizione, della superbia e del séguito dei cittadini poveri, che la famosa Libertà romana non seppe e non poté proibir in Cesare, in Pompeo e in molti altri senatori facoltosi.
Fornito che ebbe il Pontano il suo ragionamento, disse il commendator Annibal Caro che sopra ogni altra meraviglia nella serenissima republica veneziana egli sempre avea ammirato lo stupor grande di veder il serenissimo prencipe di così famosa Libertà con un ossequio, una riverenza, una maestà da re e con una autorità da cittadino, e che il congiungere l’infinita venerazione con la limitata autorità, la lunghezza dell’imperio del prencipe con la modestia, erano temperamenti stati ignoti alla prudenza degli antichi legislatori delle republiche passate, sapienza solo felicemente praticata dal senato veneziano.
Bartolomeo Cavalcanti disse appresso che, come avea notato il Pontano, cosa molto rara era veder nella republica veneziana che le facoltà de’ grandi non facessero insuperbire i senatori ricchi; ma che portento molto maggiore era veder che tali fossero gli ordini di quella eccelsa Libertà, tali le santissime leggi di quella eterna republica, che né anco i carichi più supremi attaccassero punto di ambizione e di superbia a quei che con somma autorità gli avevano maneggiati: particolarità altrettanto degna di considerazione, quanto in qualsivoglia altro prencipato o ben constituita republica non mai era stata veduta, come quella che direttamente repugnava alla stessa natura delle cose; e che allora ch’egli fu in Vinegia, non ammirò il ricchissimo tesoro di san Marco, non l’arsenale, non il canal grande co’ superbi palagi de’ Cornari, de’ Grimani, de’ Foscari e gli altri edifizi magnificentissimi con spese reali fabbricati in quella miracolosa città, meraviglie solo notate dagli uomini ordinari; ma che cosa veramente ammiranda gli parve che fosse vedere il signor Sebastiano Venieri, poco prima stato generale di così potente armata, famosissimo per la gloriosa vittoria navale che avea ottenuta contro il Turco, ritornar privato in Vinegia, e con tanta civil modestia passeggiar la piazza, che in nessuna cosa era dissimile da que’ senatori che non si erano partiti dalla città; e che nella republica veneziana era cosa troppo singolare che i suoi nobili tanta civil modestia e tanta umanità sapessero usare in casa, e che poi fuori ne’ magistrati importanti, ne’ carichi grandi, con la magnificenza, con la splendidezza e con una reale liberalità si facessero conoscere al mondo non cittadini di una ben ordinata republica, ma uomini nati per comandare soggetti discesi da sangue reale; che però credea certo non altra nazione poter trovarsi al mondo, che meglio sapesse l’arte di accommodarsi alla modestia dell’ubbidire e alla grandezza del comandare, della nobiltà veneziana: cosa in tanto vera, che dove le altre republiche, per riputazione de’ pubblici magistrati, erano state forzate ricordare a’ loro senatori che con la magnificenza dell’animo grande procacciassero di sostener la maestà del grado publico, il senato veneziano più volte era stato necessitato pubblicar severe leggi per proibir, a quei che fuori della città esercitavano le prefetture e gli altri carichi pubblici, la soverchia virtù della splendidezza e della magnificenza.
Così disse il Cavalcanti, quando Flavio Biondo soggiunse che quando egli fu in Vinegia, in infinito rimase confuso allora che vide che in una pura aristocrazia la cittadinanza e la plebe veneziana con tanta sodisfazione vivessero in quella felicissima patria, che in molti mesi ch’egli vi fece dimora non mai seppe chiarirsi se la pubblica Libertà veneziana più fosse amata e tenuta cara dalla nobiltà che comandava, che dalla cittadinanza e dalla plebe che ubbidivano.
Appresso seguì Paolo Giovio, e disse che non solo a lui, ma a molti prencipi grandi, co’ quali a lungo più volte egli avea discorso delle meraviglie che si scorgono nel governo della republica veneziana, parea cosa degna di sommo stupore che il senato di quella eccelsa republica non in altro più studiasse che alla pace, e non ad altro con vigilanza e assiduità maggiore più attendesse che a perpetuamente far preparamenti da guerra, e che la pace armata con tutte le sue esquisitezze solo si vedeva nella floridissima republica veneziana.
Al Giovio seguì Giovanni Boccaccio, e disse che il vero sale che dalla putrefazione delle corruttele d’ogni abuso e di tutti i disordini preservava la Libertà veneziana, era quella principalissima reina di tutte le leggi, quell’ottimo instituto, tanto inviolabilmente osservato da lei, che per esaltar un senatore a’ gradi più supremi non la grandezza del parentado, non la splendidezza delle molte ricchezze, non i meriti de’ padri e degli altri antenati, ma il nudo valore, la virtù stessa di colui che chiedeva il magistrato, erano avuti in considerazione; onde accadeva che in Vinegia la nobiltà viziosa e ignorante facea numero, mentre solo la virtuosa e meritevole comandava e governava con quella prudenza che era nota a tutto il mondo.
Ma Leonardo Aretino, dapoiché molto ebbe lodato il parer del Boccaccio, soggiunse che l’uso eccellente della republica veneziana di non dar alla sua nobiltà carichi di salto, ma graduatamente, era quella base saldissima dove era fondata la grandezza e l’eternità di tanta Libertà, e che mirabilissimo precetto era che qualsivoglia nobile per salir alle supreme dignitadi, fino dalla sua prima giovanezza fosse sforzato cominciar da’ più bassi magistrati: costume saluberrimo, come quello che partoriva l’effetto importantissimo di mantener quella vera e sostanziale uguaglianza tra la nobiltà di una aristocrazia, che dà lunga vita al viver libero; perché appresso i veri intendenti delle cose di Stato, non la parità de’ beni faceva uguali i senatori nelle republiche, ma che tutti i nobili fossero costretti di camminare alla grandezza delle dignitadi più supreme per la strada medesima di cominciar il corso de’ magistrati dalle stesse ultime mosse. Legge degna della molta sapienza veneziana, della quale perché affatto fu priva l’antica republica romana, ella fu di corta vita nella sua libertà, e quella brieve che ebbe, fu travagliata da pericolosissime infermitadi di tumultuose sollevazioni. Perché l’abuso bruttissimo di dar i consolati della patria libera e gl’importantissimi carichi della cura degli eserciti a Pompeo, a Cesare e ad altri soggetti facoltosi nella prima giovanezza loro, altro non fu che più tosto trattarli da uomini nati di sangue reale, da signori e padroni della patria libera, che da senatori di una ben ordinata republica. Percioché essendo verissimo che quella è ben regolata libertà, dove anco a’ senatori di sommo valore e di merito infinito sempre avanza una dignità grande da sperare, la quale a’ soggetti avidi della vera gloria serve di acuto sprone, che battendo loro il fianco dell’onorata ambizione velocemente li fa correre nella strada diritta della virtù per poter giunger poi alla meta del magistrato bramato, a Cesare e a Pompeo, che nella prima fanciullezza loro dalla republica romana con mortal imprudenza ottennero i primi onori e le più supreme dignitadi, qual altro grado maggiore avanzava da sperar nella vecchiaia, che quella assoluta signoria della tirannide, alla quale Cesare scopertamente, Pompeo con più cupi artifici aspirarono poi? Disordine gravissimo, e dal quale la famosa libertà romana dovea riconoscere la sua morte.
Ancorché la stessa serenissima Libertà veneziana segni grandissimi desse che il parer dell’Aretino sommamente le fosse piaciuto, comandò nondimeno agli altri virtuosi che avanzavano, che seguissero a dir le opinioni loro. Allora Benedetto Varchi così cominciò: — La mia republica fiorentina, che non mai ebbe fortuna da saper tra le sue famiglie nobili introdur la pace, l’unione e quel vicendevole amore che eterna rende la libertà delle republiche, alla fine fu forzata di cadere nell’infermità della servitù; ora a me cosa che supera tutte le più rare umane meraviglie par che sia che un nobile veneziano, ancorché gravissimamente offeso nella vita de’ suoi figliuoli e nella propria sua persona, più violentato dall’ardente carità verso la patria libera, che spaventato dal rigor de’ magistrati, con animo franchissimo sappia far la dura risoluzione di perdonar in quell’ora medesima al suo nemico l’ingiuria che ha ricevuta: risoluzione per certo ammiranda e altrettanto degna di stupor infinito, quanto apertamente si vede che il nobile veneziano di buonissima voglia nelle mani del senato sa rimetter quella vendetta dell’ingiuria ricevuta, per la quale tanta renitenza sentono gli uomini sensuali nel donarla a quel Dio dal quale riconosciamo ogni nostro bene. —
Così disse il Varchi, quando Lodovico Dolce soggiunse che se quello era vero che confessavano tutti, che la più rara e più pregiata grandezza che potea considerarsi in un prencipe era il disarmar con facilità e senza pericolo alcuno un suo capitan generale, e da lui, anco allora che sapea di esser chiamato dal prencipe adirato o grandemente insospettito della sua fede, ricever esatta ubbidienza, che per certo degna di esser anteposta a tutte le altre cose mirabili dagli altri notate nella republica veneziana, li parea che fosse ch’ella non solo con facilità grande disarmasse i suoi capitani generali di mare, ma che anco allora che i suoi ministri più principali conoscevano il senato sdegnatissimo, e che però erano sicuri di ricever da lui severissimo castigo, ancorché si trovassero assenti, armati e in carichi grandi, se accadeva che dalla republica fossero chiamati, con tanta prontezza d’animo erano veduti ubbidire, che deposte l’armi e l’autorità de’ pubblici magistrati, correvano in Vinegia per esser dagli amici e da’ parenti loro giudicati anco con la pena capitale. Cosa che per molti esempi che all’età sua in quella serenissima republica si erano veduti, aveva empiuto il mondo tutto di stupore: che però li parea di poter dire che li si facea torto apertissimo, se tanta autorità della republica veneziana, se tanta sommessione, tanta ubbidienza e così inaudita carità della nobiltà veneziana verso la pubblica Libertà non veniva anteposta a tutte quelle leggi ammirande e ottimi instituti, che avanti lui avevano raccontati gli altri.
La serenissima Libertà veneziana, che senza mai rispondere cosa alcuna a quei virtuosi aveva udito tanti suoi lodevolissimi ordini e tante sue meravigliose prerogative, disse al Dolce che quella ch’egli aveva raccontata era cosa degna di grandissima considerazione, ma che però era beneficio anco posseduto dagli imperadori ottomani: ma che da una sola prerogativa ch’ella esattamente possedeva, e nella quale si conosceva avanzar ogni principato e qualsivoglia passata e presente republica, riconoscea tutta la sua grandezza, la quale per ancora da nessuno di quei virtuosi era stata detta.
Allora Dionigi Atanagi disse che la più rara meraviglia che dagl’ingegni grandi nella republica veneziana fino alle stelle con ogni sorte di lode esaggerata meritava di esser esaltata, era il vedere che il tremendo tribunale de’ capi de’ Dieci e il supremo magistrato degli inquisitori di stato con tre sole palle di tela con facilità incredibile seppellivano vivo qualsivoglia Cesare, qualsivoglia Pompeo che vedevano scoprirsi in quella ben ordinata republica.
Non così tosto ebbe l’Atanagi detto il parer suo, che Girolamo Mercuriale soggiunse che, mentre egli si trovava in Padova nella sua carica di leggere in quelle famose scuole medicina, seppe che alcuni plebei, conforme al costume loro, essendo in Vinegia andati al lito del mare per ivi sollazzarsi con alcune giovani cortigiane che con esso loro avevano menate, da più giovani nobili veneziani talmente furono strapazzati, che avendo quelli posto mano alle armi, uno ne uccissero e gli altri maltrattarono: per lo qual delitto da’ giudici essendo stati chiamati alle scale, quei plebei, ancor che vedessero i giudìci tutti in mano della nobiltà offesa, tanto nondimeno sperarono nella rettitudine del senato, nella esquisitissima giustizia de’ tribunali criminali, che non dubitarono di comparir avanti i giudici e porsi prigioni, e che punto della buona opinione loro non si ingannarono, perché nelle difese loro avendo i giudici pienamente conosciute le molestie date loro da quei nobili, con eterna gloria dell’incorrotta giustizia veneziana gli assolsero come innocenti. E che portento non più veduto, e che da quei che non lo praticavano non poteva credersi, era che il nobile, ancorché potente per parentado, grande per ricchezze conspicue e per gli onori ricevuti nella republica di somma autorità, nel piatire più duro avversario provasse il cittadino che il nobile suo pari; e che se il precetto politico, dagli uomini grandi lasciato scritto, che le aristocrazie non morivano mai quando la gioventù nobile usava la modestia, i tribunali mantenevano la giustizia uguale, era vero, ch’egli non sapea vedere quando mai la felicissima Libertà veneziana, tanto severa nelle dissoluzioni de’ suoi nobili, tanto esquisitamente giusta ne’ suoi tribunali, dovesse aver fine.
L’ultimo di tutti volle essere il dottissimo Ermolao Barbaro; il quale disse che allora nelle patrie libere introducendosi la tirannide, quando i secreti più importanti della republica con pochi senatori erano comunicati, la prestantissima Libertà veneziana, per fuggire di far naufragio in così pericoloso scoglio, communicava i secreti e deliberava le faccende più importanti del suo stato nel supremo magistrato dei Pregadi, numeroso di più di dugento cinquanta senatori; e che cosa gli pareva degna di stupor grande che la republica veneziana in così gran numero di senatori trovasse quella secretezza, che con tante diligenze e con tanti buoni trattamenti di liberalissimi doni i prencipi molte volte indarno cercavano in un solo secretario, in un paio di consiglieri. Allora la serenissima Libertà veneziana pose la mano sopra la spalla del Barbaro, e così gli disse: — Voi avete nominata quella preziosa gioia della quale io tanto mi pregio e per la quale merito di esser da ognuno invidiata, mercé che per ben governar gli stati non meno è necessaria la secretezza che il buon consiglio.