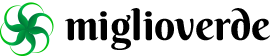La presentazione di Elogio del contante, l’ultimo lavoro che conclude la trilogia degli “elogia” libertari di Leonardo Facco, ha avuto luogo a Prato della Valle, a Padova, presso l’Alchimia, il 18 maggio. Per me, non solo è stata l’occasione per rivedere personalità del mondo libertario e liberale-classico da cui dipenderà molto del futuro del Veneto, da Novello Papafava ad Alberto Berardi, ma anche per riassaporare, in una lunga passeggiata per cerchi concentrici, uno dei luoghi patavini che maggiormente amo, e senz’altro uno dei luoghi a maggior densità storica al mondo, aldilà del fatto banale che non si tratti né di un prato, né di una valle, né a ben vedere di una piazza, “circle” o “square”, “campo” o “campiello”, ma sia cosa a sé, per così dire, come cose a sé, manufatti peculiari, sono la gran parte degli edifici della Serenissima, compreso San Marco, compreso Palazzo Ducale. Vi sono interi paesi del mondo che non hanno, entro i loro confini, le opere d’arte e architettura racchiuse in questo perimetro, e poco oltre.
 Per intanto, ne sono uscite dodici fotografie in una serata di cielo tiepolesco, davvero crepuscolare, di questa “primavera che tarda ad arrivare”, per citare il titolo dell’ultimo romanzo del mio collega, friulano, Flavio Santi. E che probabilmente non arriverà mai, soppiantata ex abrupto dall’Estate. Qui le propongo, ad uso ed abuso dei lettori, senza volermi certo mettere a confronto con i grandi fotografi che hanno posato l’obiettivo su questo oggetto così fotogenico, ma anche così difficile, nelle ambasce che colgono anche i pittori, del resto: costretti a cogliere una forma pluricircolare, un anello – come l’anello che sposa ogni anno Venezia, ma il Veneto tutto, alle acque – e costringerla nel rettangolo o nel quadrato della tesa. Solo il fish-eye, l’antico obbiettivo ad occhio di pesce (di laguna, di lago, di mare, quel che sia) può darne, forse, degna epitome. Splendido il volume pubblicato da un fotografo genovese – singolare i rapporti di questi genovesi col Veneto, tutti da indagare, ancora – Lorenzo Capellini, nel 2001, con prefazione di Vittorio Sgarbi, dedicato al Prato, alle sue statue mirabili, ma superstiti, invero, di una discreta, mirata falcidie.
Per intanto, ne sono uscite dodici fotografie in una serata di cielo tiepolesco, davvero crepuscolare, di questa “primavera che tarda ad arrivare”, per citare il titolo dell’ultimo romanzo del mio collega, friulano, Flavio Santi. E che probabilmente non arriverà mai, soppiantata ex abrupto dall’Estate. Qui le propongo, ad uso ed abuso dei lettori, senza volermi certo mettere a confronto con i grandi fotografi che hanno posato l’obiettivo su questo oggetto così fotogenico, ma anche così difficile, nelle ambasce che colgono anche i pittori, del resto: costretti a cogliere una forma pluricircolare, un anello – come l’anello che sposa ogni anno Venezia, ma il Veneto tutto, alle acque – e costringerla nel rettangolo o nel quadrato della tesa. Solo il fish-eye, l’antico obbiettivo ad occhio di pesce (di laguna, di lago, di mare, quel che sia) può darne, forse, degna epitome. Splendido il volume pubblicato da un fotografo genovese – singolare i rapporti di questi genovesi col Veneto, tutti da indagare, ancora – Lorenzo Capellini, nel 2001, con prefazione di Vittorio Sgarbi, dedicato al Prato, alle sue statue mirabili, ma superstiti, invero, di una discreta, mirata falcidie.

 Sì, perché la storia di Pra’ della Valle è storia di tragedie, a ben vedere, tragedie evidenti e drammi nascosti, dal suo inizio, in età romana, fino al suo trionfo, alla fine del Settecento, con l’invenzione di Andrea Memmo – discepolo del Lodoli, forse suo amante, nella felice libertà sessuale del regime antico, dove gli istinti ancora non erano né sindacalizzati né categorizzati, per ottenere benefici di Stato, alla faccia di ogni “pride” – che lo rende tuttora quel che è. Non solo le statue di sei dogi vennero abbattute dalla soldataglia napoleonica nel 1797, ma tale scempio costrinse a ridisegnarne il percorso, ma tutta una serie di secolarizzazioni, distruzioni, sfaceli, alterò e di molto il progetto del Memmo. Andrea Memmo, per intanto. Figura enigmatica, quella del Memmo, provveditore straordinario a Padova nel 1775, discendente da favolosa casa del tutto immiserita, tanto che la sua stessa fine fu in povertà assoluta, avendo dovuto vendere quel che gli restava per dotare le figlie. Rimane aperta una questione: se fosse stato eletto doge lui, nel 1789, anziché Lodovico Manin, la Serenissima sarebbe stata maggiormente preparata nel suo ultimo atto di vita, negli “ultimi suoi giorni tristi”, per dirla con Francesco Guccini? Rimane un mistero, ché Memmo morì nel 1793, non vide la fine della Patria, per sua fortuna. Il mistero lo svela un libro su di lui, di uno storico di mirabili e profonde visioni, Gianfranco Torcellan, discepolo del grande Franco Venturi: Una figura della Venezia settecentesca: Andrea Memmo. Ricerche sulla crisi dell’aristocrazia veneziana, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1963). Purtroppo Torcellan morì a soli 28 anni, chissà quant’altro avrebbe potuto fare, e dire.
Sì, perché la storia di Pra’ della Valle è storia di tragedie, a ben vedere, tragedie evidenti e drammi nascosti, dal suo inizio, in età romana, fino al suo trionfo, alla fine del Settecento, con l’invenzione di Andrea Memmo – discepolo del Lodoli, forse suo amante, nella felice libertà sessuale del regime antico, dove gli istinti ancora non erano né sindacalizzati né categorizzati, per ottenere benefici di Stato, alla faccia di ogni “pride” – che lo rende tuttora quel che è. Non solo le statue di sei dogi vennero abbattute dalla soldataglia napoleonica nel 1797, ma tale scempio costrinse a ridisegnarne il percorso, ma tutta una serie di secolarizzazioni, distruzioni, sfaceli, alterò e di molto il progetto del Memmo. Andrea Memmo, per intanto. Figura enigmatica, quella del Memmo, provveditore straordinario a Padova nel 1775, discendente da favolosa casa del tutto immiserita, tanto che la sua stessa fine fu in povertà assoluta, avendo dovuto vendere quel che gli restava per dotare le figlie. Rimane aperta una questione: se fosse stato eletto doge lui, nel 1789, anziché Lodovico Manin, la Serenissima sarebbe stata maggiormente preparata nel suo ultimo atto di vita, negli “ultimi suoi giorni tristi”, per dirla con Francesco Guccini? Rimane un mistero, ché Memmo morì nel 1793, non vide la fine della Patria, per sua fortuna. Il mistero lo svela un libro su di lui, di uno storico di mirabili e profonde visioni, Gianfranco Torcellan, discepolo del grande Franco Venturi: Una figura della Venezia settecentesca: Andrea Memmo. Ricerche sulla crisi dell’aristocrazia veneziana, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1963). Purtroppo Torcellan morì a soli 28 anni, chissà quant’altro avrebbe potuto fare, e dire.
 Certo è che questo mirabile ultima opera, o tra le ultime, della Serenissima, non so davvero quanto di serenissimo abbia o quanto alluda, piuttosto, alle antiche libertà patavine, dopo la strage dei Carraresi – vera o presunta – ma non tale da far sì che ci sia ora negato un Novello, di sì nobile (e ben viva) stirpe. Poco prima del passaggio di Padova alla Dominante, nel 1399, il 7 ottobre per la precisione, vi fu, in un Prato pre-memmiano e post-romano, e post-medievale la gran processione dei Bianchi invocanti la pace per il secolo a venire. Per i redattori solerti di wikipedia: bene ricordare che il 7 ottobre era l’anniversario di Lepanto, non data scelta a caso. I barbari che distrussero le statue dei Dogi nel 1797 lo fecero forse su indicazione di qualche rancoroso patavino? Certo né Napoleone né Cavour restituirono la “patavina libertas”. Mi pare. Almeno. Anzi. E dunque anche Memmo va visto come figlio di una Serenissima in disarmo, oltre che disarmata. E sarà stato proprio un caso, che la prima statua, poi rimossa, fatta “per prova”, fosse quella di Cicerone? A quale “Italia” si voleva arridere, evocando e
Certo è che questo mirabile ultima opera, o tra le ultime, della Serenissima, non so davvero quanto di serenissimo abbia o quanto alluda, piuttosto, alle antiche libertà patavine, dopo la strage dei Carraresi – vera o presunta – ma non tale da far sì che ci sia ora negato un Novello, di sì nobile (e ben viva) stirpe. Poco prima del passaggio di Padova alla Dominante, nel 1399, il 7 ottobre per la precisione, vi fu, in un Prato pre-memmiano e post-romano, e post-medievale la gran processione dei Bianchi invocanti la pace per il secolo a venire. Per i redattori solerti di wikipedia: bene ricordare che il 7 ottobre era l’anniversario di Lepanto, non data scelta a caso. I barbari che distrussero le statue dei Dogi nel 1797 lo fecero forse su indicazione di qualche rancoroso patavino? Certo né Napoleone né Cavour restituirono la “patavina libertas”. Mi pare. Almeno. Anzi. E dunque anche Memmo va visto come figlio di una Serenissima in disarmo, oltre che disarmata. E sarà stato proprio un caso, che la prima statua, poi rimossa, fatta “per prova”, fosse quella di Cicerone? A quale “Italia” si voleva arridere, evocando e 
 installando l’avvocato della romanità? Il percorso ideologico delle statue superstiti, a quale “patavinitas” non veneziana vuole velatamente, o non tanto velatamente alludere? In fondo l’ultima statua collocata nel Prato, quella del medico Francesco Luigi Fanzago, ci parla di un uomo che nacque sotto la Serenissima ma fece splendida carriera in età napoleonica e poi austriaca. La sua statua venne collocata nel 1838. Fu autore di fondamentali studi sulla pellagra. Che non s’attenuò, ma crebbe, nel passaggio dal regime antico, di libertà, a quelli nuovi, di schiavitù (mal intesa, a volte, per libertà). Già dall’inizio del progetto vi grava un’ombra – almeno parzialmente – romana, quella di Piranesi. Nel passaggio da Venezia – e prima da Mogliano Veneto – alla città eterna, ma non meno eterna della Serenissima, in fondo. Prato della Valle è un prisma dove, atrocemente, splendidamente, si misura la fine di un regime ed i timidi vagiti di uno nuovo. In un numero infinito di tappe, passando dalle riflessioni del veneziano Vincenzo Radicchio sulla fabbrica del Prato (stampate, significativamente, però, a Roma, nel 1786, fino ai progetti del 1863, che precedono di tre anni l’annessione, di erezione di statue, poi messe fuori dal percorso, a Giotto e Dante: non patavini, non veneziani, ma a Padova legatissimi, ovviamente. Ed ecco gli scritti dei patavini del tempo, Melchior Missirini, e soprattutto Pietro Selvatico, autore di guide turistiche perfette, e perfettamente patriottiche, ma in senso più “italiano” che “veneto”, o “serenissimo”, che dir si voglia. Missirini era di Forlì: repubblicano, filonapoleonico, uomo per tutte le stagioni, morto nel 1849. Pietro Selvatico d’Este era un architetto neogotico, non a caso. Le Edizioni della Normale, sede dunque di indubitato prestigio, ha ripubblicato nel 2007 il suo scritto sull’educazione del “pittore storico odierno”, e le sue guide di Padova e Venezia ebbero gran successo nell’Ottocento. Il richiamo al gotico riporta, ovviamente, e deliberatamente, a temi, e tempi, pre-Serenissima, libertà antiche che l’Italia però non mi pare abbia né restaurato, né particolarmente omaggiato.
installando l’avvocato della romanità? Il percorso ideologico delle statue superstiti, a quale “patavinitas” non veneziana vuole velatamente, o non tanto velatamente alludere? In fondo l’ultima statua collocata nel Prato, quella del medico Francesco Luigi Fanzago, ci parla di un uomo che nacque sotto la Serenissima ma fece splendida carriera in età napoleonica e poi austriaca. La sua statua venne collocata nel 1838. Fu autore di fondamentali studi sulla pellagra. Che non s’attenuò, ma crebbe, nel passaggio dal regime antico, di libertà, a quelli nuovi, di schiavitù (mal intesa, a volte, per libertà). Già dall’inizio del progetto vi grava un’ombra – almeno parzialmente – romana, quella di Piranesi. Nel passaggio da Venezia – e prima da Mogliano Veneto – alla città eterna, ma non meno eterna della Serenissima, in fondo. Prato della Valle è un prisma dove, atrocemente, splendidamente, si misura la fine di un regime ed i timidi vagiti di uno nuovo. In un numero infinito di tappe, passando dalle riflessioni del veneziano Vincenzo Radicchio sulla fabbrica del Prato (stampate, significativamente, però, a Roma, nel 1786, fino ai progetti del 1863, che precedono di tre anni l’annessione, di erezione di statue, poi messe fuori dal percorso, a Giotto e Dante: non patavini, non veneziani, ma a Padova legatissimi, ovviamente. Ed ecco gli scritti dei patavini del tempo, Melchior Missirini, e soprattutto Pietro Selvatico, autore di guide turistiche perfette, e perfettamente patriottiche, ma in senso più “italiano” che “veneto”, o “serenissimo”, che dir si voglia. Missirini era di Forlì: repubblicano, filonapoleonico, uomo per tutte le stagioni, morto nel 1849. Pietro Selvatico d’Este era un architetto neogotico, non a caso. Le Edizioni della Normale, sede dunque di indubitato prestigio, ha ripubblicato nel 2007 il suo scritto sull’educazione del “pittore storico odierno”, e le sue guide di Padova e Venezia ebbero gran successo nell’Ottocento. Il richiamo al gotico riporta, ovviamente, e deliberatamente, a temi, e tempi, pre-Serenissima, libertà antiche che l’Italia però non mi pare abbia né restaurato, né particolarmente omaggiato.

 Nel secolo a venire, l’equivalente delle statue del Prato, lo troviamo a Venezia nel “Panteon Veneto” a Palazzo Loredan, una delle sedi del prestigioso Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Impresa durata dal 1847 al 1932, meravigliosa costruzione di una veneticità italiana, quasi che il Leone dovesse assorbirsi nel tricolore, tricolorarsi, insomma, per dir così. Uno studio comparato – che lascio volentieri ai giovani studiosi – delle statue in Prato e dei busti del Panteon, porterebbe volentieri a risultati notevoli: certamente, forse neppure nelle intenzioni del Memmo v’era una celebrazione della Serenissima, ma una esaltazione di Padova, dal 1404 sottomessa, e felicemente per molti aspetti (non per tutti) al Leone marciano.
Nel secolo a venire, l’equivalente delle statue del Prato, lo troviamo a Venezia nel “Panteon Veneto” a Palazzo Loredan, una delle sedi del prestigioso Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Impresa durata dal 1847 al 1932, meravigliosa costruzione di una veneticità italiana, quasi che il Leone dovesse assorbirsi nel tricolore, tricolorarsi, insomma, per dir così. Uno studio comparato – che lascio volentieri ai giovani studiosi – delle statue in Prato e dei busti del Panteon, porterebbe volentieri a risultati notevoli: certamente, forse neppure nelle intenzioni del Memmo v’era una celebrazione della Serenissima, ma una esaltazione di Padova, dal 1404 sottomessa, e felicemente per molti aspetti (non per tutti) al Leone marciano.
 Prato della Valle, mirabilmente guardato da vicino da Santa Giustina, da lontano da Sant’Antonio, cinto nelle braccia della santità, è monumento voluto laico, già ai tempi della Serenissima: né le persone in vita, né i Santi, potevano essere ospitati. Siamo nel 1776, quando queste regole, sotto Memmo, vennero introdotte. Un percorso dunque tutto laico, e tutto maschile, salvo per Gaspara Stampa, poetessa e patavina bellissima, almeno secondo i ritratti. Vi aleggia l’ombra, certo, dell’amante del Memmo, la celebre Giustiniana Wynne – ed ad Andrea di Robilant dobbiamo il bel romanzo che narra la vicenda, alla fine molto terra terra, dei due – scrittrice, come il Goldoni, però, o Casanova (suo amico), che scriveva soprattutto in francese. E che scelse Padova per i suoi ultimi anni. A Padova, nella splendida, ma poco nota chiesa di San Benedetto Vecchio, in riviera San Benedetto, giacciono le sue spoglie mortali. Senz’altro, fu ammiratrice di Gaspara Stampa. Forse una statua alla Cornaro Piscopia, prima laureata al mondo (a Padova) non avrebbe stonato, ma per fortuna c’è, commovente, al Bo.
Prato della Valle, mirabilmente guardato da vicino da Santa Giustina, da lontano da Sant’Antonio, cinto nelle braccia della santità, è monumento voluto laico, già ai tempi della Serenissima: né le persone in vita, né i Santi, potevano essere ospitati. Siamo nel 1776, quando queste regole, sotto Memmo, vennero introdotte. Un percorso dunque tutto laico, e tutto maschile, salvo per Gaspara Stampa, poetessa e patavina bellissima, almeno secondo i ritratti. Vi aleggia l’ombra, certo, dell’amante del Memmo, la celebre Giustiniana Wynne – ed ad Andrea di Robilant dobbiamo il bel romanzo che narra la vicenda, alla fine molto terra terra, dei due – scrittrice, come il Goldoni, però, o Casanova (suo amico), che scriveva soprattutto in francese. E che scelse Padova per i suoi ultimi anni. A Padova, nella splendida, ma poco nota chiesa di San Benedetto Vecchio, in riviera San Benedetto, giacciono le sue spoglie mortali. Senz’altro, fu ammiratrice di Gaspara Stampa. Forse una statua alla Cornaro Piscopia, prima laureata al mondo (a Padova) non avrebbe stonato, ma per fortuna c’è, commovente, al Bo.

 Ora, vorrei concludere come Leonardo Facco ha concluso il proprio intervento in Prato della Valle, con una poesia. Ma, purtroppo, mi tocca concludere in prosa. E dura. Quel che ho scritto sul Pra’ deve essere letto con attenzione politica: la creazione di un Veneto libero dovrà tener conto di tensioni immense non solo all’interno delle componenti del Veneto di ora, che mi pare sempre più lacerato e triste, ma anche all’interno della Venetia del 1775, quando Memmo mise mano al Prato, e quando, pur anziana, la Serenissima esisteva ancora. Tensioni tra Padova e Venezia, tra laicità e religione, tra capitali in crisi, soprattutto, in questo caso, tra Venezia e Roma, mentre Parigi e Londra attraevano le menti, come fanno tuttora. Solo all’interno della pacata riconsiderazione della storia d’Italia potrà collocarsi ogni anelito all’indipendenza, che abbia, o meno, successo.
Ora, vorrei concludere come Leonardo Facco ha concluso il proprio intervento in Prato della Valle, con una poesia. Ma, purtroppo, mi tocca concludere in prosa. E dura. Quel che ho scritto sul Pra’ deve essere letto con attenzione politica: la creazione di un Veneto libero dovrà tener conto di tensioni immense non solo all’interno delle componenti del Veneto di ora, che mi pare sempre più lacerato e triste, ma anche all’interno della Venetia del 1775, quando Memmo mise mano al Prato, e quando, pur anziana, la Serenissima esisteva ancora. Tensioni tra Padova e Venezia, tra laicità e religione, tra capitali in crisi, soprattutto, in questo caso, tra Venezia e Roma, mentre Parigi e Londra attraevano le menti, come fanno tuttora. Solo all’interno della pacata riconsiderazione della storia d’Italia potrà collocarsi ogni anelito all’indipendenza, che abbia, o meno, successo.
E si passeggi tutti, indipendentisti, centralisti, federalisti, per ore al Prato e dintorni. Capiremo molte cose. Innanzi tutto, noi stessi. O cominceremo a farlo.