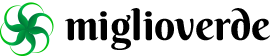La vita e l’opera di Milovan Gilas (1911-1995) è strettamente legata alla storia del comunismo nell’ex Jugoslavia. Per molti anni infatti Gilas fu l’incarnazione perfetta del dirigente comunista ortodosso e intransigente. Durante la seconda guerra mondiale divenne il braccio destro di Tito nella resistenza contro i tedeschi, che sfocerà nella conquista del potere al termine del conflitto. Nel 1948 Gilas assunse un ruolo politico di primissimo piano, spingendo Tito a rompere con l’Unione Sovietica di Stalin e a proclamare la via nazionale al comunismo. Nel 1953 divenne vicepremier e poi presidente del Parlamento jugoslavo. A questo punto tutto lasciava pensare che Gilas sarebbe diventato il successore naturale di Tito, ma improvvisamente, tra lo stupore generale, cominciò a criticare il regime, invocando una maggiore libertà d’opinione, denunciando la deriva burocratica e condannando il sistema a partito unico.
Gilas cadde ben presto in disgrazia. Non solo perse ogni carica politica, ma venne arrestato e condannato per deviazionismo. Nel 1957 pubblicò all’estero il suo capolavoro, La nuova classe (edita in Italia dalla casa editrice Il Mulino), che gli costò altri due anni di carcere. Nel 1966 venne scarcerato definitivamente con il permesso di continuare la sua attività di scrittore, ma col divieto di pubblicare in patria le sue opere. Gilas è stato forse l’unico alto dirigente nella storia del comunismo che abbia conquistato ed esercitato il potere, e l’abbia poi volontariamente rifiutato. Sono casi più unici che rari anche nelle nostre “democrazie”.
LA PROPRIETÀ PUBBLICA NON ESISTE
La nuova classe di Milovan Gilas è stato giudicato dal New York Times uno dei cento libri più influenti del ventesimo secolo. L’aspetto rilevante del libro è la descrizione del comunismo come dominio di classe. Applicando una sorta di “teoria liberale della lotta di classe”, Gilas considera il collettivismo statalista come una forma di sfruttamento parassitario della classe politico-burocratica ai danni delle classi produttive.
Tutte le rivoluzioni comuniste, appena giungono al potere, operano una profonda modificazione dei rapporti di proprietà, sopprimendo la proprietà privata a vantaggio di quella collettiva. Il potere della “nuova classe” burocratica si fonda sulla gestione e amministrazione di questa proprietà statale. «L’apparizione improvvisa di una nuova classe – spiega Gilas – è stata celata sotto la fraseologia socialista, e, ciò che è più importante, sotto le nuove forme collettive di possesso di proprietà. La cosiddetta proprietà socialista è un travestimento della proprietà reale da parte della burocrazia politica» (p. 56).
Il problema fondamentale è che il concetto di proprietà pubblica (o socialista) nasconde un imbroglio semantico, dato che “pubblico” e “collettivo” sono concetti astratti, o metafore. Solo gli individui vivono, pensano, agiscono, possiedono e hanno bisogni. Dato che in ultima analisi sono sempre gli individui singoli ad appropriarsi di qualcosa, nella realtà la proprietà pubblica non esiste: tutta la proprietà è sempre e solo privata. Aldilà delle denominazioni formali, proprietario di un bene è colui che decide sui modi di utilizzazione di un bene e che gode dei suoi frutti. I beni in “proprietà pubblica” sono allora, di fatto, in proprietà privata della classe politico-burocratica, che decide come usarli e che si appropria dei benefici della loro amministrazione sotto forma di stipendi, poltrone, prebende.
Nei regimi socialisti il popolo non era “proprietario di tutto” come diceva la propaganda, ma proprietario di niente: i veri proprietari delle ricchezze del paese erano i membri della nomenklatura. Secondo la definizione giuridica romana, ricorda Gilas, la proprietà costituisce l’uso, il godimento e la disponibilità dei beni materiali. Ebbene, la burocrazia politica comunista usa, gode e dispone della proprietà nazionalizzata, e quindi né è la reale proprietaria: «questo è quanto appare all’uomo comune, il quale considera il funzionario comunista molto ricco e come individuo che non ha bisogno di lavorare».
 Gilas osserva anche che la proprietà privata ostacola il potere burocratico: «La proprietà privata, per molte ragioni, si è dimostrata poco propizia all’instaurazione dell’autorità della nuova classe, [che] ottiene il suo potere, i suoi privilegi, la sua forza ideologica e le sue abitudini da una forma particolare di proprietà – quella collettiva – che la classe amministra e distribuisce in nome della nazione e della società» (p. 53)
Gilas osserva anche che la proprietà privata ostacola il potere burocratico: «La proprietà privata, per molte ragioni, si è dimostrata poco propizia all’instaurazione dell’autorità della nuova classe, [che] ottiene il suo potere, i suoi privilegi, la sua forza ideologica e le sue abitudini da una forma particolare di proprietà – quella collettiva – che la classe amministra e distribuisce in nome della nazione e della società» (p. 53)
L’analisi di Gilas è perfettamente applicabile anche ai nostri sistemi a economia mista. Il fatto che nessuno possa vendere la propria “quota” delle ferrovie statali, delle aziende sanitarie o della scuola pubblica, né decidere come usarla, dimostra che in verità il cittadino è un proprietario nominale, con il solo dovere di pagare i debiti di gestione accumulati dai membri della classe politico-burocratica, che sono i reali proprietari della cosa pubblica.
UNA TEORIA LIBERALE DELLA LOTTA DI CLASSE
La proprietà collettiva serve dunque a fornire un’indispensabile base materiale alla nuova classe burocratica salita al potere. Si spiegano così le guerre sanguinose che i regimi comunisti hanno sempre scatenato contro i contadini, i quali nei paesi non industrializzati costituiscono la stragrande maggioranza dei ceti produttivi. L’obiettivo della “collettivizzazione” era quello di sottrarre la proprietà delle ricchezze ai produttori e ai legittimi proprietari, per trasferirla alla “nuova classe” parassitaria dei rivoluzionari di professione.
La presenza dello stato genera sempre una divisione di classe tra coloro che beneficiano delle risorse “pubbliche” (i consumatori di tasse, cioè la classe politico-burocratica e le loro clientele) e coloro che sono chiamati a saldare il conto (i pagatori di tasse, cioè i lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato). Sotto questo punto di vista la differenza tra il comunismo orientale e la socialdemocrazia occidentale è solo di quantità, perché là era più esteso il settore statale dell’economia.
L’economia gestita collettivamente dalla burocrazia conduce però inevitabilmente a uno «spreco di fantastiche proporzioni», anche perché la proprietà “di tutti” sembra non appartenere a nessuno. «I capi comunisti trattano la proprietà nazionale come propria, ma nello stesso tempo la sperperano come se fosse di altri». Lo spreco maggiore, però, è quello del potenziale umano: «L’opera lenta, improduttiva di milioni di persone prive di interesse, insieme con la prevenzione e l’impedimento di ogni lavoro non considerato “socialista”, rappresenta lo sperpero incalcolabile, invisibile e gigantesco che nessun regime comunista ha mai potuto impedire» (p. 134). Nonostante l’economia pianificata sia forse «l’economia più rovinosa nella storia della società umana», la nuova classe non può rinunciarvi senza minare se stessa, perché «spogliare i comunisti dei loro diritti di proprietà equivarrebbe ad abolirli come classe».
Anche queste parole di Gilas si adattano perfettamente alla descrizione dei nostri attuali sistemi, con la cronica inefficienza del settore statale, gli sprechi di denaro pubblico e gli ostacoli burocratici e fiscali alla libertà d’impresa. Ma soprattutto spiegano perché le classi politiche dei paesi occidentali sono tanto restie a privatizzare o liberalizzare, e tanto disponibili a estendere l’area pubblica a danno di quella privata. La gestione dei beni e del denaro pubblico è infatti la fonte di ogni loro privilegio e potere.
ANCHE LE SOCIALDEMOCRAZIE OCCIDENTALI DESTINATE A CROLLARE
Gilas osserva poi che la burocrazia comunista trae vantaggio dalla statalizzazione dell’economia anche quando provoca il crollo della produzione e il caos economico generale. Un tipico caso fu la collettivizzazione dell’agricoltura in Unione Sovietica, totalmente ingiustificata dal punto di vista economico, ma politicamente indispensabile perché la nuova classe doveva insediarsi con tutta sicurezza nel suo potere e nei suoi possessi. «Si possono calcolare le perdite delle produzioni agricole e dell’allevamento, ma le perdite di manodopera, dei milioni di contadini gettati nei campi di lavoro forzato, sono incalcolabili. La collettivizzazione – osserva Gilas – fu una guerra spaventosa e devastatrice che somigliò a una folle impresa, se si esclude il profitto che ne trasse la nuova classe assicurandosi l’autorità» (p. 66-67).
È proprio quello che osserviamo oggi nelle crisi dei “debiti sovrani” che assillano tanti paesi europei, compresa l’Italia. Queste crisi hanno tutte una sola origine: l’eccessiva pressione esercitata dai tax−consumers sui tax−payers. In altre parole, la struttura produttiva di molti paesi in crisi non è in grado di sopportare il livello di spesa pubblica stabilito dai governi.
In nessun paese, però, le categorie che traggono profitto dall’intervento dello stato sono disposte a ridurre la spesa pubblica e la tassazione. In Grecia come in Italia queste classi parassitarie, proprio come le ex nomenklature comuniste, preferiscono di gran lunga il default dello stato, l’aggravamento della crisi economica o i suicidi degli imprenditori rovinati all’ipotesi di allentare la presa sui ceti produttivi.
È chiaro, tuttavia, che i nostri attuali sistemi politici, basati sull’espansione all’infinito della spesa pubblica, della tassazione e dell’indebitamento statale sono insostenibili, e non possono reggere nel tempo. Probabilmente non sono neanche riformabili dall’interno. La loro fine sarà, verosimilmente, la stessa che Gilas aveva predetto per i sistemi comunisti, a meno che non intervenga un fattore dirompente esterno al sistema, come una rivolta fiscale di massa o una separazione di alcune parti del territorio.
In collaborazione con www.libreriadelponte.com